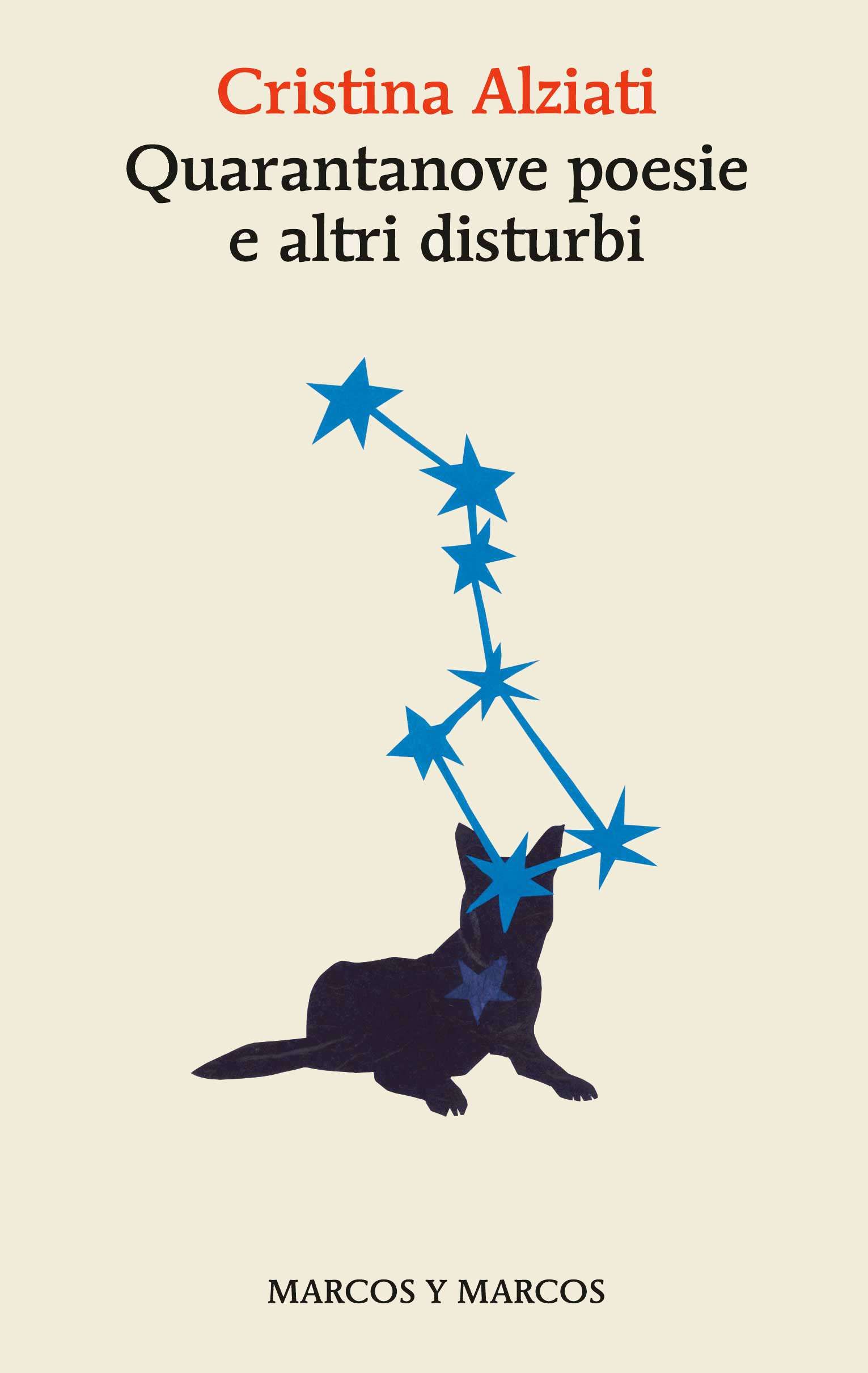
“Le guerre oltre la guerra”. Sui nuovi versi di Cristina Alziati
Guarda la stirpe- aggiunge l’impostore – Le guerre oltre la guerra. (La stirpe, p. 70)
Cristina Alziati dopo undici anni ha dato alle stampe un nuovo libro di versi: Quarantanove poesie e altri disturbi (Marcos y Marcos, 2023). Si tratta di una pubblicazione molto attesa dai pochi che sanno come si tratti della voce poetica che più di tutte ha saputo ereditare la dura lezione di Franco Fortini, inaccessibile ai più. I testi di Alziati infatti custodiscono gli strumenti stilistici e formali per captare il rumore giornaliero dei macelli del mondo: hanno preso avvio nel 1991 dallo spartiacque della Guerra del Golfo, l’aggressione all’Iraq da parte delle potenze occidentali, mascherata dai media e fondatrice di tutte le altre nuove guerre dell’ordine-disordine globale, e rendono dicibili, con asciutta tensione e torsione sintattica, le carneficine dell’inferno contemporaneo: Mostar, Baghdad, Gaza. In questo nuovo libro, come “disturbi dell’udito” (p. 58) ascoltiamo ancora le voci dei trapassati: da Rosa Luxemburg a Edoarda Masi (Dall’altra parte, p. 30).
Qualcosa tuttavia è cambiato. Nelle due precedenti raccolte, A compimento (Manni, 2005) e Come non piangenti (Marcos y Marcos, 2011), la sfida della poesia come resistenza all’orrore storico trovava nei dettagli della natura le proprie tenaci allegorie. Accogliendo il magistero di Bertolt Brecht, era possibile narrare in versi la parabola di un padre e di un figlio che stendono un telo sull’albicocco che gela mentre Hitler prepara la guerra (Primavera 1938).
Nella nuova raccolta sembra che questa possibilità sia negata: fra la natura (il bombo, l’airone, il lichene) e l’uomo (gli “elegantissimi” che ammazzano il piccione in cerca di briciole nel panificio), prevalgono la distanza, il silenzio, l’inaccessibilità, l’estinzione. Tra i barlumi di speranza sembra sopravvivere solo il dialogo tra figlia e madre: figura di esile protezione e di prosecuzione oltre la fine biologica. Le ragioni di questo cambiamento sono esplicite nella poesia La tela (p. 41) che allude a Brecht, chiamato “il mio poeta”:
Il mio poeta in esilio, una volta con la tela di un sacco dal gelo un giovane albicocco proteggeva. Anche qui, in fondo alla scarpata ce n’è uno, e a febbraio io attendo il biancore dei fiori tralucere tra i rami. Ma intorno da diecimila mesi l’argilla è spaccata dall’arsura il Circolo polare artico rovescia negli oceani acque annerite il colore del cielo è colore di pioggia che non piove. Così custodisco soltanto un ricordo a febbraio, di un alberello e un gesto. Con quale tela mai proteggerò l’argilla, il Circolo polare, il cielo?
Come Fortini alla fine degli anni Cinquanta (Traducendo Brecht) oggi Cristina Alziati collauda i propri versi misurando la vicinanza e la distanza dal poeta tedesco: facendosi carico di tutte le implicazioni poetiche e politiche della mutazione e della distruzione (storica e ecologica). Dopo una verifica di questa portata, i margini che i versi concedono alla “speranza di una città futura” risultano ulteriormente assottigliati. Se “La poesia/ non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi” è il verso più memorabile di Traducendo Brecht, Quarantanove poesie e altri disturbi si apre con una negazione: “Infatti non scrivo./Ripeto soltanto che il dolore/ è reale e passato. La storia è ciò che ho raccontato/ di poco peggiore il presente/ e non ne voglio dire (Risposta, p. 13). All’ombra “fissata un mattino d’agosto” dall’esplosione nucleare su Hiroshima (L’ombra, p. 72) e alle esplosioni dell’“ossido di etilene” occidentale fra il Tigri e l’Eufrate (1991, p. 21) si aggiunge ora la certezza che “nemmeno il lichene/ verrà risparmiato” (D’Europa, p. 35). Eppure a questa certezza folgorante e desolata non corrisponde nessun disincanto, nessun cedimento cinico o nichilista: di guerra in guerra, di menzogna in menzogna la “piccola porta” è migrata dalle figure di natura alle immagini di figli, “che resteranno”. La sezione centrale, dal titolo Exclave, è abitata dal “lascito”, il dialogo con la figlia Sofia a cui il libro è dedicato: una forma di vera persistenza e di “amore” (Il messaggio, p. 66). Analoga funzione, sul piano collettivo, rivestono il “minuscolo circo di artisti ragazzini” e la bambina afgana che piange sorridendo in Una bambina (p. 37). In tal modo, l’intimità che si avverte in tutto il libro con le figure di dissoluzione sembra nascere ancora una volta dalla consapevolezza di un esproprio subìto collettivamente: dalla certezza che l’inferno dei viventi non era il nostro destino inevitabile o immodificabile. Come ha potuto scrivere Massimo Raffaeli con Mark Fischer, in questa raccolta insomma “storia diventa il deserto” perché oggi, privati delle nostre parole, siamo ridotti a poter “immaginare la fine del mondo ma non la fine del capitalismo” (in “Il manifesto”, 4 aprile 2023). In A compimento, Cristina Alziati scriveva così:
Quello che dite odio per voi, dei lavoratori, è voce di un interesse non vostro che il vostro contraddice. Non è odio il lavoro. Lo sapete. Voi per negare questa verità vera puntualmente ordinate il terrore. (Ai padroni)
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento