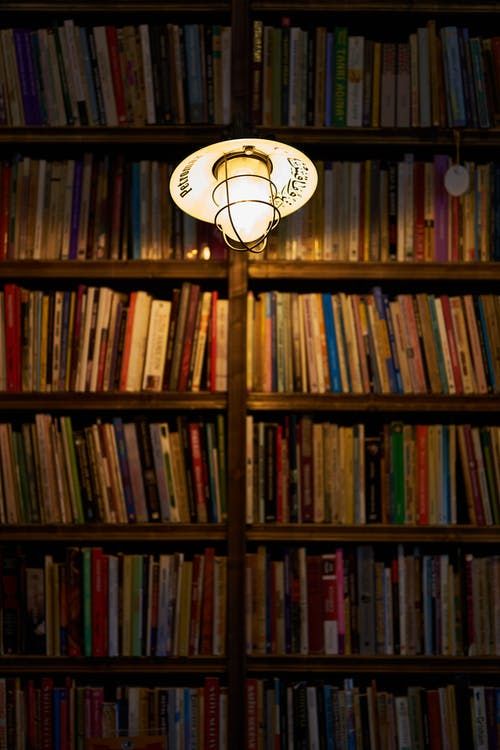
Equo canone. Ovvero del canone letterario a scuola/6 Tre domande a Francesca Fedi
A cura di Luisa Mirone
Rispetto all’insegnamento della letteratura italiana, le Linee guida nazionali per gli istituti tecnici e professionali e le Indicazioni nazionali per i Licei, pur nella diversificazione dei curricula, sono a tutt’oggi storicamente orientate. Dentro questo percorso storicoletterario, vengono privilegiati, talvolta in modo rigorosamente prescrittivo, alcuni autori, tradizionalmente presenti nel canone, rispetto ai quali, nei tempi contingentati dell’insegnamento scolastico, le aperture al Novecento o all’estremo contemporaneo assumono i connotati sfumati di suggerimenti o sollecitazioni. I docenti e le docenti di letteratura italiana si trovano pertanto oggi nelle stesse difficoltà di coloro che ebbero insegnanti quand’erano fra i banchi; né è bastata a risolverle (semmai le ha amplificate) la “riforma” che ha imposto l’anticipazione della trattazione della cosiddetta letteratura delle origini al secondo anno del biennio. Abbiamo chiesto pertanto a studiosi e studiose vicini e vicine al mondo della scuola di rispondere a tre domande-chiave per provare a ridefinire non tanto i confini, quanto i parametri del canone scolastico. Pubblicheremo periodicamente le loro risposte. Sono già uscite quelle di Silvia Tatti, di Riccardo Castellana, di Giancarlo Alfano, di Massimiliano Tortora e Duccio Tongiorgi.
D1: Ha scritto Cesare Segre (Critica e critici, Torino, 2012): «la filologia è proprio lo sforzo di capire; e la continuità geografica e storica ci fornisce strumenti abbastanza efficienti per seguire gli sviluppi del modo di significare ed esprimersi delle manifestazioni artistiche».
Ritiene che la storia della letteratura sia ancora oggi, a scuola, uno strumento valido per l’approccio ai testi, uno strumento ancora capace di coniugare insieme appartenenza e scarto, contiguità e distanza, identità e alterità?
R1: Quasi trent’anni di esperienza didattica – nella scuola superiore (un Liceo Scientifico), in un ateneo estero e poi nell’università italiana, con studenti principianti e avanzati, madrelingua e non – mi hanno convinto della necessità di dare il peso adeguato ad un approccio che tenga conto delle coordinate storiche e geografiche. Ci tengo a specificare “storiche e geografiche” perché continuo a ritenere imprescindibile, per le ragioni ancora valide esposte da Dionisotti molti anni fa, affrontare lo studio degli autori riconducendoli al loro contesto geo-culturale oltre che storico: per mettere a fuoco di ogni opera letteraria la “ragione poetica” (per usare un sintagma graviniano-foscoliano che disegna una categoria assai utile). Mi sembra infatti che solo ricostruendo criticamente i motivi profondi che hanno spinto un autore a scrivere – scegliendo un argomento, un genere, una lingua, un registro ecc. – sia credibile lo sforzo di proporre la lettura della sua opera/delle sue opere alla nostra platea studentesca. Raramente o mai, infatti, questi “motivi profondi” – l’urgenza di scrivere e il desiderio di essere letto – sono svincolati dal contesto storico e geo-culturale cui ho accennato prima.
A queste considerazioni generali e, per così dire, “di principio” si affianca una sorta di valutazione statistica. Negli anni in cui, rispondendo magari ai suggerimenti e ai moniti di colleghi più esperti e disincantati (o sedicenti tali), ho “alleggerito” i programmi di studio dei miei corsi di laurea Triennale, rinunciando a pretendere un inquadramento geo-storico di autori, opere, correnti, la risposta degli studenti è stata più fiacca e il livello della preparazione si è abbassato. Per contro, da quando due anni fa – insieme all’amica e collega che condivide con me il corso – ho ricominciato a imporre lo studio del “manuale” anche alle nostre matricole di Lingue, i risultati sono stati confortanti: i testi sono stati compresi meglio e oserei dire (ma sono sempre ottimista) anche apprezzati di più.
Naturalmente non è semplice individuare, di volta in volta, gli argomenti di storia letteraria da proporre; e una selezione – anche e tanto più a livello universitario – sembra inevitabile. Non sempre i libri di testo, anche recenti e frutto di riflessioni acute e di sforzi sinceri, forniscono soluzioni risolutive. Come nella scuola secondaria, anche all’università tocca poi sempre, in ultima analisi, al docente compiere delle scelte, delle quali ritengo personalmente che sia poi opportuno dare sempre conto agli studenti.
Quanto all’urgenza di «coniugare insieme appartenenza e scarto, contiguità e distanza, identità e alterità»: si tratta di un nodo essenziale, e da affrontare, a mio parere, proprio puntando sulla storicizzazione. Senza la quale – come mi è capitato spesso di ripetere, in privato e in pubblico – si rischia di perpetrare una frode a danno dei nostri studenti, appiattendo ogni prospettiva in un presente privo di sfumature, dove può sopravvivere solo quello che è immediatamente comprensibile perché uguale o molto simile a quel che già si conosce; e dove, per diretta conseguenza, diventa poco interessante o troppo faticoso confrontarsi con quel che è nuovo e diverso, e tanto più progettarlo.
D2: Secondo Remo Ceserani «Il nostro compito critico e storiografico prioritario è proprio la ricognizione e la ricostruzione dei sistemi tematici e formali, nella consapevolezza che è proprio nella diversa costituzione di quei sistemi che l’immaginario rivela la sua capacità di raccordo con i movimenti profondi della società, le sue strutture economico-sociali, materiali, culturali, linguistici» (Guida breve allo studio della letteratura, Bari-Roma, 2003).
Esaurita da tempo la funzione delle narrazioni storicoletterarie sul modello desanctisiano, è possibile, a suo avviso, proporre agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di percorrere la letteratura attraverso itinerari tracciati dai grandi temi e dai generi? E, eventualmente, quali temi indicherebbe?
R2: Questa seconda domanda mi sembra ancora più delicata della prima… ma proverò a rispondere considerando le due in stretta contiguità tra loro. Preservando sempre l’impianto geo-storico dell’approccio, trovare un “punto di accesso” tematico, o di genere (inteso come genere letterario), allo studio della letteratura può essere sicuramente proficuo. Parentesi: mi permetto di usare la metafora del “punto di accesso” – che mutuo dall’uso che ne ho sentito fare agli amici dell’ADI-SD – perché mi sembra funzionale a chiarire il tipo di sforzo che noi docenti di Letteratura Italiana, a tutti i livelli (giacché tra gli studenti delle IV e V superiori e le matricole che seguono i miei corsi non è realistico parlare di livelli davvero diversi), dobbiamo fare per portarci dietro, in piccioletta barca, un pubblico spesso poco attrezzato e non solo poco motivato, ma difficilmente motivabile.
Dunque, ben vengano i percorsi tematici, che mi sembra abbiano il pregio di incuriosire e di mobilitare la memoria e la fantasia “associativa” dei nostri ascoltatori. La condizione preliminare è restare ancorati (e richiamare costantemente i nostri allievi) a una premessa metodologica: la cosiddetta “critica tematica” non può risolversi in un inventario di occorrenze. Non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di sottolinearlo, mi rendo conto. Eppure ho in mente, come tutti noi credo, esempi aberranti di esercizi di questo tipo, proposti anche in sede “scientifica” (convegni, seminari) da colleghi comprensibilmente entusiasti (qualche anno fa) delle magnifiche sorti spalancate agli aspiranti tematologi dalle risorse elettroniche. Detto più seriamente (ma con un po’ di leggerezza, perché mi sembra un’affermazione scontata): l’approccio tematico ha senso se punta a illuminare i motivi della fortuna di un tema (un motivo, una figura, un luogo comune) a ricostruirne la circolazione e i momenti di particolare visibilità, a situarlo in un dibattito complessivo.
La richiesta di proporre dei temi mi mette in imbarazzo, perché ovviamente la tentazione è quella di attingere alla mia esperienza, cui non è certo il caso di attribuire valenze esemplari. La “forma intervista”, d’altro canto, implica il privilegio di poter/dover parlare di sé… Citerò quindi due esempi di percorsi che ho proposto in anni recenti, e che mi sembra abbiano funzionato: il tema del suicidio e il motivo dell’ingratitudine (il quale ultimo coincide con uno dei miei interessi di ricerca). Menziono entrambi i percorsi perché giocoforza sono stati gestiti in modo diverso. Il tema del suicidio può essere ovviamente affrontato partendo da premesse molto remote, seguendone gli sviluppi dalla tradizione classica a quella medioevale e moderna, mettendo in rilievo la persistenza e la produttività di alcuni paradigmi (Catone Uticense è forse l’esempio più trito), la diversa declinazione in vari generi e forme, le discontinuità legate all’affermarsi, nel tempo, d’impostazioni filosofiche diverse (dallo stoicismo al libertinismo, fino al nichilismo moderno). Si tratta insomma, di un arci-tema, che offre molte possibilità didattiche d’interazione con altre tradizioni letterarie (antiche e moderne) e altre discipline (storia dell’arte, della filosofia e del diritto); e presenta d’altronde il rischio vitando – al quale già accennavo – di smarrirsi nella selva delle occorrenze perdendo di vista le “linee di scorrimento”, gli effettivi nessi tra “quel che viene prima e quel che viene dopo”. Il percorso incentrato sull’ingratitudine, all’inverso, va gestito concentrando l’attenzione su alcune (tutto sommato poche) fasi della storia culturale e letteraria, nelle quali questo motivo ‘improvvisamente’, ma non immotivatamente, diventa o ridiventa pervasivo. Certo, nella tradizione letteraria ‘universale’ la figura dell’ingrato (e traditore, e ribelle, e beffatore… chi restituisce, insomma, pro bono malum) è pervasiva: da Giuda Iscariota a Pinocchio, tanto per dirne due. Ma ci sono momenti – e io ho ragionato (e proposto didatticamente di riflettere) sul primo Cinquecento – in cui la ridefinizione del sistema politico-culturale, che investe e scuote la coscienza dei letterati, riporta alla ribalta il tema sempre ambiguo del rapporto di necessità beneficio-premio: quindi anche il problema dell’ingratitudine, colpa oggetto di accuse incrociate e reversibili, come insegna la lettura del Furioso o delle opere machiavelliane.
Una piccola coda sull’opportunità (evocata nella domanda) di «percorrere la letteratura attraverso itinerari tracciati» oltre che dai grandi temi, «dai generi». Si tratta di una soluzione senz’altro apprezzabile, e per lo più (lo dico ancora una volta empiricamente) fruttuosa. A me è capitato spesso, per esempio, di proporre ai miei studenti dei corsi di Laurea Triennale una riflessione diacronica sui testi riconducibili al genere epico. Ancora più spesso – vorrei aggiungere – ho sperimentato con risultati soddisfacenti un’ulteriore soluzione, che penso possa essere applicata tal quale anche alla didattica rivolta agli studenti di Scuola Superiore: la via non dei generi, ma dei “modi” letterari, o dei “registri”. Un buon riscontro, per esempio, ha avuto il tentativo di seguire il filo conduttore dell’ironia; perché mi ha dato l’occasione di portare l’attenzione, più in generale, sul meccanismo del distanziamento ironico; e quindi di presentare alcuni testi nei quali, in momenti storici diversi, autori diversi hanno affidato all’ironia (o al paradosso: un altro degli argomenti che mi sono particolarmente cari) l’energia critica del loro discorso. È un punto, questo, che mi sta particolarmente a cuore; perché sono persuasa che il “corpo a corpo” coi testi letterari che sono l’oggetto del nostro insegnamento sia un’ottima occasione per allenarsi a distinguere “le parole e le cose” e per esercitare un senso critico la cui fiacchezza è – credo – uno dei nodi problematici del nostro sistema formativo.
D3: Nel corso di un importante seminario nazionale di formazione (COMPITA, Tivoli, 2015) cui prendevano parte docenti di circa cinquanta scuole secondarie d’Italia, Romano Luperini, invitato, con altri notissimi studiosi, a esprimersi sul canone scolastico, lanciò ai gruppi di lavoro una sfida: individuare dieci autori (e dieci opere) imprescindibili della letteratura italiana che potessero costituire una sorta di canone essenziale ed esemplare. Non si trattava di salvare il salvabile, ma di individuare quali voci – tra quelle già consegnate alla tradizione nazionale – fossero ritenute capaci di dialogare con l’Europa, di rappresentare l’Italia entro una più ampia (e oggi più che mai necessaria) dimensione europea. Fu una prova molto difficile, e non se ne venne a capo.
Le proponiamo la stessa sfida, ampliando la rosa a quindici nomi e motivando le sue scelte.
R3: La tentazione, a questo punto, è di cogliere l’opportunità insita nel finale della domanda, e dichiararmi vinta in principio. Ma dopo lunghi contorcimenti, pur di non lasciare il tavolo, ho deciso di alzare la posta, ben sapendo che si tratta di una scorrettezza passibile di espulsione.
Ai 15 autori/testi che ho scelto nell’ambito del canone esteso dal Due all’Ottocento (con un minimo sconfinamento nel secolo XX), provo ad affiancarne altrettanti novecenteschi, motivando minimamente la logica di questi accoppiamenti. Che spero risultino in qualche modo giudiziosi, e magari spendibili didatticamente; ma restano certo assai soggettivi, nella misura in cui chiamano in causa opere che particolarmente amo e che mi paiono – in qualche caso – ‘necessarie’.
L’elenco, per ovvi motivi, segue un ordine storico-cronologico solo nella ‘colonna 1’.
- Dante per la Commedia, la prima opera-mondo della tradizione letteraria in volgare italiano. – 1 bis) Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, raccolta che anche già nel titolo esibisce la vitalità della lezione dantesca nella lirica del pieno Novecento.
- Petrarca, come punto di riferimento della lirica moderna con l’impresa dei Rerum vulgarium fragmenta. – 2 bis) Umberto Saba, Canzoniere, testimonianza di un debito impossibile da saldare, ma anche da cancellare.
- Boccaccio per la codificazione della novella attraverso il Decameron. – 3 bis) Luigi Pirandello, Novelle per un anno, nel mio parzialissimo giudizio la più bella raccolta novellistica del Novecento.
- L’Ariosto dell’Orlando Furioso, autentica bibbia dell’immaginario poetico-romanzesco. – 4 bis) Italo Calvino per la trilogia de I nostri antenati (e qui forse è superfluo profondersi in spiegazioni).
- Machiavelli per il De principatibus, attraverso il quale è possibile anche spiegare lo snodo storico-culturale del primo Cinquecento e la stagione decisiva delle guerre d’Italia. – 5 bis) Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, fulminante pendant novecentesco del tentativo (fallito quanto quello machiavelliano) di analizzare la propria sconfitta guardando in avanti.
- Galileo come fondatore della prosa scientifica moderna, soprattutto attraverso il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. – 6 bis) Primo Levi, Il sistema periodico, per come racconta la vita e la morte attraverso il prisma della scienza e del suo linguaggio.
- In omaggio alla vocazione teatrale del mio secolo prediletto, proporrei uno dei capolavori goldoniani, forse La locandiera. – 7 bis) Eduardo De Filippo. Anche qui sono incerta: ma per accostare a Mirandolina un personaggio femminile altrettanto potente si potrebbe optare per Filomena Marturano.
- una tragedia di Alfieri, magari Antigone, che segna la vera svolta in direzione della riduzione dei personaggi e della disarticolazione dell’endecasillabo. – 8 bis) Il racconto del Vajont, caposaldo del teatro tragico civile di Marco Paolini.
- Il mattino di Giuseppe Parini, per l’energia satirica e la genialità delle scelte linguistico-stilistiche. – 9 bis) Dario Fo, Mistero buffo: esattamente per gli stessi motivi, con due secoli di stacco.
- di Foscolo privilegerei Le ultime lettere di Jacopo Ortis che, con buona pace di Manzoni, sono il primo romanzo italiano moderno e si prestano oltretutto straordinariamente bene a spiegare il ventennio cruciale tra il Triennio democratico e la Restaurazione. – 10 bis) Emilio Lussu, Marcia su Roma e dintorni: anche in questo caso per illustrare un nodo della storia italiana, ricostruito alla luce della sconfitta e dell’esilio.
- Includo Leopardi soprattutto in quanto autore dei Canti e responsabile di quella ‘dissoluzione dei generi lirici’ dalla quale non si sarebbe mai più tornati indietro. – 11 bis) Per un corrispondente valore modellizzante assunto nel Novecento collocherei qui La bufera di Montale.
- Non possono restar fuori I promessi sposi. Ma per una sorta di contrappasso per opposizione accosterei al più celebre romanzo italiano l’opera di Svevo (proponendo almeno La coscienza di Zeno), narratore rivolto alla narrativa europea molto più che alla tradizione italiana.
- Carlo Dossi, Vita di Alberto Pisani, uno dei capolavori della linea sterniana rimasta marginale nel nostro Ottocento. – 13 bis) quasi inevitabile, in questo caso, l’aggancio con la narrativa di Gadda, dando la priorità forse al Pasticciaccio (leggermente meno ostico – didatticamente parlando – della Cognizione), o anche ai racconti dell’Adalgisa.
- Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo: al quale accosterei Il Piacere dannunziano, l’unico testo non ancora novecentesco della ‘colonna bis’, e anzi cronologicamente saldato al Mastro dalla comune data di pubblicazione; ma così profondamente diverso, e proiettato verso il secolo successivo, da consentire anche didatticamente una proficua lettura in parallelo.
- Chiuderei, come avevo annunciato, sconfinando nel Novecento, con il Pascoli del 1903, la data dell’ultima edizione di Myricae e della prima dei Canti di Castelvecchio. – 15 bis) e qui, forse troppo prevedibilmente (ma se di canone si parla, quanto è lecito ‘scartare’?), lascerei l’ultimo seggio a Gozzano, non solo per un affondo nella sua interpretazione della ‘poesia delle piccole cose’, ma come esempio di sperimentalismo metrico e pretesto per un excursus sul dialogo con la lirica dannunziana.
Articoli correlati
- Equo canone. Ovvero del canone letterario a scuola/3 Tre domande a Giancarlo Alfano
- Equo canone. Ovvero del canone letterario a scuola/5 Tre domande a Duccio Tongiorgi
- Verificare il canone tra i banchi di scuola
- Equo canone. Ovvero del canone letterario a scuola/2 Tre domande a Riccardo Castellana
- Equo canone. Ovvero del canone letterario a scuola/4 Tre domande a Massimiliano Tortora
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento