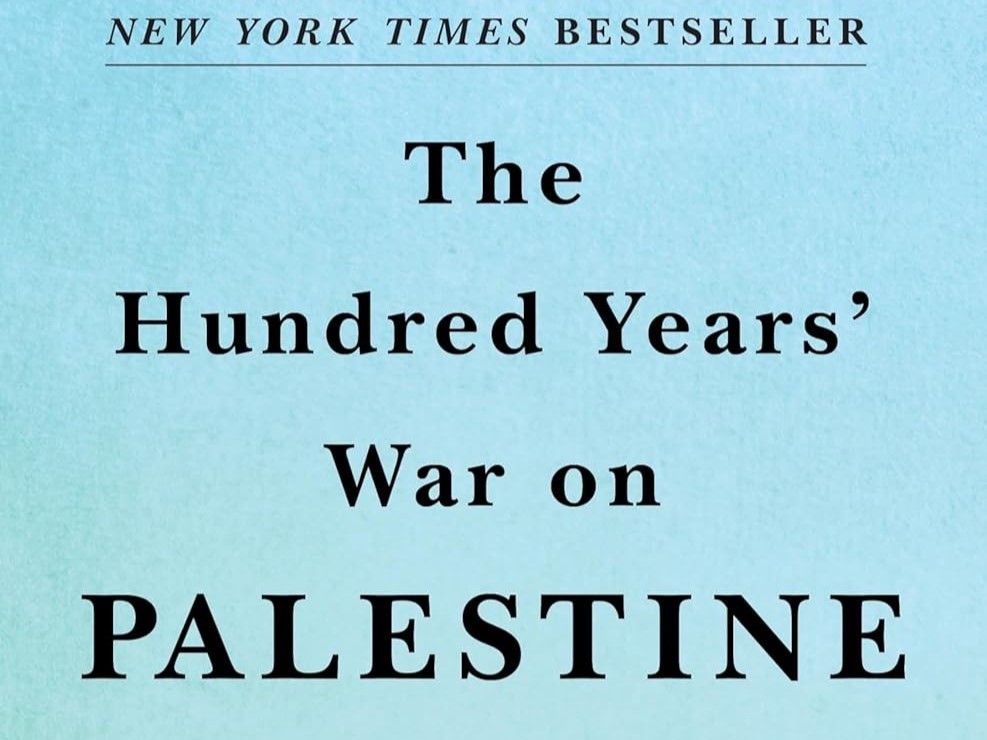
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
[Questo articolo è uscito sul numero 7, luglio-agosto 2024, dell’Indice dei libri del mese, pp. 3-4.]
La strage compiuta da Hamas il 7 ottobre scorso in Israele e quella iniziata pochi giorni dopo ad opera dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza hanno colto l’editoria italiana tutto sommato meno impreparata della politica e dei mass media, tuttora cronicamente riluttanti a dar conto della profondità storica di quanto va in onda quotidianamente sotto gli occhi del mondo. Il lettore ha infatti a disposizione da tempo libri ben documentati e argomentati, tra cui si segnalano quelli dello storico israeliano emigrato nel Regno Unito Ilan Pappé, dalla Storia della Palestina moderna ai più specifici La pulizia etnica della Palestina e La prigione più grande del mondo (v. in fondo l’elenco dei libri citati). Tuttavia, se si eccettuano i contributi di Edward Said, da La questione palestinese a La pace possibile, colpisce l’assenza di voci palestinesi in un dibattito che, in occidente, è ancora pesantemente distorto dall’«orientalismo» messo in luce dallo stesso Said: «Non possono rappresentare se stessi; devono essere rappresentati», recitava significativamente la frase di Marx posta in esergo all’ormai classico Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente. Gli storici di parte araba in realtà sono molti, da Aref al-Aref, il primo a ricostruire estensivamente la Nakba, a Fayez Sayigh, Emil Touma, Beshara Doumani, fino a Maher Charif, l’unico tradotto in italiano. L’esponente forse più prestigioso di questa storiografia è oggi Rashid Khalidi, discendente di una famiglia di notabili di Gerusalemme e ‘Edward Said Professor’ di Modern Arab Studies alla Columbia University di New York. I suoi numerosi libri sono da anni un punto di riferimento stabile nel dibattito anglo-sassone. L’ultimo, The Hundred Years’ War on Palestine, uscito nel 2020, è già apparso in diverse lingue, e l’editore che lo pubblicasse in Italia si si renderebbe meritorio, perché, oltre a chiamare sistematicamente a confronto le fonti più usualmente compulsate, quelle israeliane ed euroamericane, con le assai più trascurate fonti arabe, interrogando anche preziosi archivi privati, adotta un quadro interpretativo molto innovativo, inquadrando la questione israelo-palestinese nel nuovo filone della storia globale che indaga il cosiddetto «colonialismo d’insediamento».
Gli studi sul settler colonialism hanno avuto un impulso decisivo alla fine degli anni ’90 in Australia con storici come Patrick Wolfe e Lorenzo Veracini, interessati in primo luogo alla colonizzazione britannica e allo sterminio degli aborigeni, ma le ricerche si sono rapidamente ampliate a tutto il mondo. I casi da manuale, come tali inclusi nel Routledge Handbook of the History of Settler Colonialism, sono l’Irlanda, gli Stati Uniti, il Canada, l’America latina, l’Africa (inclusa l’Etiopia colonizzata dagli italiani), l’Oceania, la Siberia, l’Hokkaido e, appunto, la Palestina. Secondo Khalidi – ma la prospettiva è ormai condivisa da molti, tra cui gli stessi Veracini e Pappé – la nascita di Israele risponde non solo a una logica nazionalista, mirante cioè all’indipendenza della nazione ebraica e alla sua difesa dalle persecuzioni subite per secoli, ma anche, inscindibilmente, a una logica coloniale: nato al culmine dell’età dell’imperialismo, mentre gli stati europei si spartivano l’Africa, il sionismo si è ideologicamente costituito e ha praticamente agito come altre forme di colonialismo d’insediamento, perseguendo un progetto di eliminazione e sostituzione dei nativi. Per occupare le terre su cui rivendicano il loro diritto, i coloni devono infatti necessariamente ingaggiare una guerra contro la popolazione che le abita, e avviare un processo di «ingegneria sociale» per trasformare, come Khalidi rileva nel caso della Palestina, «gran parte di un paese a maggioranza araba in uno stato a maggioranza ebraica».
Una strategia ricorrente, perché necessaria, del colonialismo d’insediamento è quella di negare in prima istanza la presenza stessa di una popolazione nativa, e successivamente di negarne il diritto alla terra sulla base di argomentazioni razziste, culturali o politiche: Khalidi rimanda alla vasta pubblicistica di propaganda, vitale ancora oggi, che dipinge la Palestina come un «un paese abitato da una piccola popolazione di beduini nomadi e senza radici, privi di un’identità fissa e di un legame con la terra». Ricorrente è, anche, l’uso della violenza, per soggiogare i nativi, espellerli o eliminarli, com’è avvenuto in larga scala nelle Americhe e in Oceania: Khalidi ricorda come Ze’ev Jabotinsky, padrino della corrente politica che domina Israele dal 1977 con primi ministri che vanno da Begin a Netanyahu, scrivesse nel 1923 che «ogni popolazione autoctona del mondo resiste ai colonizzatori finché ha la minima speranza di potersi liberare dal pericolo di essere colonizzata» e che dunque per attuare il programma sionista sarebbe stato necessario un «muro di ferro di baionette». Ricorrente è, ancora, il ricorso alla categoria politico-giuridica di «terrorismo», emersa durante la Rivoluzione francese ma non a caso riplasmata in contesti coloniali come quello algerino o indiano, come dispositivo per demonizzare qualsiasi forma di resistenza e sradicarla con la violenza, in deroga a ogni garanzia contemplata dallo stato di diritto: qui Khalidi si sofferma in particolare sugli assassinii mirati di leader politici e intellettuali, come il poeta Kamal Nasser o lo scrittore Ghassan Kanafani, autore dello splendido Uomini sotto il sole. Ricorrente, infine, è il sostegno politico, economico e militare delle potenze coloniali del momento: Khalidi osserva come il sionismo si sia potuto impiantare in Palestina solo grazie all’appoggio dell’impero britannico, che disponeva delle enormi risorse necessarie a condurre una guerra coloniale contro la numericamente preponderante popolazione palestinese, e come, dopo il declino dell’impero britannico e nel contesto profondamente mutato del mondo postcoloniale, lo stato di Israele si sia potuto consolidare e ampliare solo «con il coinvolgimento diretto delle principali potenze dell’epoca e con la sanzione degli organismi internazionali da esse dominati, la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite».
La tesi del libro è che la storia della Palestina moderna sia interpretabile come un’unica «guerra dei cent’anni» che ha per obiettivo la cancellazione dei palestinesi e la loro sostituzione da parte dei coloni, come avvenuto in larga parte del mondo colonizzato dagli europei. Khalidi, optando per una narrazione che fonde in modo avvincente documentazione d’archivio e ricordi personali e di famiglia, dà corpo a questa tesi in sei capitoli dedicati ad altrettante «dichiarazioni di guerra»: dalla repressione britannica della resistenza palestinese (1917-39), passando per la Nakba (1947-48), l’occupazione della West Bank, della striscia di Gaza e del Sinai (1967), l’invasione del Libano e il bombardamento di Beirut (1982), gli accordi di Oslo (1987-95), fino alla guerra dei cinquantun giorni (2014), che con i suoi oltre 1300 morti e la distruzione del 15% delle costruzioni di Gaza appare oggi come una prova generale della campagna attualmente in corso.
A differenza di quadri interpretativi più tradizionali (il ‘semplice’ conflitto fra due nazioni o religioni, la risposta a una minaccia terroristica o antisemita, lo scontro di civiltà fra oriente e occidente) questa impostazione consente non solo di cominciare a fare i conti con il «fatto drammatico» su cui si interrogava Italo Calvino in una lettera a Issa Naouri nel 1968, e cioè «che i perseguitati d’un tempo si siano trasformati in oppressori», ma soprattutto di ricomporre in un quadro coerente una serie di aspetti messi in evidenza negli ultimi vent’anni dalla ricerca storica e dal giornalismo d’inchiesta, ma ignorati o minimizzati tanto nella storiografia mainstream quanto nel discorso mediatico: in particolare la cancellazione, a tutti i livelli, della presenza palestinese in Palestina, l’uso pervasivo e ossessivo della forza militare da parte di Israele e la piena partecipazione delle potenze occidentali a queste politiche. Per brevità mi concentrerò solo sul primo punto, passando in rassegna alcuni libri recenti.
Rispondono in effetti alla logica profonda del colonialismo d’insediamento non solo l’impressionante numero di atrocità ricostruite nel libro di Khalidi, ma anche lo sviluppo di tecnologie militari di controllo, di repressione e di eliminazione documentato da Antony Loewenstein nel suo accuratissimo Laboratorio Palestina: sistemi all’avanguardia, oggi basati sui big data e sull’intelligenza artificiale, che da tempo vengono testati sui palestinesi e rivenduti a stati autoritari, come l’Ungheria di Orban o l’India di Modi. Alla stessa logica rispondono le pratiche di segregazione ampiamente documentate nel volume Israeli Apartheid. A Beginner’s Guide di Ben White e nel ricco libro-intervista J’accuse della Relatrice speciale dell’ONU sui diritti umani nei territori occupati, Francesca Albanese, che si concentra in particolare sulle pratiche di «disumanizzazione» della popolazione palestinese. La «politica di separazione» spaziale e architettonica è stata invece indagata a fondo da Eyal Weizman, che in Spaziocidio ricostruisce le logiche che presiedono tanto alla costruzione del famigerato muro di oltre 700 km che rinchiude i palestinesi in vere e proprie riserve rendendoli «invisibili», quanto alla lenta ma inarrestabile distruzione di case e villaggi palestinesi per far posto agli insediamenti dei coloni. La cancellazione dei nativi sul piano culturale è oggetto dell’indagine La Palestina nei testi scolastici di Israele di Nurit Peled-Elhanan, che analizza l’impostazione «etnocratica» dei libri di scuola israeliani, scritti «per giovani che a diciott’anni saranno chiamati a fare il servizio militare obbligatorio e che porteranno avanti la politica israeliana di occupazione»: i palestinesi vi sono rappresentati, con sguardo tipicamente colonialista, come masse anonime, recalcitranti a ogni forma di sviluppo e integrazione nella modernità. In questa cancellazione culturale hanno da sempre un ruolo strategico le università israeliane, come mostra il recentissimo studio di Maya Wind Towers of Ivory and Steel, che ripercorre le politiche di «giudaizzazione» della Palestina attraverso l’uso strumentale di discipline come l’archeologia, la giurisprudenza, l’architettura, e naturalmente della ricerca tecnologica, spesso al diretto servizio dell’industria degli armamenti, nonché attraverso la produzione di propaganda di stato per rispondere alle critiche mosse a Israele dalla comunità internazionale. Del resto, come osserva la stessa Wind, nessuna università israeliana ha protestato ufficialmente quando l’esercito, nell’autunno dello scorso anno, ha raso al suolo o ridotto a spettrali scheletri di cemento tutte le università di Gaza – Islamica, Al-Azhar, Al-Aqsa, Al-Quds, Israa: dodici in tutto – uccidendo centinaia di docenti e studenti, e privando decine di migliaia di ragazze e ragazzi della possibilità di un’educazione superiore per chissà quanto tempo: un’azione incomprensibile in termini difensivi, o anche semplicemente militari, ma perfettamente coerente con la logica di eliminazione e sostituzione del colonialismo d’insediamento. Sul piano internazionale, infine, Rebecca Ruth Gould ha documentato, in Erasing Palestine, come la ridefinizione di antisemitismo proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e adottata da molti paesi sia usata strumentalmente per cancellare dal dibattito pubblico qualsiasi voce intenda rappresentare il punto di vista palestinese, con le conseguenze che vediamo tutt’oggi nella repressione di stato delle proteste degli studenti e degli attivisti di associazioni come Jewish Voice for Peace, particolarmente brutale negli USA e in Germania.
«Gli scontri tra coloni e popolazioni indigene», scrive Khalidi, «si sono conclusi solo in uno dei tre modi seguenti: con l’eliminazione o la completa sottomissione della popolazione nativa, come in Nordamerica; con la sconfitta e l’espulsione del colonizzatore, come in Algeria, caso estremamente raro; o con l’abbandono della supremazia coloniale, nel contesto di compromessi e riconciliazioni, come in Sudafrica, Zimbabwe e Irlanda». L’auspicio è, naturalmente, che anche in Palestina si arrivi a quest’ultima soluzione, anche se Israele ha intrapreso decisamente la strada verso la prima: da mesi ormai non passa giorno senza che i media ci mostrino bombe e bulldozer che cancellano case, scuole, ospedali, chiese, moschee, biblioteche, archivi, musei, siti archeologici, orti, oliveti, strade, cimiteri. Gaza non esiste più.
La storia, ha scritto Keith Jenkins, non è mai neutrale, ma sempre «per qualcuno». Se alla costruzione della narrazione dominante che ci accompagnerà nei prossimi decenni parteciperanno anche voci come quella di Khalidi, vorrà dire che palestinesi e israeliani – e i loro sponsor – avranno finalmente avviato «la transizione a un futuro postcoloniale», e che la loro storia sarà una storia per entrambi. Altrimenti, The Hundred Years’ War on Palestine resterà comunque a testimoniare, con la sua lucida indagine del passato coloniale, la verità di chi è stato cancellato.
I libri
Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine. A History of Settler Colonialism and Resistance. 1917-2017, New York, Metropolitan Books, 2020
The Routledge Handbook of the History of Settlers Colonialism, ed. by Edward Cavanagh and Lorenzo Veracini, London, Routledge, 2017
Francesca Albanese, J’accuse, con Christian Elia, postf. di Roberta De Monticelli, Milano, Fuori Scena, 2023
Maher Charif, Storia del pensiero politico palestinese, Bologna, Zikkaron, 2018
Rebecca R. Gould, Erasing Palestine. Free Speech and Palestinian Freedom, London, Verso, 2023
Antony Loewenstein, Laboratorio Palestina. Come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo, pref. di Moni Ovadia, Roma, Fazi, 2024
Ilan Pappé, Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli, Torino, Einaudi, 2005
Ilan Pappé, La pulizia etnica della Palestina, Roma, Fazi, 2008
Ilan Pappé, La prigione più grande del mondo, Roma, Fazi, 2022
Nurit Peled-Elhanan, La Palestina nei testi scolastici di Israele. Ideologia e propaganda nell’istruzione, Torino, Gruppo Abele, 2021
Edward Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 1999
Edward Said, La questione palestinese, pref. di Robert Fisk, Milano, Il Saggiatore, 2011
Edward Said, La pace possibile. Riflessioni, critiche e prospettive sui rapporti israelo-palestinesi, pref. di Tony Judt, Milano, Il Saggiatore, 2005
Eyal Weizman, Spaziocidio. Israele e l’architettura come strumento di controllo, Milano, Mondadori, 2022
Ben White, Israeli Apartheid. A Beginner’s Guide, London, Pluto, 2014
Maya Wind, Towers of Ivory and Steel. How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom, London, Verso, 2024, in corso di pubblicazione per Alegre.
Articoli correlati
Comments (3)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 La memoria familiare di Clara Sereni
La memoria familiare di Clara Sereni -
 Anatomia del personaggio romanzesco
Anatomia del personaggio romanzesco -
 La scomparsa di Frate Elia
La scomparsa di Frate Elia -
 Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna
Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -
-
La scrittura e noi
-
 Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti
Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -
 Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone
Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -
 Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar
Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -
 Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King
Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -
-
La scuola e noi
-
 Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento
Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -
 Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee
Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -
 I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria
I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -
 «Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici
«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -
-
Il presente e noi
-
 Ancora la pace subito: il multilateralismo conflittuale e la guerra
Ancora la pace subito: il multilateralismo conflittuale e la guerra -
 Il bisogno di un nuovo umanesimo
Il bisogno di un nuovo umanesimo -
 La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024
La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -
 Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza
Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -
Commenti recenti
- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…
- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.
- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…
- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…
- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


La descrizione fatta da Michele Sisto è molto chiara e diretta. La letteratura si interseca con la storia e la realtà che ne esce colpisce al cuore. Ho letto questo articolo con piacere grazie alla capacità di linguaggio dell’autore, oltre che con orrore per i sentimenti che ha destato in me. Le immagini che produce sono vivissime. Bellissimo articolo.
Articolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
L’articolo non solo tace molto più di quanto non dica, ma mette sullo stesso piano, con il classico stile bifronte del moderatismo più ipocrita (quello degli “opposti estremismi”), “la strage del 7 ottobre” (sic!) e il genocidio perpetrato dallo Stato israeliano nei confronti del popolo palestinese. Ad esempio, manca qualsiasi riferimento a contributi che gettino luce sul rapporto tra gli ebrei ucraini e il sionismo israeliano. In effetti, pochi sanno che gli ebrei ucraini hanno fornito un contributo fondamentale allo Stato israeliano, come dimostrano i nomi, pressoché sconosciuti all’opinione pubblica europea, di Ytzhak Ben-Zvi e di Ephraim Katzir, entrambi, come un buon numero di altri, ucraini. Del resto, lo stesso Volodymir Zelensky, nato da genitori ebrei divenuti recentemente cittadini israeliani, delineò, in un discorso tenuto all’Onu il 5 aprile del 2022, il futuro politico dell’Ucraina, dichiarando che il suo paese avrebbe dovuto conformarsi al modello israeliano. L’Ucraina, disse, «sarà più simile allo Stato israeliano che all’Europa occidentale; di fatto, tenderà a trasformarsi in un “Grande Israele”, la cui società sarà altamente militarizzata e le cui forze armate saranno incorporate in tutte le istituzioni». Come ha rilevato la rivista statunitense “Forbes”, «le analogie con Israele sono moltissime. […] Alcune di esse sono state analizzate dal gruppo di studio “Atlantic Council” e da numerosi osservatori». Così, fu proprio un qualificato esponente dell’“Atlantic Council”, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Daniel Shapiro, colui che rilanciò l’idea del presidente ucraino, accompagnandola però con alcune indicazioni essenziali per la sua realizzazione. Non desta meraviglia, pertanto, che con Zelensky quale presidente e con Volodymir Grojsman (anche lui ebreo) quale primo ministro, l’Ucraina si sia sempre più avvicinata a Tel Aviv, fino al punto che nel 2020 decise di ritirarsi da un Comitato delle Nazioni Unite che era stato costituito nel 1975 per consentire al popolo palestinese di esercitare non solo i suoi diritti di autodeterminazione, indipendenza e sovranità nazionale, ma anche il diritto a recuperare i suoi territori e le sue proprietà. Dal canto suo, il governo israeliano inviò i suoi istruttori in Ucraina per contribuire, così come faranno sulla stessa falsariga altri paesi occidentali, alla formazione militare dell’esercito di Kiev. Sennonché, per quanto riguarda la funzione dei due regimi nei rispettivi contesti geopolitici, è evidente che essi svolgono il ruolo, sotto la vigile guida americana, di avamposti aggressivi dell’Occidente imperialista contro il mondo russo, arabo e cinese. Ed è proprio in base alla strategia delineata da Zbigniew Brzezinski nel libro “La grande scacchiera. Il mondo e la politica nell’era della supremazia americana”, Kiev svolge questa funzione contro la Russia, mentre Tel Aviv è, da oltre settant’anni, il principale fattore di destabilizzazione e di guerra nel Vicino Oriente. Perché allora un tema così importante, capace di allargare la conoscenza della questione palestinese e del conflitto irreprimibile con Israele, non compare in nessuno degli autori citati? “Domandatelo al vento dei campi”, come disse una volta Knut Hamsun.