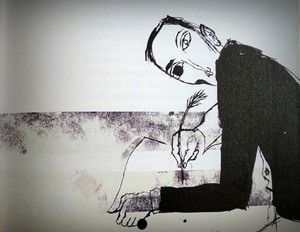
«I would prefer not to»: su Bartleby lo scrivano di Melville. La figura dell’impiegato nella letteratura dell’Otto e del Novecento/3
Pubblichiamo il terzo di una serie di interventi sul tema dell’impiegato nella letteratura del XIX e del XX secolo. Questi interventi hanno la loro origine nel corso di Letterature comparate dell’Università di Perugia, e sono stati scritti sia da docenti, che da studenti che a quel corso hanno preso parte attivamente. L’introduzione a questo ciclo di post si può leggere qui. Il secondo intervento qui.
– Bartleby, in fretta, non s’attende che voi.
Udii il sordo rumore delle gambe della sedia sul pavimento privo di tappeto, e ben presto egli apparve sulla soglia del suo eremo.
– Che desiderate? – chiese tranquillo.
– Le copie, le copie – risposi in fretta. – Le dobbiamo collazionare. Ecco – e gli tesi il quarto esemplare.
– Preferirei di no – disse, scomparendo tranquillo dietro il paravento.
Per alcuni istanti rimasi come una statua di sale, immobile alla testa dei miei tre impiegati. Non tardai però a riavermi, mi avvicinai al paravento e gli chiesi il motivo di così straordinario comportamento.
– Ma perché rifiutate?
– Preferirei di no.
Bartleby lo scrivano è, sin dalle prime battute, un testo che si interroga sull’essenza della nuova società statunitense. Si tratta di un racconto che volge lo sguardo al mondo del lavoro e alle sue dinamiche; ma non c’è dubbio che sia caratterizzato anche da una forte vena simbolica, che rende l’intera storia, se non assurda, perlomeno grottesca.
Ad una prima lettura Bartleby non sembra essere nemmeno il protagonista del racconto. Giovane, schivo e pallido, si presenta in uno studio legale per iniziare la carriera di copista. Quasi invisibile, con solerzia si avvicina alle pratiche, accanto ad altri impiegati che spiccano per eccentricità e che sembrano intrattenere con il superiore un particolare rapporto di accettazione e convivenza che sfiora a tratti i moti tipici dell’amicizia.
Il narratore, a capo dell’ufficio, personaggio stranamente disponibile e accomodante, diventa testimone involontario del declino della carriera e, di conseguenza, anche della vita del nuovo assunto. In un inspiegabile guizzo di intraprendenza (o forse sarebbe meglio dire di negazione del proprio ruolo), Bartleby decide di sottrarsi e di annullarsi: prima in quanto impiegato, e poi, in maniera più definitiva, in quanto uomo.
Ripetendo come una preghiera la frase che lo renderà celebre nella letteratura – «I would prefer not to» –, il giovane decide coscientemente di non adempiere più agli ordini; ma, ancora vincolato ad un ruolo dal quale sembra non poter sfuggire, non abbandona il campo di battaglia e rimane inevitabilmente invischiato in un luogo che si trasforma in non-luogo, un ufficio che perde tutto il carattere di spazio lavorativo e le funzioni stesse del suo essere, per divenire invece uno spazio in cui rinchiudersi per non uscirne più.
L’ambiguità tra la ferma decisione e la scelta verbale, che non si identifica immediatamente come un netto rifiuto, non fanno altro che rendere il personaggio ancora più sfuggente: quel ragazzo che aveva iniziato a fare il copista così bene si ritrova ora ad essere un peso, un peso imbarazzante, sulle spalle di un uomo che sembra non far altro che volerlo aiutare.
Non si può dimenticare, però, che la vicenda è ambientata negli Stati Uniti; lo ricorda con fermezza il sottotitolo: «A story of Wall Street». E questo vuol dire che, in qualche modo, tutte le dinamiche tipiche dell’Europa continentale – l’Europa di metà Ottocento in questo caso – sono inevitabilmente rovesciate. Mentre la figura dell’impiegato, nel vecchio continente, inizia a delinearsi come un modello in negativo (un uomo senza qualità integrato in un meccanismo che tuttavia lo schiaccia e lo priva di movimento, bloccandolo in una vita conchiusa senza possibilità di evasione o di fuga), in America la condizione di lavoratore, ancora più nel centro di quello che si delineerà come il cuore del capitalismo, può essere invece un trampolino, l’inizio di una scalata verso un successo senza limiti, che di certo non ci sarebbero stati per un impiegato così solerte come si era dimostrato Bartleby in principio.
Sembra quindi che questa scelta assuma, nella società in cui si sviluppa la narrazione, un tono più “sovversivo” di quanto non appaia ad una prima lettura: la scelta volontaria di non partecipare, e quindi di uscire dal meccanismo produttivo, rende il personaggio scomodo (tanto da essere accusato di vagabondaggio e incarcerato), e ne fa un uomo che agisce (ma allo stesso tempo non agisce) fuori dalle dinamiche indiscutibili in cui si muovono tutti gli altri.
Emblematico, perciò, che il narratore/datore di lavoro sia un avvocato e che rappresenti, anche se non direttamente, la legge; non stupisce che sia lui il primo a rimanere sbigottito della condotta del sottoposto, ma ancora più importante è che sia proprio lui a raccontare l’intera vicenda.
Ecco che Melville, immerso in un mondo dove Bartleby non può ancora parlare in prima persona, e dove non può alzare la testa per raccontare la propria storia, sceglie di dar voce allo status quo, a chi tiene le redini del gioco, inducendo il narratore – incredulo ovviamente – ad osservare un comportamento sotto molti aspetti ingiustificato, controproducente e autodistruttivo, che porterà il protagonista alla scelta non solo di non identificarsi come impiegato, ma come essere umano tout-court.
Bartleby, ormai in prigione, rispondendo all’ex datore di lavoro dirà: «So chi siete e non ho nulla da dirvi». Niente di più chiaro: un messaggio preciso che manifesta, ancora una volta, quanto sia radicata la consapevolezza del ragazzo; e quanto l’assurdità del racconto, che percepiamo scorrendo le pagine all’inizio, rappresenti in realtà, oltre che una magistrale scelta stilistica, l’acuta analisi di una trasgressività individuale, destinata fatalmente ad infrangersi contro l’ineluttabile moloch che era (ed è ancora) la società americana.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 La memoria familiare di Clara Sereni
La memoria familiare di Clara Sereni -
 Anatomia del personaggio romanzesco
Anatomia del personaggio romanzesco -
 La scomparsa di Frate Elia
La scomparsa di Frate Elia -
 Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna
Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -
-
La scrittura e noi
-
 Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti
Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -
 Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone
Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -
 Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar
Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -
 Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King
Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -
-
La scuola e noi
-
 Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento
Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -
 Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee
Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -
 I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria
I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -
 «Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici
«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -
-
Il presente e noi
-
 Ancora la pace subito: il multilateralismo conflittuale e la guerra
Ancora la pace subito: il multilateralismo conflittuale e la guerra -
 Il bisogno di un nuovo umanesimo
Il bisogno di un nuovo umanesimo -
 La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024
La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -
 Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza
Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -
Commenti recenti
- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…
- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.
- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…
- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…
- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento