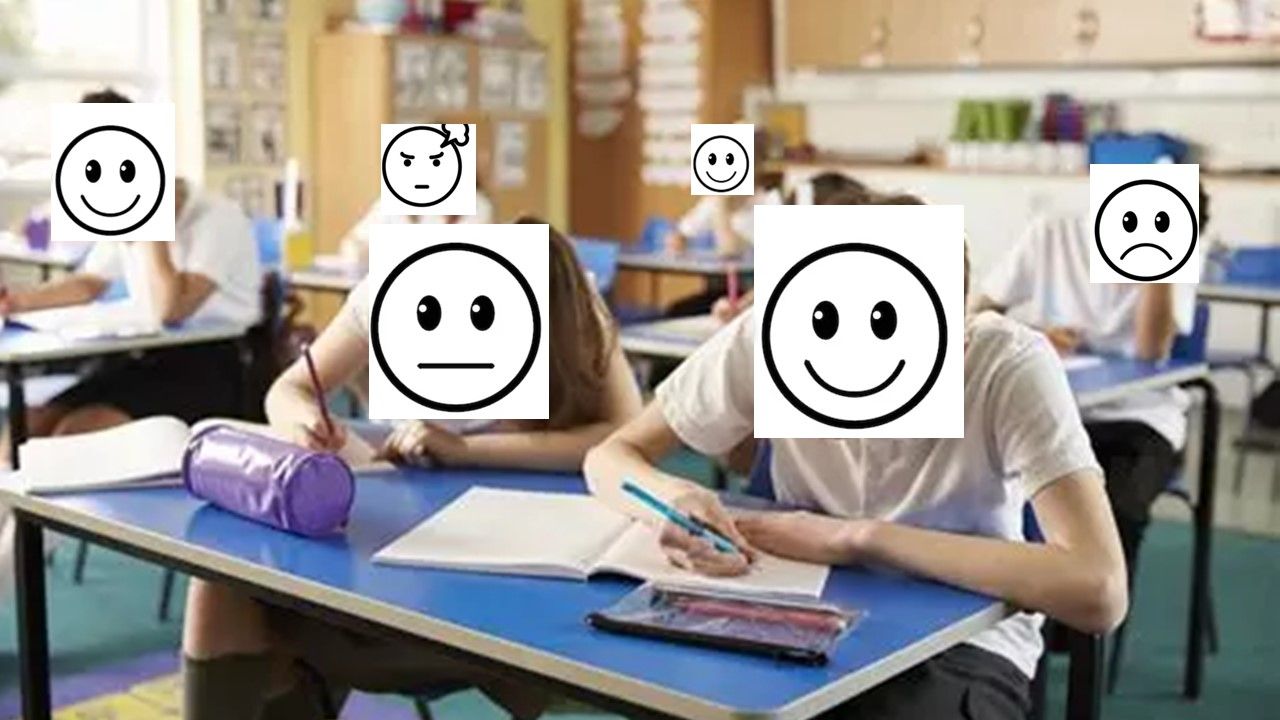
Dalle conoscenze, alle competenze, all’affettività: utopia o distopia di una professione?
A luglio 2024 ho concluso il mio anno di prova e sono finalmente diventata una docente di ruolo. È stato un percorso abbastanza impegnativo, e non solo per le innumerevoli incombenze burocratiche o per gli esami e le prove sostenute. È stato faticoso soprattutto tentare di trovare una risposta a una serie di domande che sono scaturite nel corso dell’anno e che sono state tante. Ho capito però che una sola sorregge tutte le altre: qual è lo scopo dell’insegnante? qual è il suo obiettivo? (la sua mission, direbbero i fan dell’aziendalese, tanto in voga anche a scuola, ormai). Questo scritto parte proprio da questa domanda, alla quale cercherò di rispondere non tanto citando dati statistici, sondaggi, normative di riferimento, bensì a partire da conversazioni ed episodi della vita quotidiana in classe, e più in generale a scuola, nella consapevolezza che spesso quello che un insegnante sente, vive e sperimenta ogni giorno rappresenta concretamente la sua realtà professionale.
C’erano una volta le conoscenze
Partirei col dire che, ne sono abbastanza certa, trent’anni fa, forse anche venti, un docente non avrebbe fatto grande fatica a definire il senso dell’insegnamento. Lo dico pensando ai miei professori o anche a mia madre, che insegna dal 1987 e che, sin da quando ero bambina, ho sempre visto ben salda nel proprio ruolo. Lei sapeva che il suo dovere era sostanzialmente quello di trasmettere a ragazzi e ragazze conoscenze puntuali nella propria disciplina e di dover contribuire alla loro formazione e crescita personale, segnalando con buoni voti un percorso di apprendimento ben riuscito, e invece con insufficienze e anche, se necessario, bocciature, l’apprendimento non giunto a buon fine. Questa sua convinzione era largamente condivisa da colleghi e colleghe che, dunque, grazie a una certezza abbastanza solida su cosa la società chiedesse loro di fare, svolgevano la propria attività senza troppi vacillamenti, dubbi, insicurezze. Ho detto troppi, naturalmente, perché il dubbio è parte integrante del lavoro di docente, come un po’ accade nel “mestiere” di genitore.
Tuttavia, oggi la società e, di riflesso, il mondo della scuola sono più complessi, e la definizione dell’insegnante non può più coincidere con quella appena fornita, nemmeno per mia madre o per chi, come lei, ha una così lunga esperienza alle spalle. Siamo in una fase di costante rimodellamento del ruolo del docente, sono cambiate le richieste che gli vengono fatte e, pertanto, il docente è sempre più portato a interrogarsi su di sé.
Innanzitutto, parlare di conoscenze pare vietato, quantomeno demodé, da quando i documenti europei sul finire degli anni ’90 hanno iniziato a porre l’accento sulle competenze e sulle abilità che il docente deve stimolare con una serie di «metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di “ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti» (Piano per la formazione dei docenti 2016-2019).
Molte delle metodologie innovative a favor di competenza (flipped classroom, role playing, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring,) hanno tuttavia un sapore moderno per la scelta dell’anglicismo, ma in verità venivano sperimentate anche quando ancora non si avvertiva l’esigenza di etichettarle con un forestierismo. La vera novità, dagli anni Duemila, consiste nella richiesta di rendicontarle puntualmente in piani di lavoro individuali o programmazioni di classe, incasellandole in moduli sempre più burocratizzati, nell’impianto e nella struttura, che sottraggono non poco tempo alla progettazione didattica tout court.
Ad ogni modo, l’accento su queste nuove metodologie e sulle competenze non è accompagnato da una mirata formazione nelle discipline specifiche; lo dimostra anche l’organizzazione stessa dell’anno di prova per i neoimmessi: nessun laboratorio di formazione per neoassunti verte su singole classi di concorso. Mi spiego meglio: abilitandomi per la classe A011 (discipline storico letterarie e latino nei licei), mi sarei aspettata almeno un paio di corsi precipuamente dedicati alle materie di indirizzo, con approfondimenti sulle singole discipline o anche alla loro didattica (didattica del latino o delle discipline storiche, strategie per letture in classe dei Promessi Sposi, ad esempio). Invece tutti noi neoimmessi in ruolo abbiamo potuto scegliere quattro laboratori a partire da un ventaglio di proposte dal taglio generico (es. Bisogni educativi speciali, Innovazione della didattica delle discipline, La didattica orientativa), eccezion fatta per il laboratorio dedicato all’insegnamento trasversale dell’educazione civica e alla sua integrazione nel curricolo scolastico.
L’aggiornamento nelle singole discipline non è prioritario, non viene infatti richiesto durante l’anno di prova, né in seguito, poiché generalmente i dirigenti scolastici invitano gli insegnanti a frequentare corsi più genericamente destinati all’innovazione digitale, al miglioramento delle lingue straniere o anche alla gestione della classe.
E così, se l’archeologia, la paleontologia, l’antropologia, la chimica, la fisica, la linguistica negli ultimi vent’anni hanno fatto scoperte rilevanti, sta alla libera iniziativa del singolo docente venirne a conoscenza; per i “piani alti”, per dire così, non sembra che la questione abbia una grande importanza, tanto che la presentazione di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinari non sono requisito necessario, obbligatorio.
Da ciò consegue che è la sorte a decidere se una classe seguirà un corso di storia o di scienze aggiornato, alla pari con le scoperte più recenti, nel caso in cui il professore o la professoressa di turno sia particolarmente illuminato/a, oppure se continuerà a seguire ciò che propongono i libri di testo, sempre rinnovati nell’impaginazione, ma in molti casi arretrati nei contenuti.
A scuola di emozioni
In quasi tutti i laboratori che ho frequentato l’anno scorso, ma in particolar modo in quelli dedicati ai BES e all’Innovazione della didattica, il focus non sono mai state le discipline, né tanto meno le metodologie. Il leitmotiv dominante era il clima di apprendimento: obiettivo primario era motivarci a garantire un contesto sereno in classe. E veniamo, dunque, alla parola che sta pian piano distogliendo l’attenzione non solo dalle conoscenze, ma anche dalle stesse competenze di ragazzi e ragazze: l’emotività, di cui l’affettività è una variante ancor più in voga nei discorsi sulla scuola.
Ai docenti in formazione viene continuamente ripetuto che il nostro obiettivo principale è combattere la dispersione scolastica e, per farlo, pare che l’insegnante debba essere in grado di garantire la serenità e la partecipazione gioiosa dei propri studenti.
L’obiettivo è senza dubbio importante e condivisibile (come altrimenti?), tuttavia questa serenità dello studente è così cruciale che talvolta parole innocue, almeno quando frequentavo io la scuola, come verifica, qualità, lo stesso merito al centro della nota bufera polemica, generano resistenze o vero e proprio astio, perché percepite come un baluardo della vecchia scuola di stampo gentiliano. Faccio un esempio: la formatrice del laboratorio sui BES a cui ho preso parte, proveniente dalla scuola primaria (una sorta di contraddizione, visto che il laboratorio era dedicato precipuamente a neoimmessi della scuola secondaria di secondo grado) ci ha posto una domanda che mi ha colpito: “Voi usate la parola verifica, vero? Provo sempre un taglio al cuore quando la sento”, mimando addirittura il gesto della ferita sul petto.
Quando, perplessa e anche un po’ risentita per essere identificata con una sorta di strega cattiva dell’insegnamento, ho chiesto il motivo di tanta sofferenza arrecata da una voce che vuole semplicemente essere il risultato di un’ellissi (a partire da verifica degli apprendimenti, non di certo della persona) non ho ricevuto risposta. Il problema è che neppure la mia esigenza di scoprire metodi efficaci per arginare le fatiche dell’apprendimento di studenti e studentesse con bisogni speciali è stata appagata, perché di strategie didattiche specifiche per i BES non si è parlato affatto.
Venendo al laboratorio sull’Innovazione della didattica, si è in effetti discusso degli approcci didattici cooperativi, multimediali, anche ludici, delle arcinote TIC, sicuramente utili a favorire un apprendimento disteso ed efficace, ma tutti questi metodi sono stati presentati con la finalità di allontanare l’emozione che più danneggia (o meglio, danneggerebbe?) il percorso formativo: l’ansia. Tale parola a scuola si sente pronunciare mediamente tre o quattro volte al giorno, e pare che vada cacciata, come un virus da combattere. “Entrate sempre in classe col sorriso”, ci siamo sentiti raccomandare in quel laboratorio, e il nostro sorriso, in effetti, è stato forse il principale strumento innovativo di cui si è parlato. “Se non trovi ogni giorno modo di sorridere in classe cambia lavoro”, è stato detto addirittura così. Ammesso e non concesso che un qualunque lavoratore possa essere allegro e sorridente ogni mattina, è pensabile che le qualità più importanti di un docente siano ritenute, ormai, l’empatia o la bonomia e non la sua preparazione disciplinare e la capacità di trasmetterla alla classe? Forse è questa nuova visione della professione che dà adito a proposte come la famosa ora di affettività, che financo Paola Cortellesi, dopo l’ennesimo David di Donatello ricevuto, si è sentita di dover invocare come necessità imprescindibile per il rinnovamento della scuola italiana e per la lotta all’inveterato problema della violenza di genere.
Nessuno spazio alla frustrazione
Credo ci sia quantomeno da fermarsi a riflettere. Il professore che lotta contro la dispersione scolastica elargendo sorrisi e promuovendo affettività può giungere a un grande fraintendimento su quello che davvero è in grado di fare coi propri studenti. Ho sentito colleghi arrivare ad affermazioni del tutto incompatibili con la loro cultura di base: “A che serve la grammatica?”, “Cosa importa se gli studenti sanno riconoscere o meno i pronomi?”, “Per l’insegnamento della poesia io salto la parte delle figure metriche e di suono/posizione. Preferisco un percorso tematico”. Sono tutte opinioni che ho sentito durante Dipartimenti di Lettere degli ultimi anni tre anni, che vengono da colleghi che peraltro stimo molto, ma che mi sono parsi in quei frangenti incastrati in un sistema in cui il docente non è colui che insegna una materia, che trasmette conoscenze motivando e favorendo la partecipazione in classe (proposizioni strumentali!), che può coinvolgere, ma talvolta anche annoiare (perché no?) i suoi discenti, ma è colui che li accompagna in una scoperta di emozioni gratificanti risparmiando loro esperienze spiacevoli caratterizzate da grande fatica, delusione, noia, frustrazione.
Parliamoci chiaro: la grammatica è difficile, reca solo gioia se non si deve studiare poi con grande precisione, o se la si salta a piè pari; la poesia è un grande WOW, se possiamo tutti insieme strappare le pagine sulla metrica o sulle figure retoriche. Quando lo fa il professor Keating ne L’attimo fuggente ha tutto un altro senso, però: è un gesto alla William Wallace, un inno alla libertà negata in quella scuola rigida e asfissiante assolutamente imparagonabile alla maggioranza degli istituti pubblici e privati italiani. Inoltre, le pagine strappate nel film non sono neppure quelle della metrica, bensì del calcolo matematico del piacere prodotto da un componimento poetico. Un’altra storia, insomma.
Preciso, semmai ci fossero equivoci, che è innegabile che l’emozione sia consustanziale al rapporto insegnante/apprendente, né posso dirmene esente: sono la prima che si commuove coi suoi ragazzi (anche fino alle lacrime, ahimé!), per letture condivise o durante momenti di discussione. Ma mi chiedo: in questo sforzo di tutela delle emozioni, che posto hanno quelle negative? Dove sono odio, fastidio, antipatia? Quante insegnanti mi sono state antipatiche, quanti i docenti a cui ho dato appellativi poco cortesi per alcuni voti negativi o commenti, magari anche involontari, ma che mi hanno fatta soffrire? Quante volte mi sono annoiata durante le lezioni? Eppure, tutto ciò è stato formativo.
Dalle parole di alcuni docenti percepisco il desiderio di essere benvoluti dagli studenti, di guadagnarne la simpatia, di sentirsi dunque appagati a fine anno dal bigliettino commovente, dal regalino di classe, dal “le voglio bene”, tutti gesti che, per carità, anche io ho ricevuto e che mi hanno fatta sentire felice. Tuttavia, questa felicità spesso viene adombrata dalla constatazione di programmi svolti solo parzialmente e da tabelloni finali che sono insoddisfacenti: mi vogliono bene, mi stimano, però non riesco a parafrasare più di dieci versi all’ora dell’Iliade (perché così è la realtà in molte classi). Quando parafrasiamo il testo omerico vedo spesso facce perse, smarrite, annoiate, che si illuminano solo quando dalla parafrasi passo al racconto dei fatti. “Perché non gli facciamo fare un debate?”, “Perché non gli facciamo vedere Troy?”. Ottime idee per stimolarli, certo, e per risollevarmi io stessa da una platea inebetita, ma non accetto che i ragazzi perdano la capacità di parafrasare. Non posso negare loro la possibilità di apprenderla.
Un collega e amico anni fa mi ha detto: “Attenta a stare troppo simpatica agli studenti”. Sul momento non compresi, ma ora so che il suo monito racchiude una verità importante: così come un buon genitore, anche un buon insegnante a volte può essere severo, pretendere, risultare noioso, antipatico. Può anche ingenerare, suo malgrado, ansia.
Sì, anche l’ansia è indispensabile. Lo insegna anche Inside out 2: non è possibile formare personalità complete facendo prevalere un’emozione sulle altre. Tutte servono alla creazione di un io sfaccettato e capace di affrontare una realtà altrettanto mutevole. Nel film, Gioia, l’emozione che più sembrava in grado di garantire una vita felice alla protagonista, capisce che negarle i ricordi negativi era un errore, e li riporta tutti a galla. Fra queste bolle di memoria una riguarda la scuola, è il momento della restituzione di una verifica accompagnato dalle parole del professore: “Andersen, mi aspettavo di più”.
Un buon docente non prova mai piacere nell’attribuzione di un brutto voto, che però è necessario, che però può essere anche un modo per condurre la persona verso la piena maturità, per farle imparare a cadere, non per forza a evitare la caduta.
È per questo che passo ore a cercare di elaborare griglie di valutazione chiare ed efficaci, griglie che vanno dal 3 al 10, secondo parametri puntuali. Eppure, mi sono sentita e mi sento spesso dire in consiglio di classe e in collegio docenti che è meglio non dare voti inferiori al 5, per le motivazioni più disparate: perché tanto un 4 o un 5 sono pur sempre insufficienze, dunque a cosa serve dare 3? I voti inferiori al 5 mortificano e basta, è buona prassi non darli a chi ha una situazione familiare molto complessa, oppure è proprio ingiusto ricorrere a voti troppo bassi in una prima superiore in generale, per una questione anagrafica, perché i giovani studenti potrebbero traumatizzarsi e demotivarsi.
La “scuola affettuosa” è davvero utile?
Eppure, non mi pare che questo atteggiamento mite stia dando grandi frutti: i giovani leggono poco, scrivono e parlano male, e non sono solo impressioni; basterebbe consultare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica, inglese, spesso disastrosi, ma soprattutto provare a correggere un paio di tornate di temi delle superiori.
La dispersione scolastica è un problema cruciale della nostra società, ma spesso si trascura quella implicita: una quota importante di studenti consegue il diploma, ma non raggiunge nemmeno lontanamente i livelli di competenza che ci si dovrebbe aspettare dopo tredici anni di scuola. Spesso, ragazzi e ragazze escono dalle scuole superiori, anche con votazioni non basse, ma sono poco o nulla preparati ad affrontare percorsi lavorativi o universitari. Per citare un paio di esperienze personali, posso innanzitutto ricordare che cinque anni fa la Facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano mi ha assunta per un corso di recupero specifico per studenti del primo anno che non avevano superato la prova di comprensione del testo in italiano del test d’ingresso. Erano circa una trentina di studenti, di cui nessuno di origine straniera. L’anno scorso la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza della Bocconi mi ha contattata per tenere un laboratorio di scrittura italiana, preoccupata per l’incapacità degli studenti al primo anno di scrivere mail corrette da un punto di vista formale e pragmatico.
Di fronte a questi livelli di conoscenze e competenze sempre inferiori, per certi versi dipesi dall’attitudine alla promozione e alla sufficienza “facili” di un sistema di valutazione affettuosamente bonario, molti docenti cercano una via di fuga dalla propria frustrazione. Questa via è offerta dal già citato sorriso o dal famoso guizzo, barlume, lampo di comprensione o di dubbio manifestati da tale studente o talaltra studentessa durante una spiegazione. Naturalmente ogni insegnante è lieto, forse anche compiaciuto, constatando di aver suscitato interesse e curiosità nei propri studenti, e lo è ancor di più quando questi comprendono le sue spiegazioni. Direi che si tratta di un’ovvietà, anche se è vero che in anni di apatia adolescenziale dilagante il docente avverte con più intensità l’entusiasmo di aver animato, per giunta culturalmente, i giovani.
Tuttavia, pensare che questi momenti quotidiani racchiudano il senso dell’insegnamento, è una forzatura. Eppure lo ha detto anche Viola Ardone circa sei mesi fa, in un’intervista rilasciata a Corrado Augias per La torre di Babele; dopo aver ribadito nel corso dell’intervista alcuni pensieri che condivido pienamente, dunque che la scuola debba insegnare il fallimento e non garantire per forza l’applauso, che esiste un’eccessiva contiguità fra genitori e ragazzi che impedisce il distacco generazionale necessario alla crescita, che spesso i genitori contemporanei faticano ad ammettere le lacune, i problemi, le difficoltà dei figli, piuttosto addebitati all’incapacità di chi insegna, alla domanda finale di Augias Ardone sente di suggellare la propria intervista con una chiosa retorica. Quando il conduttore le chiede: “Qual è il privilegio dell’insegnante oggi?”, Ardone risponde affermando che questo coincide con il cenno di comprensione dell’alunno, ma non di uno qualsiasi, ovviamente di quello seduto all’ultimo banco.
L’insegnante e scrittrice elude così la vera domanda di Augias: è davvero un privilegio insegnare oggi, come lo era tempi addietro? Chiunque si trovi dietro alla cattedra sa che non lo è, che la figura dell’insegnante non gode più di un rispetto sociale insito nel suo ruolo, che deve guadagnarsi sul campo ogni giorno rispetto di alunni e genitori e che la propria autorità è una conquista, non un diritto socialmente garantito a priori.
Il suo obiettivo comunque, la sua vera soddisfazione, non dovrebbe essere quella di ottenere dei risultati di apprendimento evidenti? La vera efficacia dell’insegnante non dovrebbe cercarsi anche nelle verifiche degli apprendimenti?
Motivare dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale portare le classi a raggiungere una meta, piuttosto che la meta stessa del nostro lavoro. Se durante una mia lezione di grammatica italiana metà classe annuisce con entusiasmo, qualcuno mi sorride, qualcun’altro aggrotta le sopracciglia meditando dubbioso sulla subordinata oggettiva, ma poi in verifica due terzi della stessa classe sono insufficienti, allora non ho raggiunto il mio scopo. Davvero dovrei soffermarmi su quelle espressioni di dubbio e partecipazione per trovare il famoso senso dell’insegnamento?
Il mio anno di prova si è chiuso con una mail di una mamma molto arrabbiata, giunta domenica 12 giugno, a mezzogiorno. La mia brutale colpa? Non aver avvisato chiaramente prima la figlia del fatto che avrebbe preso il debito in storia (con la media del 5 ben evidente sul Registro Elettronico). Ho illuso la ragazza dicendole che dovevo valutare se dare o meno il debito, l’ho tradita, non le ho dato fiducia.
E io, che credevo di averle dato l’opportunità di consolidare il proprio metodo, e di recuperare conoscenze e competenze importanti per accedere all’anno successivo, mi sono sentita infelice, ma poi ho pensato che era giusto così, che il mio dovere lo avevo fatto, nonostante il mio comportamento non fosse stato apprezzato dalla famiglia, né dalla studentessa (almeno al momento). Sono infatti arrivata alla convinzione che si debba tornare a dare importanza alle conoscenze e segnalare chiaramente quando queste sono lacunose, possibilmente indicando anche la gravità di queste lacune, e la scala dei voti aiuta semplicemente a fare questo. Ovviamente tale attitudine professionale fa sì che oltre ai sorrisi, ai cenni di comprensione, ai grazie, ai bigliettini affettuosi, si ricevano spesso arrabbiature e musi lunghi, di studenti e genitori. Ma va bene anche questo.
Bisognerebbe riavvicinarsi alle certezze che i docenti avevano venti o trent’anni fa, che risiedevano in conoscenze aggiornate, puntuali, accurate, trasmesse ai giovani con l’obiettivo di maturare implicitamente competenze (senza che sia necessario dichiarare a priori quali esse siano!) e che spesso sono loro stesse un buon veicolo per stimolare emozioni. Qualche settimana fa, a partire da una lettura di Erri De Luca in una classe prima, gli studenti hanno scritto un testo su un ricordo della loro infanzia che riguardasse il cibo. Alcuni si sono veramente emozionati, una studentessa ha pianto. Altro che ora di affettività.
I giovani oggi mostrano una disarmante fragilità, è vero, ma non è evitando loro frustrazioni e cadute che li aiuteremo a superarle: l’arma che possediamo noi docenti per fortificare le giovani generazioni sono proprio quelle conoscenze che sono linfa per l’humanitas, di cui la scuola pare tuttavia sempre più disinteressarsi.
Articoli correlati
Comments (5)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
Commenti recenti
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Insegno alle medie dal 2002. Ho visto cambiare molte cose e, se è vero che i pdp per gli alunni con esigenze speciali sono una buona cosa, che la consapevolezza del dover gestire l’aspetto educativo, relazionale, emotivo è importante (e lo è soprattutto in questo mondo postpandemico), cito, a chiosa di questa utile riflessione, un’imperitura quanto lapidaria definizione di un’amatissima collega e amica, scomparsa qualche anno fa: “Le competenze vanno bene per quelli che non hanno voglia di imparare i contenuti.” E se è un po’ tranchant, non scandalizzatevi. Fa volutamente da contrappeso a ore e ore di fuffa che la collega si è subita negli ultimi 20 anni di lavoro tra corsi, relazioni e papiri vari, continuando a insegnare Matematica e Scienze con il metodo “di una volta”. I colleghi la chiamavano Hitler. I ragazzi la adoravano, e delle sue lezioni non perdevano una sillaba. Io, vent’anni meno di lei, insegno Italiano, Storia e Geografia sforzandomi di essere altrettanto rigorosa. Per adesso non mi hanno ancora processata per crimini contro l’umanità.
Dall’articolo traspare chiaramente l’obiettivo di depotenziare le discipline a favore di una indeterminata corsa alle competenze, viste come contenitori vuoti da riempire a caso. Non si capisce però che bisogna aver ben salde le discipline per proporre modalità di insegnamento innovative. Rivendico però una cosa: la possibilità, a scuola, di annoiarsi. La scuola non è un centro ricreativo, né uno studio di psicologo, ma un luogo dove si può sperimentare lo studio fine a se stesso (urliamolo) e il confronto tra pari con una guida, l’insegnante. Non so se quelli di trent’anni fa avessero più certezze, ma so solo che si muovevano in un contesto diverso, più rispettoso del ruolo. Ecco, prima di iniziare ogni riflessione sulla scuola, andrebbe indagato il fuori, che la condiziona inevitabilmente.
Da docente di lettere in un istituto professionale condivido tutto ciò che ha scritto. Sono anni che mi batto per evitare l’abbassamento drastico delle richieste che provoca a sua volta un abbassamento ancor più drastico delle risposte da parte degli studenti. Fra l’altro ritengo che dietro il buonismo di alcuni noi docenti si celi una profonda disonestà nei confronti di coloro che dovremmo educare.
La ringrazio molto per la condivisione che mi fa sentire meno sola.
Posso solo invitarla a tenere duro… perché ha colto il punto. Riuscire ad allestire un ambiente di apprendimento positivo è rilevante se e solo se è funzionale agli apprendimenti…. altrimenti è solo un succedaneo del fare scuola. La questione delle conoscenze poi è buffa. Tragicamente buffa. dal 1885 (perlomeno) chiunque si sia occupato di programmi scolastici ha sempre dichiarato che l’insegnamento non doveva perseguire l’apprendimento meccanico. Gentile compreso… i cui programmi d’esame (programmi di studio, salvo alle elementari, non ne esistevano.) sono un’ode alle competenze disciplinari che dovevano essere vagliate dagli esaminatori (googolare per credere). La questione a mio avviso è altra e insidiosissima. Il baricentro si è spostato dalle competenze disciplinari alle competenze funzionali. Il che tocca relativamente l’area matematico scientifica, ma devasta le discipline a più netta rilevanza culturale.
Contributo estremamente veritiero, mi ci ritrovo in toto. Nulla da aggiungere, solo grazie.