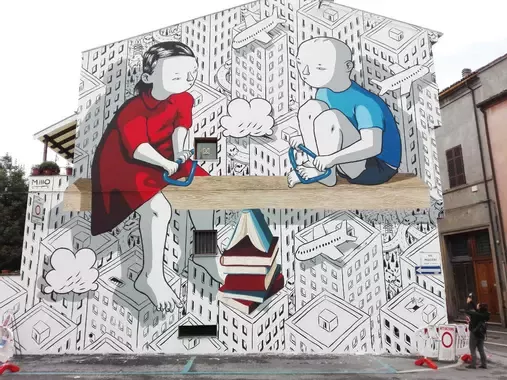
L’ora di lotta al femminicidio
Non è una novità che, di fronte a fatti di cronaca che coinvolgono giovani e giovanissimi, da molte parti si alzino voci che chiedano insistentemente alla scuola di farsi carico di questo o di quel problema sociale – la lotta alle mafie, la cura dell’ambiente, il razzismo, l’abuso di sostanze stupefacenti… – in un fiorire di pacchetti di ore di “Educazione a…”, giornate commemorative, incontri con esperti, conferenze, concorsi, e chi più ne ha, più ne metta.
È successo anche questa volta, di fronte all’ennesimo, agghiacciante, femminicidio.
Ma chiedere che la scuola faccia da deus ex machina ogni volta che i titoli dei giornali sembrano interrogarsi su “come sia potuto accadere” significa crogiolarsi nell’illusione: illusione che la scuola possieda non si sa bene quale capacità taumaturgica di ovviare ad un problema gravissimo e profondamente radicato come quello della mascolinità tossica e della mentalità patriarcale; illusione, soprattutto, che la scuola non sia essa stessa parte del sistema sociale o non sia essa essa stessa una società in piccolo – quando, al contrario, è la prima forma di organizzazione sociale che i bambini e le bambine incontrano al di fuori della famiglia.
Cosa possono fare, infatti, un pacchetto di ore ad hoc spalmate qua è là, un paio di lavori di gruppo con annessa realizzazione di un bel PowerPoint e la partecipazione ad una conferenza – magari pomposamente rinominati, nelle scartoffie burocratiche, nei PTOF e nelle programmazioni di classe, Laboratorio per il contrasto della violenza di genere? Cosa possono fare, soprattutto, in una società che trasuda sessismo e violenza di genere da ogni poro – dalle famiglie al mondo del lavoro, allo sport, all’intrattenimento? Cosa possono fare per le bambine che già dalla scuola dell’infanzia sono costrette ad indossare un grembiulino rosa anziché uno rosso, giallo, blu o verde? Cosa possono fare per la ragazzina di undici anni che ogni mattina deve, lei, unica femmina, rifare i letti dei fratelli prima di uscire per andare a scuola? Cosa possono fare per la tredicenne che torna a casa con un consiglio orientativo per il liceo scientifico, ma a cui il padre annuncia che la matematica non fa per le ragazze e che quindi la iscriverà ad un corso di parrucchiera? Cosa possono fare per l’adolescente che, almeno un paio di volte alla settimana, arriva in ritardo a lezione perché sul treno delle 7.35 c’è quell’uomo che la fissa insistentemente e cerca di avvicinarla, e quindi preferisce aspettare il treno successivo, anche a costo di un richiamo? Cosa possono fare per tutte le studentesse brillanti che, ad ogni pranzo di famiglia, anziché ricevere complimenti per il 9 nel compito di fisica o il 30 e lode all’esame di microbiologia, si sentono costantemente chiedere se hanno un fidanzato? Cosa possono fare per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che, tornati a casa, vedono il lavoro domestico e di cura sempre sulle spalle delle donne? Che, fuori dalle mura della scuola, sono inondati da messaggi pubblicitari, editoriali di giornali, testi di canzoni, prodotti mainstream di ogni tipo che rigurgitano sessismo, oggettificazione del corpo femminile, misoginia?
Non chiedete, quindi, alla scuola, soluzioni miracolistiche. Soprattutto, non chiedetele ad una scuola sempre più bistrattata, impoverita, burocratizzata, considerata ormai solo in funzione del mondo del lavoro (mondo del lavoro dove, tra l’altro, imperano gender pay gap e soffitti di cristallo) e non più come luogo fondamentale per la costruzione del pensiero critico, dell’identità personale e civica.
Ma allora, la scuola può sentirsi indifferente al problema della violenza di genere sistemica? Certo che no, ma lasciate che essa lotti con i propri mezzi e i propri strumenti: lasciate che insegnanti appassionati di matematica e scienze facciano, per la presenza femminile nelle discipline STEM, più di quanto possano fare mille giornate dedicate a donne e scienza; lasciateci il tempo e lo spazio per leggere e commentare in classe Extraterrestre alla pari, La lupa e Quaderno proibito, per indignarci di fronte al linciaggio di Ipazia, alla lettera scarlatta di Hester Prynne, alla monacazione forzata di Gertrude, allo stupro di Catherine Maheu, e di riconoscerci nelle loro storie; lasciateci il tempo di spiegare Olympe de Gouges, Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir; di ammirare le opere di Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo e Marina Abramovič, senza imbrigliarci in moduli, UDA, progetti e progettini curricolari ed extracurricolari, perché questo sappiamo fare, e sappiamo farlo, spesso, molto bene. La richiesta che si può fare agli insegnanti e alle insegnanti, quindi, non è quella di estrarre dal cappello una nuova disciplina, l’ora di lotta al femminicidio, ma quella di essere autoriflessivi, di interrogarsi seriamente su se stessi e su se stesse (come già chiedeva, cinquant’anni fa, Elena Gianini Belotti in quel saggio capitale che è Dalla parte delle bambine), proprio in quanto membri di una società in cui le norme non scritte della discriminazione e della violenza di genere sono state profondamente interiorizzate, per scardinare in sé gli stereotipi, i preconcetti, i comportamenti “istintivi” e “naturali” che ci rendono portatori e portatrici sani di patriarcato, nel tentativo di rendere la scuola non l’impoverita panacea a tutti i mali di una società iniqua, violenta, maschilista, ma un piccolo laboratorio in cui sperimentare un modello alternativo di comportamenti e di relazioni, più giuste ed eque, meno violente e meno sessiste per tutti e per tutte.
Articoli correlati
Comments (4)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 La memoria familiare di Clara Sereni
La memoria familiare di Clara Sereni -
 Anatomia del personaggio romanzesco
Anatomia del personaggio romanzesco -
 La scomparsa di Frate Elia
La scomparsa di Frate Elia -
 Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna
Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -
-
La scrittura e noi
-
 Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti
Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -
 Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone
Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -
 Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar
Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -
 Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King
Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -
-
La scuola e noi
-
 Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento
Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -
 Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee
Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -
 I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria
I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -
 «Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici
«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -
-
Il presente e noi
-
 Il bisogno di un nuovo umanesimo
Il bisogno di un nuovo umanesimo -
 La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024
La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -
 Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza
Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -
 Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola
Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola -
Commenti recenti
- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…
- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.
- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…
- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…
- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Grazie Emanuela,
perché in questo articolo, in cui percepisco la tua partecipazione emotiva sul tema, hai dato voce alla posizione di tanti insegnanti che sono stanchi di essere additati come la causa della degenerazione della società e accusati ogni giorno, da politici di varia appartenenza, di “non fare abbastanza”. Si fa educazione sentimentale con l’esempio, con una lettura, un dibattito, con la restituzione di un romanzo, con la scrittura di un tema di attualità. Tutto è educazione sentimentale, ma anche civica, se il nostro agire didattico si muove tra passione e consapevolezza. Grazie ancora di aver dato forma ai pensieri di molti che sono stanchi di sentire frasi come “a scuola bisogna introdurre… (completamento a scelta)”.
Condivido ogni singola parola e mi complimento con chi ha scritto l’articolo. Sono insegnante in pensione e con alunne e alunni ho costantemente affrontato problemi attuali ; spesso quotidiani alla mano e riferimenti letterari ” vicini” al loro mondo. Solo così può “agire” la scuola .
Le arringhe grondanti di retorica e frementi di indignazione possono far colpo, ma non è con esse che si può disinnescare l’operazione politico-ideologica con cui, attraverso l’uso strumentale dell’attenzione al femminicidio e alla violenza di genere, si tende a far passare politiche repressive funzionali alla svolta reazionaria in corso a livello nazionale, europeo e mondiale. La risposta che il potere dominante e l’opposizione subalterna e connivente dànno al cosiddetto “femminicidio”, che fra l’altro nel nostro paese, contrariamente a quanto fa supporre il pompaggio mediatico con cui viene gonfiato, rappresenta, nel campo dei reati, una delle percentuali più basse in Europa, è infatti di tipo penale e corporativo, ad un tempo vittimizzante e infantilizzante: le donne vengono considerate come esseri fragili da proteggere di fronte ad aggressioni brutali dovute non si sa bene a quali ‘raptus’ e, quindi, ignorando completamente la natura strutturale della violenza, non solo di genere, di cui è satura una società fondata sulla competizione e sul profitto. Si tratta di un’impostazione buonista che, mentre non recherà alcun vantaggio alle vittime della violenza, alimenterà un odio ancor più forte nei riguardi del genere femminile. Basti pensare che nel comune sentire sta passando il discorso secondo cui le donne sono la rovina della famiglia, i mariti devono vivere in miseria dopo la separazione e ad essi vengono negati i figli che i giudici assegnano sempre alla compagna ecc. ecc., ignorando bellamente che, se tutto ciò accade, non è certo colpa della donna, ma semmai di una società che dà stipendi da fame, nonché insicurezza e precarietà generalizzate: una società i cui organi di governo (dall’esecutivo al sistema dei ‘mass media’) usano il discorso e la pratica dei diritti e delle tutele ponendo fra parentesi il fatto che “il diritto non può mai essere più elevato della condizione economica e del grado di civiltà sociale che vi corrisponde” (K. Marx, “Critica del programma di Gotha”). Pertanto, la lotta per la liberazione della donna non può essere né concepita in modo corporativo, poiché sarebbe destinata alla sconfitta, né ridotta ai buoni propositi educativi, poiché si perderebbe nelle brume di una ‘cattiva infinità’, né tradotta in qualche articolo di legge, poiché nelle condizioni attuali la codificazione penale dei reati connessi alla violenza di genere servirebbe soltanto ad un uso repressivo. Essa ha un senso non velleitario soltanto se viene integrata in una lotta più generale, economica politica morale culturale, degli sfruttati e degli oppressi, il cui scopo sia quello di trasformare, insieme con la società, la qualità stessa della vita e, dunque, delle relazioni tra l’uomo e la donna.
Vi seguo sempre, ma è la prima volta che sento la necessità di partecipare alla riflessione. Anche io nel mio piccolo (sono un’insegnante di lettere della scuola media) ho scritto un articolo, che per certi versi rispecchia il tono di questo di Emanuela Bandini, sul sito web della mia scuola (l’occasione era la conclusione di un mese di attività di lettura). Giro qui il link per chi avesse curiosità di leggerlo.
http://www.istitutocomprensivobitritto.it/novembre-un-mese-di-letture-e-di-riflessioni-ioleggoperche-libriamoci-premio-giulitto/