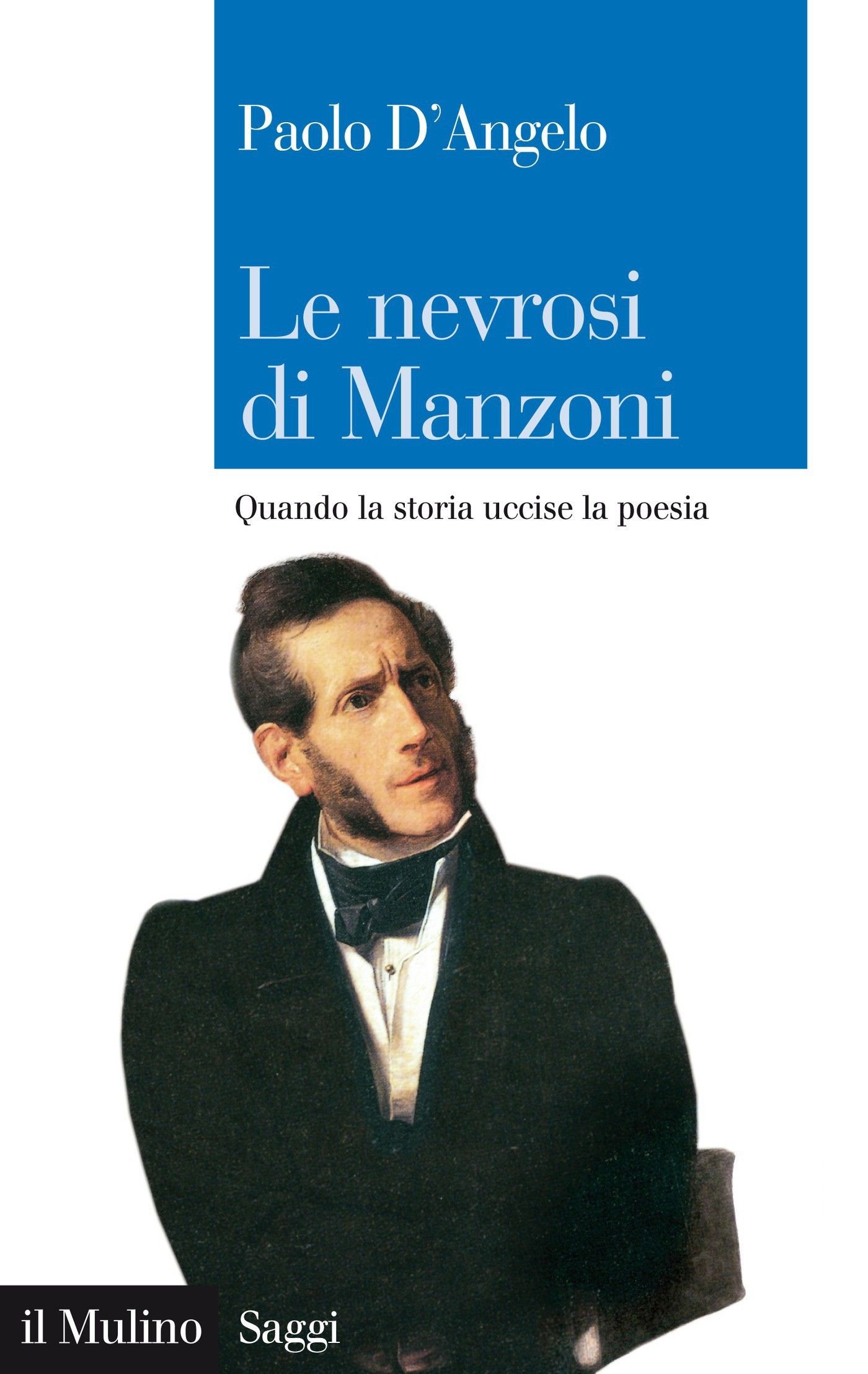
Su Paolo D’Angelo, Le nevrosi di Manzoni. Quando la storia uccise la poesia
Alessandro Manzoni, nato nel 1785, lasciò questo mondo a ottantotto anni, dopo aver seppellito quasi tutti i molti famigliari, figli compresi, che aveva stretto a sé tutta la vita a presidio delle sue patologie: l’ipocondria, l’agorafobia, la paura di sentirsi male per strada senza che nessuno potesse soccorrerlo. A quasi un secolo e mezzo dalla sua morte, Manzoni continua a essere – e forse nemmeno abbastanza – uno degli autori più importanti della letteratura italiana – certamente anche il più detestato nelle classi scolastiche, secondo un curioso destino che per esempio non riguarda l’altro autore “obbligatorio”, cioè Dante. Perché questa centralità? Possono esserci risposte varie, ma almeno un dato è chiaro e letterale: Manzoni merita di essere un classico anzitutto perché ha scritto I promessi sposi (1827 e 1840-42); certamente non sarebbe così famoso se avesse composto soltanto le tragedie, Il cinque maggio, o le opere di teoria letteraria, tra cui il trattato Del romanzo storico. Tale ovvietà merita di essere ripetuta, e si sente per l’appunto il bisogno di scriverla dopo aver letto il libro di Paolo D’Angelo Le nevrosi di Manzoni.
D’Angelo insegna Estetica, e ha scritto testi belli e fondativi – per esempio L’estetica del Romanticismo o Estetica e paesaggio. In questo volume, l’autore spiega il silenzio creativo manzoniano successivo al romanzo attraverso due argomenti: il primo è quello hegeliano della morte dell’arte, a vantaggio della storia, che conquista sempre più serietà e attendibilità, nel caso di Manzoni; il secondo argomento, anticipato dal titolo e ripercorso ottimamente nel secondo capitolo attraverso la ricostruzione delle testimonianze e delle fonti, è invece quello del temperamento nevrotico manzoniano: l’approdo alla verità religiosa e al bello ideale diventano, in questa chiave, la risposta al «bisogno di trovare dei punti fermi, delle basi di appoggio che impediscano di perdersi nel terrain vague dell’immaginazione» (p. 194).
Anche se l’autore dichiara di non voler offrire un contributo di critica letteraria, certamente possono giovare allo studio di Manzoni i due meriti principali del libro, vale a dire da un lato la riconferma, condotta attraverso la discussione dei documenti di poetica e di teoria, di quanto la scelta di non scrivere un altro romanzo certamente non possa essere intesa come l’arresto di qualcuno «che ha perso il passo con la storia» (p. 14); dall’altro lato, ridiscutendo il rapporto storia/invenzione dallo sguardo di oggi, con passaggi e raffronti spesso sorprendenti o magari anche ellittici, ma in ogni caso appassionati, D’Angelo dimostra come la tensione tra i due poli attesti, una volta di più, la modernità di uno tra i narratori più significativi della letteratura europea ottocentesca. D’altra parte Le nevrosi di Manzoni induce a riflettere, oltre che sullo scrittore affrontato, sui rischi che può correre la teoria quando, per eccesso di passione argomentativa, metta troppo da parte l’esperienza del testo – la prima citazione dai Promessi sposi, per dire, arriva a metà del libro, a p. 97, e ne seguiranno due o tre in più e basta. Ma un conto è non considerare uno scrittore e la sua opera in una dimensione esclusivamente letteraria; un conto è scavalcare del tutto tale dimensione. In generale, questa rimozione potrebbe talvolta anche ingannare – chi leggerebbe Zola, se dovesse fidarsi soltanto degli scritti di teoria? e in più la teoria non sta solo fuori dal racconto. Al tempo stesso, nel caso particolare dell’autore dei Promessi sposi l’invenzione non è tanto e solo un problema estetico o morale, ma letterario, nel senso più concreto dell’espressione, come hanno ben capito i molti autori novecenteschi che hanno amato Manzoni proprio per la sua straordinaria ostinazione a sporcarsi le mani d’inchiostro, ossia a tradurre in pratica di stile, correggendo, rifacendo, riscrivendo, l’idea per cui forme false e falsamente ripetute diffondono false idee.
Creatività e immaginazione, intesa come espressivismo, sono allora situazioni inconciliabili per Manzoni, è vero, ma è vero non solo per ragioni nevrotiche, ma perché proprio attraverso l’esperienza dei Promessi sposi l’autore dimostra quanto simile binomio sarebbe ingenuo. L’invenzione, allora, non è solo una proiezione persecutoria del falso, ma è la “dicitura”, l’attenzione agli effetti di prospettiva o di ironia, la capacità, insomma, di aver scritto un capolavoro nel genere del romanzo storico non per aver semplicemente usato la storia, ma per aver inventato un impasto artistico tutto speciale, capace di raccontare una storia così elementare come quella di una condizione di sopruso politico, escogitando un’inquadratura di avvio così portentosa come l’assalto fisico ed emotivo della paura e della forza da cui è attaccato don Abbondio. {module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento