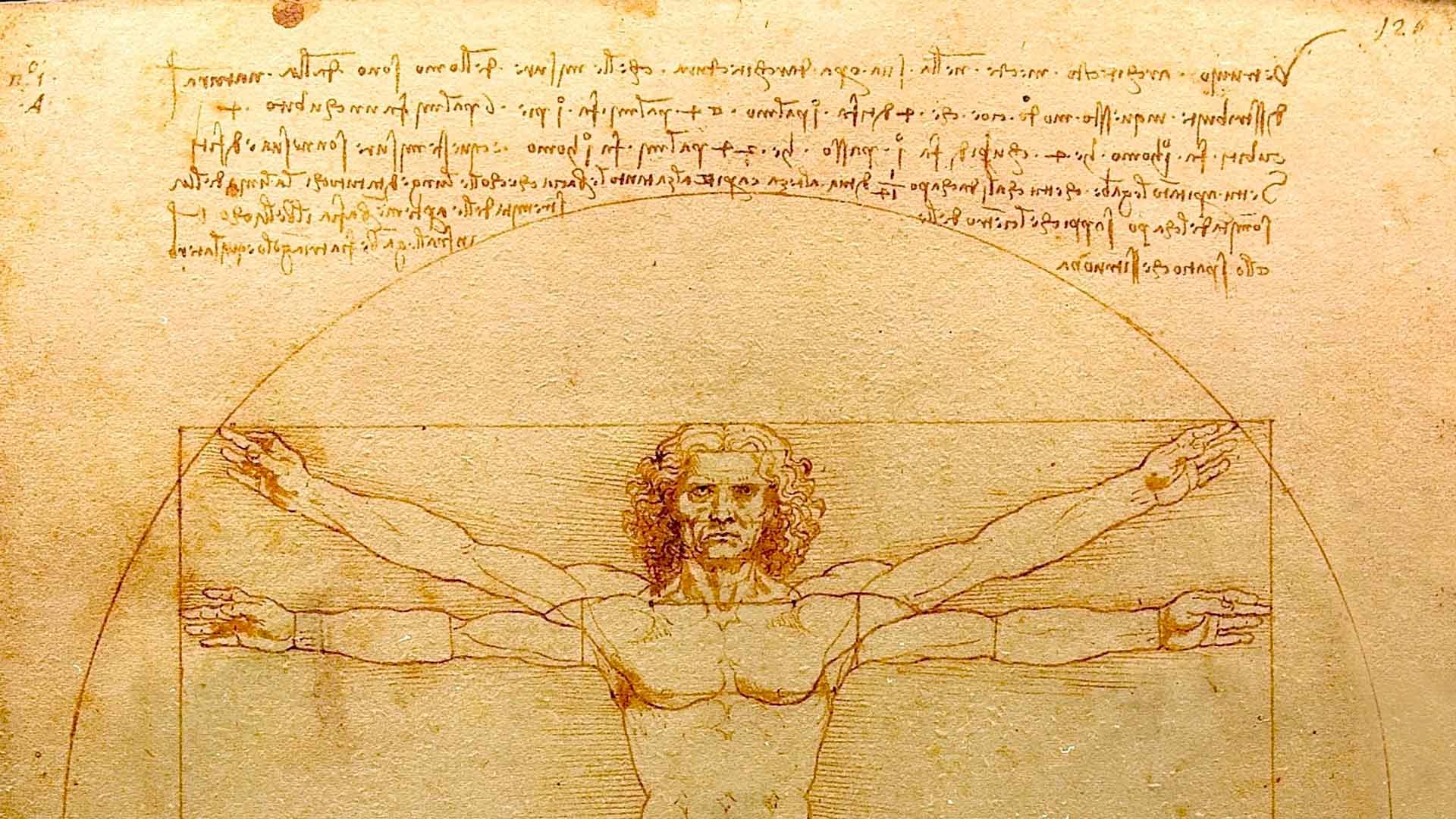
Del senso comune perduto. Rivisitazione di due libri troppo fortunati: Morin, La testa ben fatta; Nussbaum, Non per profitto /2
Pubblichiamo la seconda parte dell’intervento su La testa ben fatta e Non per profitto (la prima parte si può leggere qui), contenente un’analisi del libro di Martha Nussbaum e una conclusione comune.
***
Se La testa ben fatta di Morin è ormai un classico sull’interdisciplinarità, Non per profitto di Martha Nussbaum appartiene al florido genere della “difesa della cultura umanistica”. Il libro non contiene in effetti osservazioni molto originali o profonde sull’arte e la letteratura; è però interessante perché ne inquadra i compiti formativi entro la discussione di un più ampio problema etico (l’autrice è una filosofa morale): quello della «vita buona», degna di essere vissuta, della filosofia classica. Intorno a questo tema si manifesta peraltro la convergenza più evidente con l’altro autore: l’arte è lo strumento principale per l’espressione e la realizzazione di una «sensibilità simpatetica» (Nussbaum) e di un’«etica della comprensione umana» (Morin).
Difesa della cultura umanistica: pensiero critico, arte, cittadinanza globale
Il discorso di Nussbaum tiene insieme la dimensione pedagogica e quella etico-politica, ma non è privo di risonanze che potremmo definire spirituali, anche se di una spiritualità laica e immanente:
«Se l’autentico scontro di civiltà è, come io credo, uno scontro interno all’anima di ciascuno di noi, dove grettezza e narcisismo si misurano contro rispetto e amore, tutte le società contemporanee sono destinate a perdere a breve la battaglia, se continueranno ad alimentare le forze che inevitabilmente portano alla violenza e alla disumanità e se negheranno appoggio alle forze che educano alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza» (p. 154).
La triade dei saperi di una cultura umanistica all’altezza dei nostri tempi è per la studiosa composta da:
- logica, intesa come cura dell’arte dell’argomentare (in senso socratico, dialettico e fortemente anti-sofistico);
- letteratura e arti, utili allo sviluppo di un’«immaginazione narrativa» capace di far assumere il punto di vista altrui e di garantire così empatia e socialità;
- saperi fattuali come la storia globale e la cittadinanza del mondo, per uscire dalle angustie delle tradizioni culturali nazionali e aprirle allo studio dell’altro e delle minoranze.
Il nesso tra umanesimo e democrazia è per Nussbaum costitutivo e la democrazia va intesa nel senso più ampio possibile: come istituzione politica, come bene collettivo, come atteggiamento interiore di ragionevolezza e fraternità.
Il punto di vista è limpidamente illuminista e razionalista: difesa di una «cultura del dissenso individuale [e] della responsabilità» che metta in discussione autorità e tradizione, inesausta discussione di idee attraverso un metodo di apprendimento socratico.
Le forze che ostacolano la realizzazione di questa idea di mondo sono anch’esse forze contemporaneamente interiori ed esteriori: la «grettezza» e il «narcisismo» di cui parla Nussbaum sono tanto qualità dell’animo quanto forze sociali che si concretizzano in precisi imperativi economici, quelli del «profitto» citato nel titolo dell’opera.
La cultura umanistica è “attiva” o “passiva”?
Il filo argomentativo del libro si dipana intorno a una opposizione diffusissima in molti discorsi sull’educazione: quella tra una scuola della libertà e dell’autonomia e una scuola del conformismo e dell’obbedienza.
Parlando dell’attuale sistema scolastico e universitario indiano, immemore della millenaria tradizione culturale e spirituale del paese ed esclusivamente concentrato sulle assai più produttive discipline STEM (Science Technology Engineering and Mathematics), Nussbaum denuncia il dilagare di una formazione «per il profitto», che viene da lei associata da un lato allo studio manualistico, dall’altra al superamento di esami nazionali standardizzati, entrambe pratiche che producono conformismo e passività. Nella tradizione dello stesso paese la studiosa trova però un modello pedagogico opposto: quello di Rabindranath Tagore, fondato su uno sviluppo olistico delle potenzialità umane, attento a privilegiare soprattutto la creatività, la libera espressione di sé, l’equilibrio psicologico e fisico, da cui viene l’importanza riconosciuta al canto e alla danza.
Benché non ci sia perfetta simmetria tra i due paesi, lo schema funziona anche per gli Stati Uniti: da un lato la deriva verso una valutazione standardizzata ossessiva, la priorità attribuita alla sfera cognitiva a detrimento di quella sociale ed emotiva, la finalità esclusiva della produzione di lavoratori efficienti e competitivi; dall’altro lato l’attivismo di John Dewey, modello pedagogico certo più laico di quello di Tagore ma non meno attento allo sviluppo equilibrato di tutte le facoltà umane nella stessa direzione di libertà, autonomia e creatività dell’indiano.
Ma in questa polarizzazione le connotazioni di “attivo” e “passivo” – più intuitive e morali che propriamente analitiche – tendono ad appiattire questioni diverse in una stessa visione prospetticamente deformata. In effetti andrebbe dimostrato che il nozionismo nel campo dei contenuti didattici, la standardizzazione nella valutazione, il conformismo di una scuola che miri alla sola riproduzione sociale della forza lavoro, la priorità riconosciuta alle materie tecnico-scientifiche, l’invadenza dell’economia, siano fenomeni tra loro solidali e opposti a una formazione di stampo umanistico. D’altro canto Nussbaum, proponendo l’insegnamento di Tagore e Dewey come cultura umanistica tout court, stabilisce un’equivalenza, per non dire una identificazione perfetta e senza ulteriori residui, tra la pedagogia dell’indiano e dell’americano e la cultura umanistica: identificazione non solo discutibile ma anche involontariamente surrettizia.
Consideriamo un contesto come quello italiano. Nel nostro paese le rilevazioni nazionali e internazionali standardizzate e il costrutto di competenza ad esse associato – costrutto che per la propria ambiguità semantica e concettuale continua a prestarsi sia a interpretazioni economicistiche sia di sviluppo delle capacità umanei – vengono presentate da molti riformatori come forze del campo “attivo”, capaci di scardinare il contenutismo inerte delle varie “storie della…” caratteristiche della tradizione didattica dell’umanesimo italiano. Insomma, la divisione delle forze in campo è forse meno simmetrica di quanto non pensi Nussbaum.
Come detto, la filosofa si rifà alla tradizione deweyana. Tuttavia Dewey è stato anche un critico della tradizione umanistica, all’inizio del secolo scorso, perché la considerava elitaria e portatrice di una scissione tra teoria e pratica.ii L’identificazione tra attivismo democratico e umanesimo è meglio giustificata dalla storia della scuola americana, ma è decisamente più problematica per l’Europa (per la presenza di Dewey e prima di lui del riformatore Horace Mann, per il fatto che l’America nasca come democrazia fin dalle origini, per il minor peso rispetto all’Europa delle aristocrazie intellettuali, …). La semplificazione nussbaumiana rischia di dare per risolto e aproblematico un rapporto che invece è dialettico, a volte teso, e che continua ad essere una spina nel fianco per la scuola di massa: si pensi soltanto alla perdurante contrapposizione didattica tra laboratorio (attivistico, deweyano) e lezione (trasmissiva, umanistica), discussione che alle proprie spalle cela un più profondo conflitto su quale sia il rapporto – per usare il lessico di Dewey – tra sapere, pensare, fare. La relazione reciproca tra queste tre operazioni nell’attivismo e nell’umanesimo tradizionalmente inteso non è affatto la stessa. Indipendentemente dalla posizione che assumiamo nel dibattito, di dibattito ancora aperto si tratta e occorre impostarlo correttamente: ne va della comprensione della scuola e, per quel che più ci interessa ora, di una definizione di umanesimo non unilaterale.
Educare e istruire
In Non per profitto si tende a proiettare con troppa facilità problemi e pratiche del sistema americano sui sistemi europei e dell’accademia sui gradi inferiori di scuola, rimescolando tutto nel calderone di un umanesimo globalizzato un po’ astratto e perbene:
«un altro problema delle università europee e asiatiche è [che in esse] non trovano ancora lo spazio necessario nuove discipline di particolare importanza per una buona cittadinanza democratica. I women’s studies, lo studio di razza ed etnicità, gli studi ebraici e islamici: sono tutti marginali» (140).
Addirittura, in un altro passo, l’assenza di questo genere di studi nei curricoli europei sarebbe chiaro indizio di quella censurabile cultura del profitto ostile alla cultura umanistica. Qui però Nussbaum confonde cause ed effetti. Ovviamente l’attuale trasformazione delle università in imprese volte alla produzione di sapere utile ha aggredito prima di altre le facoltà umanistiche, ma la scarsa presenza dei cultural studies nelle università europee dipende innanzitutto dalle diverse tradizioni intellettuali e didattiche: è avventato, e forse anche un po’ presuntuoso, credere che per questa assenza i nostri sistemi scolastici e accademici non siano comunque stati in grado di fornire agli europei una coscienza critica democratica. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una identificazione surrettizia: l’educazione alla cittadinanza globale finisce per coincidere con il programma di decostruzione della tradizione occidentale degli studies dei dipartimenti di letteratura delle università americane, risolvendosi totalmente in esso.
Non c’è alcun dubbio che non si dia democrazia senza pluralismo e inclusione dei punti di vista di tutti. Ma tali punti di vista e prospettive “altre” non possono essere semplicemente evocati, vanno pazientemente inverati. Perché gli studi sulle donne, la razza, l’etnicità, l’islam e l’ebraismo e molti altri penetrino nella cultura scolastica, bisogna preoccuparsi di un processo di traduzione da un livello all’altro del sistema. Se all’accademia spetta infatti la definizione (o la ridefinizione, o il sovvertimento) dei contenuti delle discipline, a scuola si studiano materie, che non coincidono con le prime né ne sono una semplice “applicazione” pratica, perché ne sono semmai una riconfigurazione passata al vaglio delle necessità pedagogiche e didattiche. In una parola: un cambio di paradigma non si improvvisa, nemmeno se è urgente per la democrazia e la convivenza civile. Forse una cosa che l’umanesimo (“tradizionale”, se significa qualcosa) può insegnare è proprio che la cultura e i suoi processi storici sono lenti e faticosi, nascono da dialogo e conflitto, e questi processi non possono essere “saltati” per volontà di riforma.
Non a caso, nella sociologia della scuola sono state coniate formule come «pedagogia cous cous» e «multiculturalismo delle 3 S» (Saris, Samosas and Steel band: rispettivamente le vesti e la cucina indiana e gli strumenti a percussione caraibici), per indicare tentativi di educazione interculturale che hanno finito per ridurre la conoscenza dell’altro all’invito a portare a scuola oggetti delle “propria” tradizione, con un involontario effetto di orientalismo.
Per ampliare il pluralismo culturale nell’accademia serve, in fondo, molto poco: la creazione di una cattedra in studi islamici, la sua attribuzione a un esperto nel campo. A scuola il rischio di stemperare o di involgarire questo processo di arricchimento culturale in una pedagogia del cous cous è alto perché dalla scuola contemporanea si pretende un rapido adeguamento alle necessità civiche dell’“attualità” e delle trasformazioni sociali e politiche (per poi irriderla o criticarla quando non è in grado di adeguarsi), dimenticando che la conoscenza – dell’altro, in questo caso – non si improvvisa. La cultura umanistica può resistere aristocraticamente o può buttarsi entusiasticamente nel gorgo, morendo di sterilità nel primo caso e dimenticando totalmente se stessa nel secondo: oppure può mediare, aprendosi a nuove esigenze educative ma ricordando a se stessa la propria pensosa lentezza e complessa cautela.
Non voglio fare il torto a Nussbaum di insinuare che questo non sia anche il suo obiettivo. Tuttavia nel suo libro l’ansia di fornire una patente di nobiltà umana alla cultura umanistica, in un mondo che si “disumanizza”, la fa tralignare dall’equilibrio sempre necessario tra l’educare e l’istruire:
«Non si può educare senza insegnare: l’educazione senza istruzione è vuota, e tende a degenerare molto facilmente in una retorica di tipo etico-sentimentale. È invece molto facile insegnare senza educare, e si può continuare a imparare fino alla fine dei propri giorni senza per questo diventar colti» (Hannah Arendt, La crisi dell’istruzione, in Tra passato e futuro, 1968).
Eticizzare l’insegnamento
Sono ingiusto quando affermo che nel libro di Nussbaum la cultura umanistica scade in una «retorica di tipo etico-sentimentale»?
Per la filosofa una funzione fondamentale dell’arte e della letteratura sarebbe quella di lavorare «sulle zone d’ombra culturali» e su «precise aree di disagio sociale» (p. 123). Se la vocazione della cultura umanistica è da sempre quella di studiare le pieghe dell’animo umano, questo linguaggio da assistente sociale o psicologo lascia perplessi; d’altra parte sappiamo bene quanto la reazione verso questi usi strumentali della letteratura sia sempre a rischio di scadere nell’idealismo dello studio “disinteressato” degli otia, con tutto il ben noto portato aristocratico di privilegio. Ma il programma della filosofa sembra essere esente da un dubbio del genere:
«ci sono tante opere d’arte che stimolano simpatie inopportune. I bambini a cui si chiede di allenare l’immaginazione leggendo letteratura razzista, o coltivando l’oggettivazione pornografica della donna, non crescono certo in maniera consona alla cittadinanza democratica, e non si può negare che i movimenti antidemocratici sappiano bene come utilizzare arte, musica e retorica per contribuire a umiliare e stigmatizzare ulteriormente certi gruppi e persone. […] Queste forme deleterie di “letteratura” operano inibendo ogni accesso immaginativo alla posizione stigmatizzata – trattando le minoranze, o le donne, come semplici oggetti senza uno spessore che valga la pena conoscere», (p. 123-124).
È vero, avremmo bisogno di moltiplicare i nostri accessi immaginativi anche alle posizioni stigmatizzate. Ma il congiunto divieto di certi contenuti confligge in modo plateale con questa funzione ed opera piuttosto come rimozione del male che come sua conoscenza. Come ho già detto, spesso Nussbaum non distingue quali delle proprie osservazioni vadano applicate alla scuola primaria, quali alla scuola secondaria, quali all’università: da qui nascono incongruenze come l’immaginare che a dei «bambini» vengano proposti contenuti in cui la donna (a scuola?) è oggettivata «pornograficamente».
Di che cosa si parla in questo passo? Della Capanna dello Zio Tom da cui negli Stati Uniti è stata espunta la parola “negro” nelle edizioni scolastiche? Della pubblicità e della tv? Della propaganda politica della destra wasp? Della violenza e del sessismo dei video rap? Della precoce sessualizzazione delle starlette bambine della Disney? Di tutto questo probabilmente, forse anzi di qualcosa di ancora più grande: di un intero sistema culturale, di un mondo, di una civiltà. Se la parola “negro” rischia di produrre scandalo o conflitto in una scuola elementare, nessuna antipatia verso il politicamente corretto mi convincerà che non sia saggio rimuoverla. All’università e nelle scuole superiori potremo parlarne senza censure e rimozioni? Leggendo Non per profitto, non l’ho capito.
Ma quel che conta è domandarsi: che cosa c’entra la cultura umanistica? Essa sembra essere brandita come un baluardo contro la barbarie. Peccato che, da un lato, essa non sia così efficiente come arma politica; dall’altro, addomesticata tramite la rimozione di quanto di scandaloso contiene, semplicemente non è più cultura umanistica, ma catechismo.
Conclusione
Di fronte ai processi caotici e accelerati che la conoscenza subisce nella tarda modernità, il senso di smarrimento nella scuola è grande ed è comprensibile cercare delle bussole. Con questa disamina parallela dei libri di Morin e Nussbaum ho cercato di mostrare che alcune di queste bussole, purtroppo, non funzionano come spereremmo. L’interdisciplinarità del francese è un marchingegno complicato che difficilmente può essere di qualche utilità nella quotidiana pratica didattica; l’umanesimo di Martha Nussbaum è pieno di buone intenzioni, e il problema è proprio questo.
La scienza della complessità di Morin ha avuto una larga eco in un momento, la fine del secolo scorso, nella quale ogni paradigma era perduto; l’umanesimo della Nussbaum cerca in effetti di dare una risposta all’altezza di una (auspicata e auspicabile) società globale pluriculturale e aperta. Continuiamo a leggere il più possibile, a nutrirci di teoria e di riflessioni (leggiamo, ci mancherebbe, anche Nussbaum e Morin): ma non dimentichiamo che noi insegnanti facciamo cultura in una dimensione rasoterra e artigianale, in cui anche gli altisonanti concetti devono prendere la più prosaica forma del senso comune, in cui viviamo ogni giorno per il semplice fatto di entrare in classe. O meglio: forse noi lo ricordiamo. Dovrebbero ricordarlo anche gli intellettuali e i decisori politici.
i Su questo confronta gli interventi di Gianni Marconato e Rosario Paone su questo blog.
ii Sui contorni storici di questa polemica, cfr. il capitolo relativo a Dewey nel recente libro di Massimo Baldacci, La scuola la bivio. Mercato o democrazia, Franco Angeli, 2019.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento