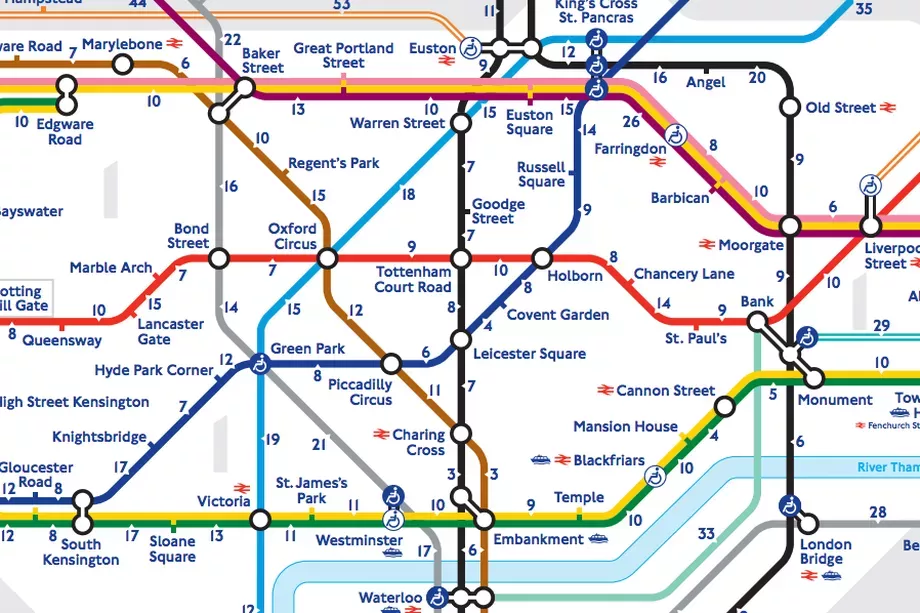
Del senso comune perduto. Rivisitazione di due libri troppo fortunati: Morin, La testa ben fatta; Nussbaum, Non per profitto /1
Questo intervento è diviso in due parti. Questa prima parte contiene un’introduzione comune ai due libri in oggetto e un’analisi del saggio di Morin; la seconda parte, che uscirà nelle prossime settimane, conterrà un’analisi del saggio di Nussbaum e una conclusione comune.
Anniversari
Il 2020 è l’anniversario di due libri che continuano ad avere una buona accoglienza nelle bibliografie sulla scuola; il secondo di essi, poi, quando studiavo da insegnante, passava per inaggirabile bibbia e le idee del suo autore sono state recepite in Italia nelle Indicazioni nazionali per la primaria, nella sezione «Per un nuovo umanesimo» (basterebbe un confronto stilistico, se non altro).
Non per profitto di Martha Nussbaum usciva per Il Mulino nel 2010, La testa ben fatta di Edgar Morin esattamente dieci anni prima per Raffaello Cortina Editore (l’edizione francese è del 1999).
Torno a rileggerli oggi non tanto per l’esteriore coincidenza del doppio anniversario, quanto perché vorrei riflettere sul significato del credito loro riconosciuto. La ricerca di un nuovo paradigma interdisciplinare da parte di Morin e la difesa della cultura umanistica di Nussbaum sono temi importanti. Ma confesso che le risposte e le proposte di questi due importanti intellettuali mi hanno convinto poco dalla prima lettura: c’è in entrambi un eccesso di buone intenzioni, una mancanza di materialismo e buon senso, una generalità di proposte che scade involontariamente nella genericità, un certo – tocca dirlo – velleitarismo politico. Ma sparare su un grande perché un po’ di polvere cada anche su di me sarebbe una ragione ben meschina per intraprendere la critica di un libro. Perciò aggiungo subito che sono convinto che questi difetti possano essere ritrovati in buona parte dei discorsi sulla scuola e sui saperi di tutti noi, perché tutti parliamo a partire da una condizione di impotenza: ma, come è noto, è molto più istruttivo spiare le tracce di questa impotenza tre le cime più alte.
L’interdisciplinarità come chiave universale
La frase “la testa ben fatta e non ben piena” che Morin riprende da Montaigne non è che una delle molte formulazioni di un principio pedagogico ben noto. Quanto inchiostro si è versato e versiamo su di esso. Che cosa ha aggiunto Morin a questo dibattito tanto da far spiccare il suo libro su molti altri? Egli sembra fornire il balsamo per suturare la scissione tra le due, anzi tre culture – scienze naturali, scienze umane, cultura umanistica – e soprattutto per ricomporre una condizione dei saperi esplosa in minutaglie iperspecialistiche. Non c’è disciplina per la quale egli non trovi una collocazione nel proprio coerente paradigma reticolare ed ecologico, fatto di sistemi autoregolantisi, di sistemi di sistemi connessi da fasci di azioni e retroazioni, e in cui un principio ologrammatico di rispecchiamento del tutto in ciascuna parte, e di ciascuna parte nel tutto, garantisce che la competenza acquisita in uno qualsiasi dei nodi consenta lo sviluppo della totalità dei saperi: «l’iperspecializzazione impedisce di vedere il globale (che frammenta in particelle) così come l’essenziale (che dissolve)» (p. 13).
L’enfasi posta sulle facoltà globali di contestualizzazione e interconnessione, in opposizione a un paradigma cartesiano fondato sulla scomposizione analitica in componenti elementari, sembra dare il colpo di grazia al nozionismo che tritura il vivo sapere in cellule morte e inservibili. L’omologia, non solo metaforica ma letterale, tra «pianeta fisico […] biosfera e […] umanità» (p. 46) sembra garantire la possibilità di ricomporre la scissione tra res extensa e res cogitans, dando un venatura etica e umanistica ad ogni disciplina: «un modo di pensare capace di interconnettere e di solidarizzare delle conoscenze separate è capace di prolungarsi in un’etica di interconnessione e di solidarietà tra umani» (p. 112).
Insomma l’interdisciplinarità, con Morin, prende la forma non di un generico invito a tentare qualche connessione tra le discipline, a collaborare con qualche collega: si tratta di una riforma «non programmatica, ma paradigmatica». L’idea di «riformare le menti», di ritrovare un «paradigma perduto», di intridersi di un sapere che si fa mobile strategia e felicità della scoperta non lascia in effetti indenni dalla fascinazione: «il nostro insegnamento tende al programma, mentre la vita ci chiede strategia e, se possibile, anche serendipità e arte» (p. 72).
Quello che semmai piace meno a chi continui a difendere prima di ogni altra cosa le ragioni del senso comune è il tono profetico e avanguardistico di Morin. La riforma del pensiero è difficile perché si tratta di un’impresa radicale e nuova, che incontrerà prevedibili resistenze. Per questo occorrerà partire da minoranze marginali, devianti e magari “perseguitate” «di educatori, animati dalla fede nella necessità di riformare il pensiero e di rigenerare l’insegnamento» (p. 117). Quest’ultimo è «un compito di salute pubblica: una missione», fondato su tre impulsi «Eros → missione → fede» che «costituisce il circuito ricorsivo della trinità laica, in cui ciascun termine alimenta l’altro» (p. 118). Sarà che chi accetta di insegnare in quell’enorme pachiderma che è la scuola di Stato e ne porta sulle spalle tutto il grigio dei doveri quotidiani ha sempre un po’ di antipatia per chi si smarca; sarà piccineria piccolo-borghese magari, non posso negarlo. Ma preferisco un linguaggio più laico e meno incline a vezzeggiare il nostro desiderio di sentirci minoranza speciale e più intelligente del resto del gonzo pecorume. È, credo, un modo per essere sinceri democratici.
La chiave universale in mano agli insegnanti
Ecco il programma di Morin per la scuola primaria. Con i bambini occorrerà partire da domande come
«cos’è l’essere umano? La vita? La società? Il mondo? La verità? […] È interrogando l’essere umano che si scoprirebbe la sua natura duplice, biologica e culturale. Da una parte, si acquisirebbero le basi della biologia; da lì, dopo aver colto l’aspetto fisico e chimico dell’organizzazione biologica, si inquadrerebbero i domini della fisica e della chimica, e poi le scienze fisiche ci porterebbero a collocare l’essere umano nel cosmo. Dall’altra parte si scoprirebbero le dimensioni psicologiche, sociali, storiche della realtà umana. Così, dal principio, scienze e discipline sarebbero collegate, ramificate le une alle altre e l’insegnamento potrebbe fare la spola tra le conoscenze parziali e una conoscenza del globale. […] Si dovrebbe raccontare l’avventura cosmica come la possiamo attualmente delineare (indicando ciò che è ipotetico, ciò che è ignoto, ciò che è misterioso), la formazione della particelle, l’agglomerazione della materia in protogalassie […]» (pp. 88-9),
per poi arrivare a descrivere il processo di ominizzazione, grazie al quale si introdurranno i problemi della cultura, del pensiero, del linguaggio. Morin qui segue il filo di un’idea che in lui è centrale, per cui per superare la frattura tra studio della natura e studio dell’uomo occorre indagare il punto in cui natura e cultura, animalità e umanità insieme si scindono e si suturano.
Nella secondaria «i programmi dovrebbero essere sostituiti da guide d’orientamento che permettano agli insegnanti di situare le discipline nei nuovi contesti: l’Universo, la Terra, la vita, l’umano» (p. 92). E così via.
Morin si muove perennemente su di un piano metadiscorsivo, in cui la cornice conta sempre più dell’oggetto incorniciato e l’organizzazione e la struttura occupano tutto lo spazio del pensabile. Egli critica «la sofisticazione, la formalizzazione e l’astrazione» in quanto procedimenti di conoscenza deteriori e preferisce di gran lunga «la capacità di contestualizzare e di globalizzare»: ma la pretesa di sistematizzazione e coerente organizzazione dei saperi si impone su tutto in modo piuttosto minaccioso, come se ogni esperienza di apprendimento dovesse sempre sollevarsi dal proprio parziale e semicieco contesto tirandosi da sola per il codino, come il barone di Münchausen dalle sabbie mobili. Viene il sospetto che la difesa di un sapere insieme materiale e mentale, incarnato e capace di slancio trascendente oltre se stesso sia un effetto di puro verbalismo. Nonostante Morin sia un lettore attento di poesia, forse non ricorda il memento tragico di Mallarmé: ahimé, ho letto tutti i libri, ma la carne è triste. Si potrebbe avere una prova indiretta di questa involontaria astrattezza badando alla quantità di verbi al condizionale nelle pagine de La testa ben fatta: i “si dovrebbe”, “si potrebbe” non si contano.
Il suo approccio olistico e cibernetico, in cui il complesso precede il semplice, e non viceversa, pretende di costituire dei quadri di riferimento generali come atto preliminare, e finisce così per attribuire a maestre e maestri prima e a insegnanti della secondaria poi, compiti che sono vertiginosi anche per chi è in possesso di saperi teorici e strumenti di ricerca sofisticatissimi. Morin infatti è costretto a riconoscere il carattere costitutivamente iperspecialistico dei saperi attuali e la conseguente difficoltà obiettiva che gli stessi esperti e scienziati trovano a dialogare con i loro pari dentro l’accademia e nei luoghi di ricerca. Eppure quello che risulta ancora solo auspicato ma difficile ai più alti ordini della scienza, dovrebbe, a suo dire, cominciare a concretizzarsi nella scuola primaria.
Quanto poi alla ricongiunzione tra natura e cultura, umano e animale, si potrebbe ricordare che già il nostro Leopardi, nello Zibaldone, osservava che se fossimo in grado di cogliere tale snodo, avremmo risolto tutti i problemi della conoscenza: la differenza con Morin sta nel fatto che l’enciclopedico poeta ne parlava come di una evidente impossibilità, una nostalgia perenne di unità che regge tutta l’architettura del sapere e muove la nostra curiosità; nell’entusiastico epistemologo francese sembra quasi che la data in cui stringeremo fra le mani questo punto infinitamente sfuggente sia prossima.
Quando questo bel programma cerca di concretizzarsi in proposte operative, Morin non trova di meglio che immaginare un «professore di filosofia» o «un insegnante polivalente» (p. 92), che dovrebbe guidare gli insegnanti nel collocare correttamente la propria disciplina nella rete degli altri saperi. Non si pensi a un confronto gratuitamente maligno se dico che la mente è immediatamente corsa a una lettura preadolescenziale, Crociera nell’infinito di A. E. Van Vogt, il cui protagonista era uno scienziato, irriso e marginalizzato dai colleghi iperspecializzati perché insegnava “connettivismo”, una superdisciplina che intendeva porsi da interfaccia di collegamento fra tutte le altre.
Per Morin si tratterebbe anche di «istituire in tutte le Università e in tutte le facoltà una decima epistemologica o transdisciplinare che preleverebbe il 10% del tempo dei corsi per un insegnamento comune che verta sui presupposti dei differenti saperi e sulle possibilità di farli comunicare» (p. 99). Anche in questo caso la mente di un italiano corre a giochi di prestigio orario ben noti (l’ultimo esempio è la recente legge sull’“educazione civica”) o alla nostra malattia tipica, la “commissionite”, per cui di fronte all’evidente incapacità d’azione degli individui o degli organismi già esistenti, ci si rifugia nella supervisione di una ulteriore commissione capace di cogliere dall’alto i nessi che sfuggono a chi è avviluppato in essi, con l’esito certo di moltiplicare, altro che semplificare, i livelli in cui occorrerà prendere decisioni e pianificare operazioni, creando conflitti e impasse.
Noi insegnanti, di fronte a Morin, ci ritroviamo un po’ nello stesso rapporto che intercorre tra i generali de La certosa di Parma e di Guerra e pace e i loro eserciti: dalla specola delle proprie mappe del territorio, i primi studiano piani e strategie, mentre fra fumo, palle di cannone, cavalli e soldati che corrono di qua e di là, Fabrizio Del Dongo e Nikolaj Rostov, che pure avrebbero tutta l’intenzione di dare il proprio contributo a un’impresa eroica, nemmeno capiscono dove si trovino.
Conclusione: nel nome di Montaigne
Quando Morin descrive un insegnante ideale – di filosofia, ma appassionato di letteratura, interessato alle scienze naturali e curioso di tutte le scienze umane – sembra proporre il proprio percorso intellettuale. Nulla di male, anzi: abbiamo bisogno di modelli e maestri. Ma hic Rhodus, hic salta: il maestro non esiste indipendentemente dal contesto. Una figura del genere si dà solo dove c’è prossimità umana, intimità, dialogo reciproco: il cenacolo umanistico, il gruppo elettivo di discepoli, qualche fortunato gruppo classe, …
La curiosità inesausta di Morin ha bisogno di totale libertà: come vincolare a questa libertà le nostre organizzazioni complesse? Morin afferma che
«gli attuali progetti di riforma ruotano intorno a questo buco nero [la necessità di una riforma del pensiero], che risulta loro invisibile. Sarà visibile solo quando saranno riformate le menti. E qui arriviamo a un vicolo cieco: non possiamo riformare l’istituzione senza aver prima riformato le menti, ma non possiamo riformare le menti se non abbiamo preventivamente riformato le istituzioni» (p. 115),
ma pensa che per risolvere il paradosso basti invocare l’evidenza della vita: esso infatti non sarebbe che quel «genere di impossibilità di cui la vita si è sempre fatta beffe» (p. 117). In verità lo iato tra azione del singolo e gabbia d’acciaio dell’organizzazione resta intatto.
I nostri formatori nelle scuole di specializzazione, mettendoci in mano La testa ben fatta, ci hanno perciò suggerito una strada fin troppo velleitaria: la chiave universale di Morin non apre la serratura dell’interdisciplinarità.
L’amore per l’omologia dello studioso nasconde in modo fin troppo evidente che, se anche si realizzasse una maggiore interdipendenza tra le discipline a livello di ricerca scientifica, il salto da questo piano a quello della didattica, dei saperi scolastici, della cultura degli insegnanti, resterebbe comunque un salto quantico tra piani difformi. La realtà è piena di vuoti, di asimmetrie, di asperità inappianabili. Tutto si tiene sempre un po’ troppo nel pensiero di Morin, come tutto simula di tenersi sempre un po’ troppo in tante noiose tirate sull’interdisciplinarità cui noi insegnanti siamo abituati.
Morin è assai più convincente, infatti, in alcune pieghe del proprio discorso: ad esempio quando afferma che la soluzione a certi problemi interni a una disciplina può venire dall’esterno del campo o da semplici amatori, i quali grazie al proprio sguardo vergine sono in grado di vedere ciò che rimane nascosto agli occhi di chi occupa il centro del focus; o ancora, sintomaticamente, ai margini del libro, in una delle appendici (Inter-poli-trans-disciplinarità) dove l’approccio alla conoscenza descritto è realmente imprevedibile, vitale ed anarchico. Ma le pieghe non fanno sistema, e l’imprevedibilità cozza con l’idea stessa di costruire un nuovo paradigma.
In conclusione, credo che Montaigne sia il nume tutelare solo del titolo e assai meno dell’intero libro di Morin. L’autore dei Saggi, che amava certo le teste ben fatte, era però innanzitutto uno scettico, un antisistematico, un sottile umorista: qualsiasi piccola verità affermasse, la pronunciava fra virgolette, con una scrollata di spalle e un sorriso sornione sulle labbra:
«Se poi questo discepolo è di così bizzarra tendenza che preferisce ascoltare una favola piuttosto che la narrazione di un bel viaggio o un saggio ragionamento quando sarà in grado di capirlo; se al suono del tamburino, che eccita il giovanile ardore dei suoi compagni, si volge a un altro che lo invita ai giochi dei saltimbanchi; se per suo gusto non trova più piacevole e più dolce tornare impolverato e vittorioso da un combattimento, piuttosto che dal gioco della palla o dal ballo col premio di quella gara, non trovo altro rimedio se non che al più presto il suo precettore lo strangoli, se non ci sono testimoni, oppure che lo si metta a fare il pasticciere in qualche buona città, fosse anche figlio di un duca, secondo il precetto di Platone per cui bisogna sistemare i ragazzi non secondo le possibilità del loro padre, ma secondo le possibilità della loro anima» (Montaigne, Saggi, «Sull’educazione dei fanciulli»).
A uno così riesce difficile intestare addirittura una “riforma del pensiero”.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento