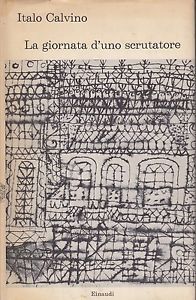
Elezioni e letteratura. Perché rileggere La giornata d’uno scrutatore di Italo Calvino
Perché sottopone il gesto elettorale alla verifica dell’introspezione modernista
Se la svolta nella vicenda intellettuale di Calvino si produsse, come per altri scrittori della sua generazione, a cavallo fra i fatti d’Ungheria e il “miracolo economico”, La giornata d’uno scrutatore (1963) è il racconto-saggio in cui tutta l’esperienza ideologica e narrativa del dopoguerra viene sottoposta alla più aperta e severa verifica critica. Non a caso, il seggio elettorale in cui si svolgono gli eventi è collocato nell’istituzione torinese dove monache e preti custodiscono gli esseri deformi, nati dagli “scherzi della biologia”. L’atto principe della storia democratica (il suffragio universale) qui è posto insomma al cospetto dell’irriducibilità dei “mostri” del Cottolengo.
Il fondamento della vicenda è autobiografico: Calvino si basa su due sue esperienze di scrutatore avvenute durante le elezioni del 1953 e del 1961. Tuttavia, la terza persona e l’invenzione di un protagonista, Amerigo Ormea, permettono di riprodurre mediante l’indiretto libero, i pensieri più nascosti e le argomentazioni più labirintiche e più segretamente dubitative di un personaggio fittizio. La struttura del testo è chiusa e circolare: l’azione si svolge in un solo giorno e in un solo luogo, quasi interamente limitato agli interni del grande ospedale torinese. A proposito di questo testo, con La nuvola di smog e La speculazione edilizia, la critica ha parlato di un “ciclo realistico” opposto al ciclo fantastico della trilogia degli antenati. Ma Amerigo Ormea non è costruito secondo le convenzioni della tradizione realistica ottocentesca: non ne sono descritti l’aspetto fisico, i connotati psicologici, la precisa condizione lavorativa. Ciò che conosciamo di lui è la sua interiorità, la lotta mentale, la ricerca di un senso, disperatamente erosi dal cozzo tra la volgarità della cronaca e l’assoluto della biologia, tra gli abusi elettorali del partito di maggioranza e l’estraneità incosciente dei pazienti reclusi. Amerigo è in tal modo un personaggio schiettamente neomodernista, e il testo s’inscrive nei generi novecenteschi dell’interiorità e del romanzo saggio: il lettore è chiamato a partecipare dell’esperienza problematica delle sue continue digressioni dubitative, a far propri i dubbi sulla biologia, sulla democrazia, sulla storia.
Perché ripropone sullo sfondo piatto della cronaca politica la profondità leopardiana dei “limiti oscuri”
La ricerca vana e accanita di Americo subisce un ulteriore scacco e un vero e proprio affannoso rincaro a partire dal cap. XI dopo il breve ritorno a casa e le discussioni telefoniche con la fidanzata Lia sul tema dell’aborto. Ritornato nel seggio elettorale, si sente infatti “un ultimo erede del razionalismo settecentesco” preso in ostaggio in una città nemica. Nel recinto del Cottolengo, la Ragione laica, nata dai Lumi, si scontra con i “limiti oscuri” del corpo, della biologia. Franco Fortini chiamava “limiti oscuri” gli ostacoli non superabili che la morte, la malattia, il trauma sempre oppongono a ogni progetto umano, anche il più “progressista”. Leopardi, analogamente, valorizzato da Sebastiano Timpanaro, rappresentava nella situazione della Ginestra sulle pendici del Vesuvio questo medesimo tratto radicale della condizione umana. Il punto di vista critico di un intellettuale di sinistra e quello di un onorevole democristiano, giunto al seggio a caccia di voti, sono posti a confronto con quello di un nano, dal cui sguardo urgono tenaci ed enigmatici bisogni elementari. Il protagonista conosce in tal modo i confini corporei e biologici dell’operare umano, con conseguente avvitamento su se stessa di ogni idea progettuale. Il Cottolengo, come il Vesuvio sterminatore, pone al soggetto domande radicali di senso, non eludibili e non oltrepassabili né con la morale laica, storicista e illuminista di Amerigo né con quella cattolica delle monache che accudiscono e accompagnano al voto i reclusi (anche se quest’ultima, grazie al ricorso alla Grazia e alla trascendenza, per un attimo sembra più adatta a render dicibili le infinite sofferenze della carne).
Perché discute il nichilismo con i minimi strumenti dell’umano
Le risposte di senso, nel cuore stesso dell’insensatezza elettorale e biologica, si danno, flebili ma preziose, nei capp. XII-XV, con cui la vicenda dello scrutatore si conclude. Nella zona più nascosta del labirinto del Cottolengo, che ha tratti spaziali di tipo concentrazionario, Amerigo cerca di opporsi con sempre minore convinzione al voto degli ammalati più gravi: esseri dalle “facce viola”, “teste boccute” che latrano o che squittiscono affiorando dai letti. Giunto al centro dell’inferno, gli sembra di essere chiamato non più a sorvegliare sugli abusi elettorali ma a stabilire il confine tra l’umano e il non umano. Nota, in tal modo, un giovanotto deforme e attonito e un vecchio padre con il cappello da contadino, venuto per la visita domenicale, che schiaccia delle mandorle e imbocca muto il figlio: i due sono “reciprocamente necessari”, l’umano – pensa Amerigo – “arriva fin dove arriva l’amore”. Analogamente, nell’ultimo capitolo, mentre pensa ai risultati di quel voto e prevede un’involuzione della società italiana, scorge in cortile alcune donne grasse che spingono allegre un carrello ingombro di fascine per la zuppa: “anche la città dell’imperfezione” – pensa – “ha la sua ora perfetta. L’attimo in cui diventa la Città”.
Far uso di questo testo nell’orizzonte d’attesa attuale, discuterlo in situazioni didattiche e pubbliche, compararlo per temi e per forme ad altri libri (primo fra tutti La strada di Cormac McCarthy) è possibile. Sia per via etica che per via storico-letteraria: La giornata d’uno scrutatore apre infatti domande di senso che oltrepassano il ventennio del nichilismo morbido e cinico successivo, e d’altra parte, le sue stesse forme saggistico-narrative ripropongono la questione della ripresa, nel secondo Novecento, di moduli tipici del grande modernismo europeo.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
- Lettura, esperienza e interpretazione. La letteratura nella scuola superiore
- Voce e persona, soggetto trascendentale e soggetto empirico
- Leggere a scuola i poeti del presente: Valerio Magrelli
- Gli oggetti desueti e Les Objects désuets: due nuove edizioni per Francesco Orlando
- Portare a spasso il canone. (Uno stress test alla Letteratura italiana)
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento