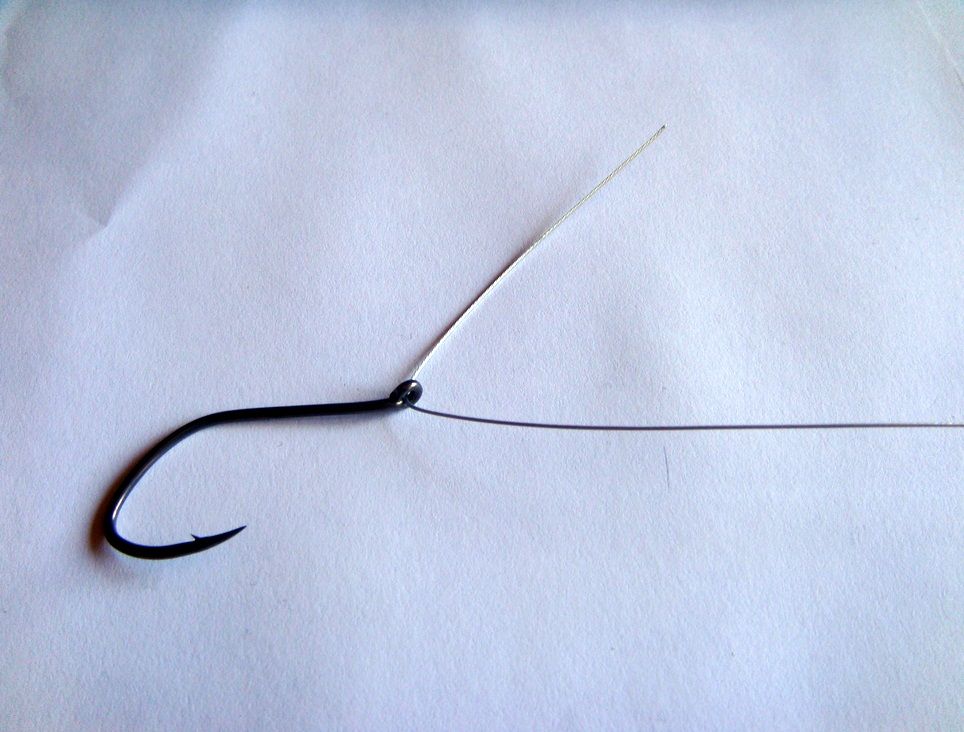
La poesia recente e la scuola. Con tre proposte didattiche
Vicinanza e distanza della poesia
1. Una sorta di analfabetismo ha colpito duramente la poesia italiana nei decenni successivi al secondo dopoguerra: istruito per un qualche esempio di poesia o di poetica comminato a scuola, il lettore medio è analfabeta per tutto quanto è avvenuto in poesia, in Italia e non solo, più o meno a partire dal ’50.
Convenzioni e usi consolidati furono allora spazzati via. Spirava un vento fortissimo, che seppe innovare percorrendo strade diverse e in reciproca opposizione (sperimentalismo esasperato e virate verso la prosa); soprattutto, fece irrompere nella tradizione italiana voci e ritmi provenienti da altri idiomi (si pensi alle parlate periferiche dei «neodialettali», da Albino Pierro a Tonino Guerra; e alle rinsanguanti traduzioni dall’inglese, dal tedesco, dal russo, dal francese di tanti poeti: da Montale a Caproni, da Fortini a Giudici e Raboni).
È vero che quest’opera di corrosione era stata avviata a inizio secolo da avanguardie storiche e grandi individualità (Campana, Ungaretti): essa allora prendeva senso in contrasto con la solidità della tradizione. Ma dopo la constatata inagibilità della tradizione medesima, anche prossima (simbolista e post-simbolista), era necessario impegnarsi per contrapporre una pars construens all’affermazione più distruttiva mai pronunciata nei confronti della poesia: vale a dire la sentenza di Adorno (datata 1949) in virtù della quale «scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie».
Il campo dunque fu sgombrato e lasciato libero a una pluralità di esperienze, scoperte, impulsi che resero singolare ogni proposta, fino al punto da richiedere una particolare «istruzione poetica» per ogni autore o gruppo di tendenza.
Da qui il contraccolpo – soprattutto sulle istituzioni scolastiche – che venne a rovesciare il rapporto con il testo poetico: note e commenti si resero necessari, quasi si fosse trattato di scritti di cinque secoli prima e non dell’opera di autori contemporanei. Descrivere la nuova poesia con gli strumenti consueti dell’analisi del testo era (e resta) difficile se non impossibile.
Questa smania di gettare luce, di spiegare tutto è dura a morire; quando invece, e un insegnante non lo dice quasi mai, la voce della poesia si ascolta molto di frequente sul limite di un dissidio, non di una consonanza. La consonanza semmai è il risultato finale, e cioè l’interazione di un ascolto e di una pronuncia – dentro la nostra voce – di un’altra voce.
2. Al riguardo di quanto appena evidenziato, è doveroso capovolgere il segno il più delle volte negativo al sintagma «poesia difficile». Anzi, meglio ancora sostituire a «difficile» «dura». Ma dura non vuol dire ‘per iniziati’: un’idea di poesia chiusa, l’idea cioè di un’operazione misticheggiante e sacra limitata alla setta degli «eletti», è da respingere senza alcuna riserva.
La vera poesia al contrario, proprio perché impegna e manifesta il meglio della lingua e dell’esperienza umana, è per tutti e da tutti può essere praticata: essa rappresenta un’opportunità straordinaria di un uso del linguaggio intensificato e al calor bianco.
Torniamo a «duro» e «difficile». A leggere autori come Zanzotto e Char (sono esempi), ci si trova davanti a cortocircuiti verbali e mentali che possono essere penetrati fino a un certo punto. Ma se ne resta comunque colpiti. Un verso si trasforma in un colpo quando si impone come una realtà che il lettore non riesce ad assorbire. Una realtà, appunto, dura. E ciò che è duro lascia il segno.
Il verso di Char «Nous errons auprès de margelles dont on a soustrait les puits», difficilmente lo si metabolizza, ma è terribilmente bello. Se accadesse di metabolizzarlo, verrebbe trasformato in un ricordo, mandato magari nello sfondo dei ricordi piacevoli, gradevoli, orecchiabili. Da dove, prima o poi, svanirebbe.
È certo un paradosso che nelle parole che scuotono stanno insieme vicinanza e distanza. Com’è possibile allora portare la propria capacità di ricezione a un grado di incandescenza tale che quei versi s’imprimano con il marchio a fuoco della necessità e dello choc? Forse è possibile traducendo topoi e mitologemi della tradizione in una prospettiva attuale, traendo cioè dalla propria esperienza un punto di vista che trasformi l’ovvio in inusitato, il familiare in qualcosa di mai visto prima.
Proposte didattiche
Specimen n. 1: Charles Simic, Le mie scarpe
In Das Unheimlich (‘Il perturbante’, 1919), Sigmund Freud, parafrasando il grande poeta romantico tedesco Schelling, così scrive: «L’unheimlich non è in realtà niente di nuovo, di estraneo, ma piuttosto qualcosa che è da sempre familiare alla psiche e che solo il processo della rimozione ha reso irriconoscibile. In relazione al processo della rimozione si chiarisce la definizione di Schelling, secondo la quale l’unheimlich è qualcosa che sarebbe dovuto rimanere nascosto e che invece ricompare».
Ciò che ci inquieta non è dunque niente di nuovo o di inusitato; è invece qualcosa di noto fin dalla notte dei tempi, di familiare alla nostra vita interiore. Col tempo però questo qualcosa è venuto estraniandosi alla nostra stessa vita interiore. È intervenuta cioè una rimozione, una specie di occultamento – come si fa talvolta con i morti di morte violenta.
Bene, certa poesia, certa letteratura – e certa musica, certa pittura ovviamente – scoperchiano proprio ciò che è stato occultato, consentono di violare un divieto (o se preferiamo un tabù). Ne risultano esse stesse necessariamente inquietanti, e tanto più inquietanti quanto più si pongono sul terreno della realtà consueta, su quanto ci è dato di vedere e di esperire tutti i giorni.
A illustrazione di ciò consideriamo Le mie scarpe di Charles Simic (poeta serbo nato nel ’38, naturalizzato americano) nella traduzione di Andrea Molesini:
Scarpe, faccia segreta della vita interiore:
due bocche senza denti, spalancate,
due pelli d’animale in parte decomposte,
fetide come un nido di topi.
Un fratello e una sorella nati morti
in voi continuano a esistere,
guidano la mia vita
verso la loro incomprensibile innocenza.
A che mai servono i libri
quando in voi si può leggere
il Vangelo della mia vita sulla terra
e oltre ancora, delle cose a venire?
Voglio rivelare la religione
che ho ideato per la vostra perfetta umiltà
e la bizzarra chiesa che ora erigo
dove voi siete l’altare.
Ascetiche e materne, perdurate:
parenti di bovini, santi, condannati,
con la vostra pazienza silenziosa siete
la sola vera cosa che a me somiglia.
Simic si riferisce a un oggetto quanto più usuale e familiare prescindendo però dall’unicità manifesta e scontata del suo significato (e cioè una scarpa è una scarpa, secondo la più ovvia delle definizioni possibili: la tautologia). Egli porta alla luce, dall’unicità scontata del suo significato più evidente, significati altri, significati secondi, attraverso cui poter esprimere alcuni aspetti e rapporti (misteriosi e minacciosi) che informano la nostra esperienza e che altrimenti risulterebbero impronunciabili dal nostro linguaggio ordinario.
Ipotesi di consegna: si proponga allo studente di scegliere un oggetto quanto più ordinario e di farlo deflagrare dall’interno come una melagranata, attraverso un uso personale della lingua che veicoli una personale visione del mondo.
La scelta di un autore vivente non è casuale. Avendo fede nella letteratura come disciplina formativa di gusto e intelligenza, la poesia contemporanea ricopre un ruolo decisivo, perché a chicchessia riesce più facile e istintivo prendere posto entro scenari e situazioni che appartengono al proprio tempo o a un tempo comunque a portata di memoria e di testimonianza diretta, piuttosto che in un ambiente desueto o in un paesaggio di rovine.
In moltissimi casi invece gli insegnanti di lettere delle Medie inferiori e superiori non sentono il bisogno di arricchire il proprio bagaglio culturale con qualche libro di poesia contemporanea. A malapena il Montale degli Ossi di seppia e l’Ungaretti dell’Allegria possono essere identificati come i poeti più «contemporanei» praticati a scuola; troppo spesso comunque, anche loro sono letti in fretta e furia. Della successiva, straordinaria generazione dei poeti nati negli anni Dieci (Sereni, Luzi, Caproni, Fortini, Bertolucci) già non esiste più traccia in quella che un tempo si definiva «cultura condivisa».
3. Si dia un’occhiata ora a quanto normalmente succede tra insegnanti. A inizio anno, durante la fase di programmazione, una domanda che in seno al Dipartimento di Lettere i docenti si rivolgono molto spesso è più o meno la seguente: «Di fronte a una pagina che riconoscono come un testo di poesia, che cosa vogliamo che gli studenti individuino di significativo?». Facile rispondere, per chi lavora nella scuola: metafora, analogia, immagine, parallelismo, ripetizione, lessico, sintassi. A proposito di un testo narrativo, la serie sarebbe invece questa: voce narrante, personaggi, ambiente, sviluppo degli eventi, dialoghi, connessioni tra le sequenze narrative, registro linguistico.
La distinzione qui sopra operata, senz’altro grossolana, rende l’idea della coscienza comune che tanti insegnanti e studenti italiani hanno in merito all’evoluzione della poesia (e delle Lettere in generale) da Baudelaire ai giorni nostri. Qualcosa di decisivo è accaduto nella «memoria culturale attiva» degli italiani, e questo è il risultato: se c’è da narrare, lo si fa in prosa, mentre in versi si esprime il rapporto tra l’io e il mondo, l’interiorità, i sentimenti.
Affrontare in un laboratorio di poesia il tema della narrazione in versi potrebbe perciò sembrare una provocazione. Eppure si è narrato in versi da Omero in avanti e, in particolare, nei lunghi secoli della tradizione italiana, con il maggiore dei nostri poeti, Dante, poi con Pulci, Ariosto, Folengo, Tasso, fino almeno agli anni Ottanta del Novecento, con l’esempio notevole e più evidente di Attilio Bertolucci.
Ma in un laboratorio di poesia si vuole soprattutto mettere in discussione l’abitudine a un’idea statica, enigmistica della poesia, l’idea cioè che la poesia si trovi soltanto sulla pagina scritta di una storia della letteratura in uso nelle scuole, e che il suo funzionamento estetico derivi da una sua interna combinatoria di elementi (metro, suoni, rime , assonanze, figure retoriche varie). Molto meglio avanzare un’ipotesi dinamica se non addirittura causativa, secondo cui la poesia si realizza di volta in volta nella lettura, nella pronuncia, nel mondo di senso e sensibilità che essa muove.
Si proverà qui di seguito ad accostare per sommi capi quella parte del programma confinato all’ultimo anno delle scuole superiori e, nella quasi totalità dei casi, sistematicamente eluso: le forme della poesia degli ultimi 150 anni.
4. La poesia tardo-ottocentesca e primo-novecentesca si identifica quasi totalmente con la lirica, riducendo in netta minoranza gli altri sottogeneri poetici; d’altro canto, anche la prosa finisce per fare propri molti dei procedimenti retorici sperimentati dalla poesia e, a sua volta, a produrne di analoghi. Ne viene che la poesia, se da un lato allarga il suo campo d’azione (fino a coinvolgere anche la prosa), dall’altro restringe il ventaglio delle proprie funzioni, lasciando ai margini le possibilità della narrazione. «Poesia» diventa sinonimo di «poesia lirica»: una forma di scrittura che esclude la narrazione.
La esclude in primo luogo per ragioni tecniche: la lirica è per definizione il «canto dell’io» in un registro linguistico sempre teso e portato al limite (del tutto codificato e monocorde), mentre la narrazione ha bisogno dell’esatto opposto: deve poter variare i punti di vista, e quindi anche le voci e i registri linguistici.
Meglio allora, a voler spezzare alcuni automatismi che sclerotizzano la scuola di oggi, presentare da subito agli studenti autori e testi che confutino qualsiasi procedimento dilemmatico. Esempi illuminanti al riguardo sono, nei Poemetti (1897) di Giovanni Pascoli, Digitale Purpurea e Italy: vi si riscontra il dissidio tra l’esigenza della narrazione (con tanto di dialoghi) e quella di imprimere una tensione fortissima al linguaggio, che è definito «simbolista» (condensazione lirica e concentrazione semantica esasperate) e va nella direzione opposta a qualsiasi apertura di tipo narrativo.
Vero è che da Pascoli in poi (Guido Gozzano è un altro valentissimo poeta narratore), in termini di quantità i casi in cui ritrovare un esplicito intento narrativo vanno via via diminuendo. Dagli anni Venti alla fine della Seconda guerra mondiale persino la prosa perde i suoi caratteri narrativi, anche quando si presenta nelle forme esplicite del racconto o del romanzo. Si tratta di un fenomeno che non è solo italiano, ma che in Italia assume fuor di dubbio caratteri più incisivi.
Il bisogno della narrazione si avverte alla fine della guerra, ma gli strumenti dei poeti sono gli stessi della stagione precedente. Leggendo Alle fronde dei salici (1945) di Salvatore Quasimodo, per esempio, si comprende quanto imbarazzo formale vi sia nella commistione tra la volontà di raccontare qualcosa e il non saper rinunciare all’accensione lirica della sinestesia (l’«urlo nero» del v. 5). Gli strumenti espressivi, la sensibilità, ciò che nella coscienza culturale (la già richiamata «memoria culturale attiva») suonava allora come «poesia», e suona ancor oggi in molti casi, voleva e vuole i caratteri che sono già stati individuati come lirici – la mancanza di questi caratteri equivale alla mancanza di poesia.
Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale c’è tuttavia poesia nuova e importante in Italia, che si afferma spostando l’asse della lirica e immettendo nel testo tratti diffusi di narratività. Alcuni nomi: Sereni, Pagliarani, Giudici, Erba, Raboni; in dialetto, Baldini e Loi. (Sia detto per inciso che, in dialetto, vena lirica e vena narrativa non si erano mai separate, integrandosi sempre; si pensi ai proverbi, alle filastrocche, agli aneddoti, alla saggezza popolare che li informa.)
Di questo «sommovimento» Alfonso Berardinelli ha esposto una sintesi efficace: invece che una fuga dalla realtà, «potremmo leggere nella poesia moderna un ritorno alla realtà: un irrompere del non-formalizzato e del non-formalizzabile dentro una forma poetica che stenta sempre più a organizzare e dominare esteticamente i suoi materiali».
Lungo la corrente principale del secondo Novecento, la poesia è andata dunque verso la prosa. Si badi però di assegnare a «prosa» la duplice valenza di ‘fenomeno tecnico di depotenziamento prosodico dei singoli versi’, e di ‘principio tematico che coinvolge la necessaria apertura della poesia a una sempre più preponderante «prosa del mondo»’. La lirica deve ora sporcare la propria «purezza», farsi carico di elementi negativi transeunti ibridi, accogliere le scorie e i materiali che compongono l’esistenza di un soggetto occidentale, collocato tra la fine della seconda guerra mondiale e la globalizzazione.
In chiusura di paragrafo, si vuol rilevare l’importanza che da sempre ricopre la prosa intesa come interfaccia di un testo poetico: basti pensare alla necessità delle Operette morali in rapporto ai Canti di Giacomo Leopardi; all’approdo di Charles Baudelaire ai pétits poèms en prose (i Paradis artificiels e lo Spleen de Paris) subito dopo aver licenziato le Fleurs du Mal (1857); alla violenza di titoli quali Une saison en enfer e Illuminations, che raccolgono le pagine più sulfuree e sregolate di Arthur Rimbaud; oppure si rifletta sull’elaborazione sincronica dell’ultimo libro poetico innervato di «grande stile» di Eugenio Montale (La bufera e altro, 1956) e delle prose satiriche ed eclettiche de La farfalla di Dinard (1956 e 1960), in cui è evidente l’azione di nutrimento e di trampolino compiuta dalla prosa nei confronti della poesia. (Non è un caso che il libro successivo di Montale, pubblicato nel 1971, s’intitoli Satura, a indicare un nuovo tempo poetico, privo di ogni possibilità di tensione al sublime e intessuto piuttosto di contenuti umili e prosastici.)
5. Per poter narrare, la poesia necessita di attingere quei procedimenti che permettono di identificare un punto di vista, di distinguere la diversità dei registri espressivi, di dare corpo a un ambiente. Elio Pagliarani, con La ragazza Carla (1962), sceglie di mostrare più che di dire (in origine voleva essere la sceneggiatura di un film) il personaggio nelle sue relazioni, riuscendo così a produrre un linguaggio che non rinuncia a determinati caratteri «disorientanti» della lirica e alla stesso tempo riesce a raccontare una storia.
Se la poesia lirica procedeva per analogie e giustapposizioni, narrare richiede ora una continuità di collegamento tra gli eventi, la cosiddetta «diegesi». Nei Versi livornesi (da Il seme del piangere, 1959), Giorgio Caproni, mediante un continuum di richiami e riferimenti, spinge sempre la storia avanti, pur chiudendo liricamente ogni sequenza. La narrazione resta frammentaria, ma il lettore ne ricostruisce la linearità narrativa.
Persino Mario Luzi, maestro dell’Ermetismo fiorentino fiorito negli anni Trenta, apre la sua poesia a una dimensione autenticamente polifonica, evidente nella sfera metrica (ampiamente libera) e in un brulichio di voci e incontri che si manifesta spesso in luoghi liminari.
È il caso di Presso il Bisenzio, testo inaugurale della raccolta Nel magma (1963), quasi sincrona con i due libri che spalancano la poesia italiana alla quotidianità della vita comune: Gli strumenti umani di Vittorio Sereni e La vita in versi di Giovanni Giudici (entrambi pubblicati nel 1965). Il Bisenzio è il fiume che attraversa il contado nordoccidentale di Firenze, in zone già industriali. (Non è da escludere che questo fiume umile si opponga intenzionalmente all’Àffrico già descritto da Boccaccio nel Ninfale fiesolano e dal D’Annunzio alcyonio.)
Se ne riporta quasi per intero la prima strofa:
La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia / e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro / non so se visti o non mai visti prima, / pigri nell’andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte. / Uno, il più lavorato da smanie e il più indolente, / mi si fa incontro, mi dice: Tu? Non sei dei nostri. / Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta / quando divampava e ardevano nel rogo bene e male”. / Lo fisso senza dar risposta nei suoi occhi vizzi, deboli, / e colgo mentre guizza lungo il labbro di sotto un’inquietudine. / Ci fu solo un tempo per redimersi – qui il tremito / si torce in tic convulso – o perdersi, e fu quello. / Gli altri costretti a una sosta impreveduta / dànno segni di fastidio, ma non fiatano, / muovono i piedi in cadenza contro il freddo / e masticano gomma guardando me o nessuno. / Dunque sei muto? imprecano le labbra tormentate / mentre lui si fa sotto e retrocede / frenetico, più volte, finché è là / fermo, addossato a un palo, che mi guarda / tra ironico e furente. E aspetta. Il luogo, / quel poco ch’è visibile, è deserto; / la nebbia stringe dappresso le persone / e non lascia apparire che la terra fradicia dell’argine / e il cigaro, la pianta grassa dei fossati che stilla muco./ E io: È difficile spiegarti. Ma sappi che il cammino / per me era più lungo che per voi / e passava da altre parti. Quali parti? / Come io non vado avanti, / mi fissa a lungo ed aspetta. Quali parti? / I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garretti /e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto. / E’ difficile, difficile spiegarti. / […]
In primo piano è la necessità avvertita da Luzi di dare una rappresentazione al tempo, alla contingenza di un’epoca gremita di contraddizioni, quale furono, in Italia, i primi anni Sessanta. L’eco surreale che sprigiona da Presso il Bisenzio è quella di una musica nuova, lirica e prosastica insieme, come dev’essere di una sperimentazione poetica non fine a se stessa.
6. Anche per quanto concerne la lingua era necessario abbandonare emulazione e reattività nei confronti dei padri e dei fratelli maggiori. La linea portante di tanta poesia novecentesca, di matrice simbolistico-avanguardista, aveva trovato un suo cardine nell’idea di scarto rispetto alla norma linguistica: la poesia si era distanziata dal parlare comune, venendosi a identificare come lingua speciale.
Tutt’al contrario, l’ipotesi di ridurre al minimo lo scarto apre invece a una poetica incentrata sulla qualità dell’esperienza vissuta dal poeta (non necessariamente eccezionale, anzi): la lingua dunque si rivela poetica per l’intensità del vissuto e capace di espressione lirica unicamente per questo motivo, e non per il coefficiente di «sorpresa linguistica» che presenta.
Lo sforzo di riportare il soggetto lirico vago e indeterminato a una coerenza di vissuto e di ambiente si compie con Giovanni Giudici (significativi i titoli dei primi due libri di poesie, La vita in versi, 1965; e Autobiologia, 1969): attraverso una specie di smascheramento, una seconda voce si separa dalla prima, in nome di un’esigenza di verità che affonda nell’esperienza quotidiana.
(Un altro modo per conferire verità empirica alla voce del soggetto poetico è quello, con la produzione in dialetto di Franco Loi e Raffaello Baldini soprattutto, di introdurre elementi drammaturgici che permettono di sviluppare delle sequenze narrative, ovvero di collocare il soggetto dentro una scena.)
Specimen n. 2: La Bovary c’est moi, I, di Giovanni Giudici (La Spezia 1924 – Milano 2011)
Come si è detto, ridurre al minimo lo scarto rispetto all’italiano standard e sub-standard apre a una poetica incentrata sulla qualità dell’esperienza vissuta: la lingua si rivela poetica più per l’intensità del vissuto che per il coefficiente di «sorpresa linguistica» che presenta.
La Bovary c’est moi, I
Deve essere stato l’abbaglio di un momento
un tac di calamita da una parola mia o sua.
E io che ci ricasco benché lo so come sono.
Ma ti amo – mi ha ripetuto e come faccio
a non riamarlo io che non chiedo altro.
Poi tutti a bocca aperta che uno come lui
con una come me che nemmeno col pensiero avrei osato.
Continuo a domandarmi com’è possibile che.
Chissà lui cos’ha in mente chissà in me cosa vede.
Chissà cosa ama se pure ama.
Potrei supporre di non sapere come sono
e che anche lui si domandi com’è possibile che.
Ma temo sia più vero di quello che so di sapere
e lui se non oggi domani riaprirà gli occhi.
Forse ci sta già pensando a come cavarsene fuori
più avanti dei miei timori.
Non devo illudermi perché dopo sarà peggio.
Meglio dirglielo subito che se ha un sospetto è vero.
Che faccia conto sia stato come uno sbaglio al telefono.
Insomma niente – e che se vuole può andarsene.
Che disastro, qualcuno potrebbe pensare. Non è così. Se ci addentriamo nel laboratorio del poeta spezzino, ci accorgiamo della sua assoluta perizia: egli ha voluto mettere in ritmo e versi molti degli automatismi che regolavano l’italiano parlato dal ceto medio alla fine degli anni Sessanta. Vediamone uno scorporo:
-
v. 2 tac onomatopea d’impiego fumettistico.
-
v. 3, 18 il pronome neutro lo, d’impiego larghissimo nel parlato, anticipa gli enunciati come sono al v. 3 e se ha un sospetto è vero al v. 18.
-
v. 3, la congiunzione concessiva benché vuole ‘normalmente’ il congiuntivo.
-
vv. 3, 5 rispettivamente E io che ci ricasco e io che non chiedo altro: sono due esempi di frase scissa di cui la prima parte (nominale) mette in rilievo il «nuovo» (il pronome personale io), mentre la seconda contiene il «noto».
-
vv. 3, 15 in entrambi i casi la particella ci conserva una sfumatura di avverbio di luogo, ma soprattutto ha un effetto di attualizzazione e di rinforzo semantico.
-
v. 6 il che, connettivo generico, sostituisce un nesso più nettamente causale.
-
vv. 8, 11 dovrebbe trattarsi di un che dichiarativo, ma non introducendo alcuna proposizione, viene in qualche modo «assolutizzato» e introduce una reticenza.
-
vv. 8, 11 il come e il sintagma esteso come mai esprimono rispetto al perché, nelle proposizioni interrogative, una maggiore disponibilità preventiva ad ascoltare e ad ascoltarsi.
-
vv. 9, 10 rispettivamente cos’ha e cosa: nelle frasi interrogative si afferma sempre più il semplice cosa, di provenienza settentrionale, mentre perde terreno il sintagma che cosa.
-
vv. 9, 11, 14 la forma lui è in funzione di soggetto.
-
v. 13 con i verba timendi vi è spesso l’ellissi del che dichiarativo. La medesima ellissi ritorna al v. 19.
-
v. 13 il pronome dimostrativo quello è impiegato con funzione di pronome neutro in luogo di ciò.
-
vv. 15, 20 cavarsene, andarsene: in molte locuzioni cristallizzate il valore di ne enclitico, pronominale o avverbiale che sia, appare attenuato, quasi irriconoscibile; la particella enclitica, combinandosi con i pronomi atoni mi, ti, ci, si, vi, dà luogo a forme più espressive di quelle semplici cavare (peraltro di provenienza settentrionale) e andare.
-
v. 18 nel periodo ipotetico della possibilità, come in quello dell’irrealtà, nell’uso medio prevale il modo indicativo sul congiuntivo; il costrutto sintattico (e brachilogico, altro tratto del parlato) se ha un sospetto è vero sostituisce l’ipotetico del secondo tipo, e più disteso, se avesse un sospetto, sarebbe un sospetto fondato.
-
v. 20 insomma niente: la locuzione avverbiale non introduce né una conclusione vera e propria né un giudizio meramente riassuntivo; semmai ha valore di interiezione, ed esprime con enfasi la necessità di troncare ogni indugio.
Ipotesi di consegna: si proponga allo studente di narrare un accadimento qualsiasi o di descrivere soggettivamente un interno domestico avvalendosi di un lessico usuale, al limite gergale, e di una sintassi (soltanto in apparenza) poco sorvegliata. Si introduca l’attività rivolgendo la domanda capziosa esistono parole poetiche e parole invece impoetiche? (del tipo: ‘cavalcavia’, ‘bancomat’, acronimi quali TASI, TFR, PIN, INRI e via dicendo) e si chieda allo studente di impiegare soprattutto queste ultime.
7. Veniamo ora a un poeta più giovane, Mario Benedetti (Udine, 1955), qui assunto come rappresentante dei nati in Italia nel secondo dopoguerra.
Questa generazione ha trascorso l’infanzia mentre la qualità del tempo si trasformava e i paesi diventavano gangli di una nuova città diffusa (fenomeno, questo, che caratterizzò l’Italia settentrionale, e in particolare il Nord-Est, prima e più prepotentemente che altre parti del Paese). In quegli anni cinema e tivù veicolavano immagini, suoni e narrazioni da un altrove che spesso era percepito come il vero presente.
Insomma, un ordine millenario del mondo, un’idea della persona e della sua comunità furono travolti allora come dall’onda di un maremoto. (A questo proposito, la tragedia del Vajont si rivelò spettralmente emblematica.)
Ma il tempo dei paesi, della fame e dei lavori manuali non è proprio del tutto trascorso. Festoni di memoria, viluppi di immagini e sentimenti, nodi, buchi, segni di un tempo lungo e profondo aggallano qua e là nella poesia di Mario Benedetti (e non solo: tra i suoi coetanei e vicini di casa, cadano almeno i nomi di Gian Mario Villalta, anch’egli friulano, e del veneto Luciano Cecchinel).
Da Umana gloria (Milano, Mondadori, 2004):
Borgo con locanda
Come in un volo la corriera mi ha dato lo spiazzo con la facciata.
Era bello, i calzoni che cadevano larghi sulle scarpe grosse,
stare in mezzo alle foglie qua e là.
Mattine senza sapere di essere in un posto, dentro una vita
che sta sempre lì, e ha la fabbrica di alluminio, i campi.
Si muove il bancone quando si parla,
le finestre con i vasi, le tende minutamente ricamate.
Fuori i cortili corrono piano, le foglie vanno piano sotto le mucche.
Il cielo gira verso Cividale, gira la bella luce
sulle manine che avevamo, che è stata la vita essere vivi così.
Un tempo lontano è dunque ancora qui (le parole ‘borgo’, ‘locanda’ invece di ‘frazione’ e ‘pub’), e non è facile distinguere se è memoria di una lontananza nell’infanzia o se è tempo ritrovato per improvvise accensioni mnestiche (o, se si preferisce, intermittenze del cuore).
La voce del poeta assume il tono dell’elegia, e cioè: scansione lenta, l’onda lunga e ferma dell’intonazione, atmosfere fortemente evocative. Allo stesso tempo, è una voce precisa che si esprime in una lingua naturale. «Era bello» inizia il secondo verso, pare ingenuamente. Ma il bello è segnale di fragilità, di sospensione, come «la bella luce» del penultimo verso, che accende il passato dentro una visone del presente.
Lente e ampie scorrono le immagini della poesia di Benedetti; immagini in movimento, che staccano dall’una all’altra con una velocità e una precisione del montaggio che troviamo nel grande cinema. Con un respiro lento e uno sguardo veloce, attraverso il presente colmo del passato, il poeta ritrova le vite che sono state e che sono la sua e la nostra vita.
Specimen n. 3: Mario Benedetti, Borgo con locanda
Potremmo definire quello di Borgo con locanda uno stile in buona sostanza nominale, frequentemente usato nella lingua scritta (dagli haiku, agli sms, alla pubblicità). Vuol dire che la scelta del nome, unita a quella dell’aggettivo e dei verbi in modi non finiti (participio, gerundio, infinito), prevale sulla scelta del verbo di modo finito, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, nel senso che il nome assume funzioni normalmente svolte dal verbo. Vediamone un esempio letterario da Cesare Pavese (da Il mestiere di vivere, 30 marzo [1948]):
L’odore della prima pioggia notturna, sotto il cielo chiaro. Stagione aperta, ritorno. Nella vita non c’è ritorno. Bellezza di questo ritmo discorde – sul ritorno periodico delle stagioni il progredire degli anni che colorano in modo sempre diverso un tema eguale – misura e invenzione, costanza e scoperta – l’età è accumulo di cose uguali che si arricchisce e approfondisce sempre più.
Il periodo dello stile nominale predilige la costruzione sintattica per coordinazione e giustapposizione (paratassi), che si combina spesso con il procedimento dell’enumerazione. Tale costruzione può avere un obiettivo narrativo e descrittivo, il più delle volte elegiaco-evocativo.
Gli ingredienti linguistici che danno luogo allo stile nominale assicurano un insieme definito di proprietà comunicative.
Si ha anzitutto la concisione: essa può servire all’economia, particolarmente utile nella comunicazione mediata dal computer o dal cellulare, negli appunti, nel linguaggio pubblicitario; oppure a una narrazione o descrizione impressionistica, ‘tutta cose’, in cui si nominano, giustapponendoli, solo gli elementi giudicati particolarmente rilevanti o incisivi.
Strettamente legata alla concisione è l’implicitezza; l’implicito è tipicamente non risolubile in modo univoco e sicuro: spesso non è infatti possibile, né del resto necessario ai fini interpretativi, ricostruirne con certezza e precisione il contenuto.
Un’altra caratteristica dello stile nominale è l’atemporalità, la quale, essendo conseguenza dell’assenza di verbo coniugato, è presente in tutte le manifestazioni di questo stile. Dal punto di vista letterario, l’atemporalità abilita una rappresentazione astratta degli eventi, e spesso anche la rinuncia alla formulazione esplicita della successione cronologica.
Ipotesi di consegna: Si chieda allo studente di trarre ispirazione dal locus pavesiano sopra riportato come dai versi di Mario Benedetti o dagli haiku (v. ad es. Keruac: «Perfect moonlit night / marred / By family squabbles»), e di fissare su carta o sul display del suo smartphone il passaggio di un istante labile. Unico vincolo, l’impiego dello stile nominale.
Anche per quanto riguarda Benedetti e lo stile nominale, come per Giudici prima, lo scarto rispetto all’italiano standard c’è, ma esso risulta incorporato all’espressione intera, quindi minimamente registrabile in termini di infrazione della norma. Detto diversamente, il singolo verso (da intendersi come unità inscindibile di prosodia e senso) coopera senza alcuna frizione con la sintassi naturale della lingua.
8. Sebbene per sommi capi, ci è dato insomma di misurare al vivo quanto le pratiche di scrittura poetica e la loro ricezione non solo obbediscano a macro e micro vincoli del presente, ma anche all’insistenza di vincoli di maggiore durata, a distanza di tempo ancora operanti (la cosiddetta «memoria culturale attiva»).
Nello specifico, si nota con quanta fatica la poesia, dopo essersi per decenni identificata con la sola lirica, debba ricostruirsi gli strumenti necessari per tornare a raccontare; si nota altresì quanto sia difficile, se non impossibile, voler descrivere a scuola la nuova poesia con gli strumenti consueti dell’analisi del testo. Molto meglio, avendone la possibilità, tentare un approccio di tipo euristico-laboratoriale.
Quanto agli autori individuati, va puntualizzato infine che, accostando una letteratura a noi così vicina, facilmente si può cadere in definizioni inesatte o disconoscere valori. Ma tant’è: la selezione dei poeti e dei testi qui operata deriva dalla necessità di mostrare brevemente stili, approcci, denunce e rinunce che informano tanta parte della poesia recente, non solo italiana.
_____________
NOTA BIBLIOGRAFICA DI RIFERIMENTO
Auden, W.H., La mano del tintore, Milano, Adelphi, 1999
Berardinelli, A., La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, Torino, Bollati Boringhieri, 1994
Bertoni, A., La poesia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2012
Bloom, H., L’arte di leggere la poesia, Milano, Rizzoli, 2010
Celan, P., La verità della poesia. Il meridiano e altre prose, Torino, Einaudi, 1993
Cucchi, M., S. Giovanardi, Poeti italiani del secondo Novecento, Milano, Mondadori, 2004
Rilke, R.M., Lettere a un giovane poeta, Milano, Mondadori, 2000
Testa, E., Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Torino, Einaudi 2005
Villalta, G.M., Il respiro e lo sguardo. Un racconto della poesia italiana contemporanea, Milano, Rizzoli, 2005.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento