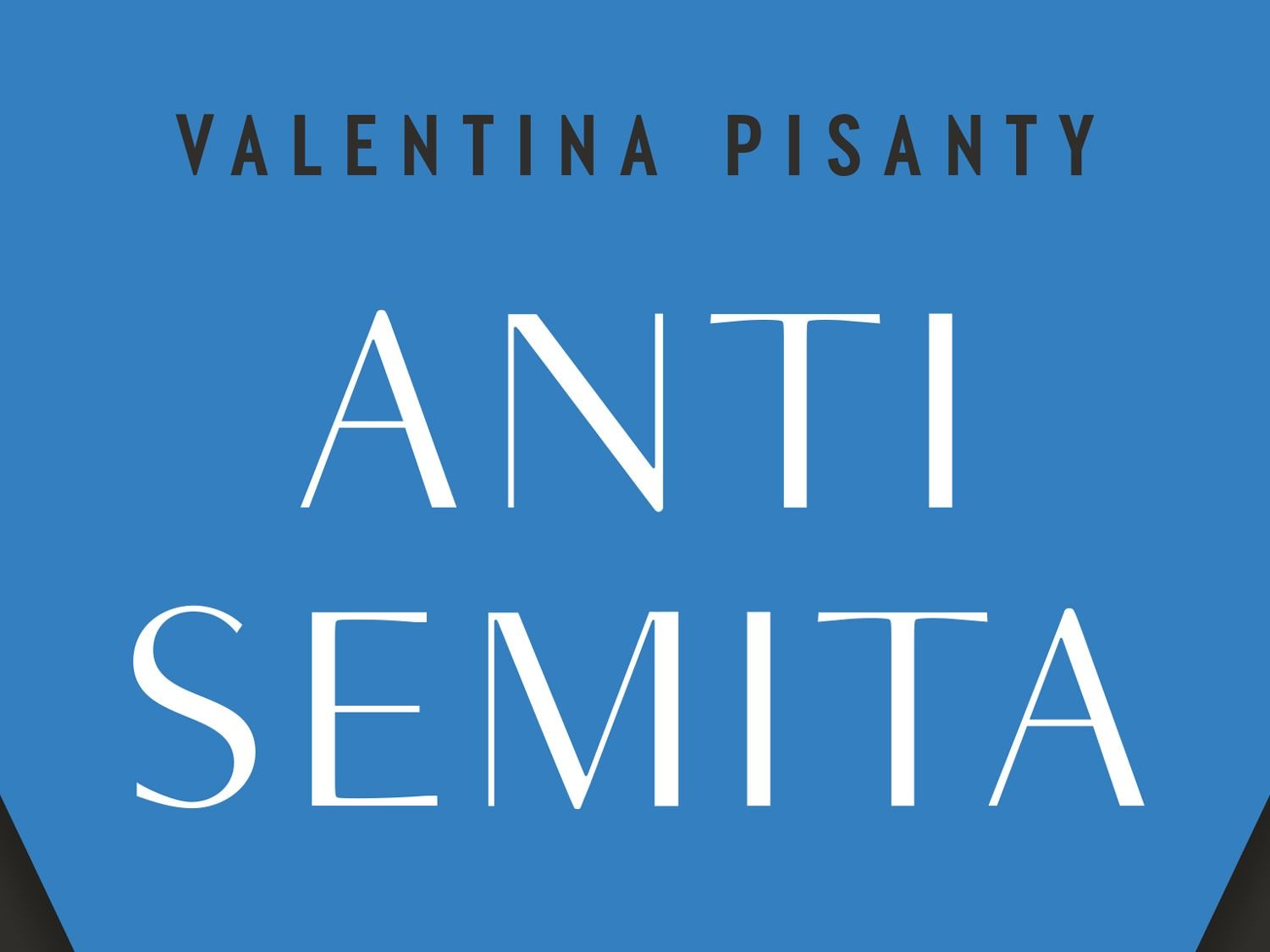
Viviamo ormai dentro una logica di guerra? Su Antisemita. Una parola in ostaggio di Valentina Pisanty
Nel suo ultimo libro, la semiologa Valentina Pisanty tenta di fornire una risposta al seguente interrogativo: «come sia possibile che, in nome della Memoria, abbiamo collettivamente spalancato le porte al ritorno degli ultranazionalisti in Europa e al loro consolidamento in Israele» (Antisemita. Una parola in ostaggio, Bompiani, 2025, ebook, pos. 213). La Memoria, con la emme maiuscola, è ovviamente quella della Shoah, strettamente legata al «“Mai Più” attorno al quale le democrazie liberali si sono strette dopo il crollo del Muro di Berlino per ridefinire il proprio progetto identitario comune» (pos. 102), in assenza del cemento delle “vecchie” ideologice otto-novecentesche.
Antisemita, un battagliero pamphlet assai più dei precedenti libri della studiosa, è quasi un caso di studio applicato delle premesse teoriche del precedente I Guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bompiani, 2019: ne avevo dato conto qui). A sei anni di distanza da quel libro, l’evoluzione della politica internazionale sembra davvero dare ragione a Pisanty: le fondamenta di un progetto identitario fondato sulla speranza post-storica che bastasse commemorare il male passato per garantirsi una pacifica esistenza nel presente delle nostre liberaldemocrazie, investendo memoria e testimoni della Shoah del compito di renderci migliori e più civili, stanno mostrando crepe sempre più evidenti. Non solo, questa fragile costruzione (post)identitaria e l’avanzata delle destre – questo era il secondo perno del ragionamento di Pisanty ne I Guardiani della memoria – sono due serie storiche interdipendenti.
L’evoluzione della parola antisemitismo
Nel libro del 2019 leggevamo che la memoria – quella personale come quella collettiva – ha sempre una «natura strategica» e selettiva, ovvero è sempre una ricostruzione del passato. Sappiamo bene che memoria e identità si costituiscono per mezzo di processi collettivi spontanei, o meglio, su scala talmente ampia da non poter essere interamente diretti; ma sappiamo altrettanto bene che esse sono anche l’effetto di precise operazioni politiche e pedagogiche: attraverso la costituzione di ricorrenze, eroi, monumenti, toponomastica, libri, programmi scolastici, narrazioni diffuse … si edificano valori condivisi e si crea una collettività. Questo processo di costruzione identitaria può dunque essere più o meno plurale e aperto: quando esso viene rivendicato in modo esclusivo da quelli che Pisanty chiama “Guardiani”, siamo vicini a una forma religiosa di sacralizzazione e assolutizzazione. La memoria della Shoah, costruita sulla testimonianza delle vittime, è, secondo Pisanty, una memoria che ha assunto via via quest’ultima forma, problematica e gravida di implicazioni politiche.
La tesi del nuovo libro di Pisanty è che l’evoluzione dei concetti di ‘antisemita’ e ‘antisemitismo’, dalla loro prima comparsa tardo-ottocentesca, abbia conosciuto un salto di qualità a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Come è noto, dopo la Shoah, l’antisemitismo è diventato equivalente semantico del Male assoluto: lo dimostra il fatto che, mentre alla fine dell’Ottocento il termine poteva essere rivendicato con connotazione positiva dai primi antisemiti, oggi anche coloro che sono effettivamente tali negano di esserlo, almeno nello spazio pubblico. L’antisemita è il soggetto cui per definizione si nega agibilità sociale (“con gli antisemiti non si parla”). In questo non c’è nulla di strano: l’identità collettiva si struttura a partire dall’esclusione di ciò che non si è e il disvalore per eccellenza nell’Occidente postbellico è stato incarnato dal nazifascismo e dalla sua volontà di sterminio. Ciò che Pisanty mette sotto la propria lente semiotica è lo scarto successivo, per il quale la forza squalificante dell’accusa di antisemitismo ha cominciato ad essere piegata a usi politici di parte. La posta in gioco era, ed è, oggi più che mai, la definizione del «nuovo antisemitismo»:
Tra la fine degli anni novanta e i decenni successivi […] alcuni policy-makers intravedono con sempre maggior chiarezza il potenziale strategico della parola antisemita. Divenuto sinonimo di Male assoluto, il termine si presta a una varietà di usi funzionali alla politica di chi se ne sente custode e titolare (pos. 89). […] La realizzazione del progetto è andata di pari passo con la scalata al potere delle destre mondiali negli ultimi vent’anni. La mia ipotesi è che i due fenomeni siano strettamente interrelati (pos. 129).
Definizioni: il «nuovo antisemitismo»
Definire è un «atto linguistico complesso che si propone di catturare l’essenza del fenomeno definito, ma al contempo stipula le condizioni che permettono di riconoscere le occorrenze di quel fenomeno» (pos. 836). È la contesa intorno a queste occorrenze, a quali di esse rientrino o no nella definizione di antisemitismo, ad avere uno squisito carattere politico:
Si capisce perché i vari gruppi di pressione hanno interesse a controllare i processi della definizione e della ridefinizione linguistica. Chi è ammesso nella stanza dei nomoteti, chi riesce a far passare le sue condizioni necessarie e sufficienti per definire il termine conteso, acquista il potere di screditare e tacitare coloro che, pensandola diversamente da lui, applicano una definizione diversa di quel concetto (pos. 850).
Pisanty ricostruisce le vicende che hanno portato alla Definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), ormai adottata da legislazioni nazionali, regolamenti universitari, …: nata come definizione scientifica e strumento euristico per l’interpretazione degli episodi di antisemitismo, essa ha conosciuto una progressiva chiusura “esegetica” di tipo letteralistico, venendo piegata a un uso normativo volto a stigmatizzare e punire forme di critica e di dissenso. Si è preteso infatti che la comunità internazionale sottoscrivesse le nuove «condizioni d’uso» del termine stabilite dai «Guardiani della memoria», senza che sia più possibile sottrarsi a tali condizioni, dal momento che anche tale critica può essere tacciata di sospetto antisemitismo.
Il problema principale della Definizione è la completa sovrapposizione tra antisionismo e antisemitismo, o meglio, tra critiche alle politiche di Israele e razzismo antisemita. Tra le fattispecie individuate dalla Definizione, alcune riguardano infatti lo Stato di Israele, come è naturale che sia: alcuni argomenti contro di esso possono (ma non devono necessariamente: e su questo slittamento nei verbi modali Pisanty insiste molto) configurarsi come intenzionalmente o preterintenzionalmente antisemiti, in particolare il considerare gli ebrei in quanto tali responsabili della politica di Israele.
Lungi dall’essere pacifica, questa sovrapposizione tra ebraismo e stato d’Israele, antisemitismo e antisionismo, antisemitismo e critiche politiche, è stata costruita grazie a una esplicita azione del governo israeliano, che dagli anni Novanta ha cominciato a interessarsi alla lotta all’antisemitismo nel mondo, considerandola «prerogativa della [propria] politica estera», con la costituzione di forum e associazioni. Ma è stata soprattutto la virata a destra della politica israeliana e il suo carattere sempre più etnico – sanciti dalla legge votata nel 2018 (ma con una maggioranza parlamentare risicata, puntualizza Pisanty, a dimostrazione del suo carattere controverso), con la quale si è scelta l’autodefinizione di “Stato degli ebrei”i – a rendere il ricorso all’accusa di antisemitismo un’arma per la contesa politica.
La problematicità della Definizione dell’IHRA ha spinto molti studiosi ebrei ed israeliani a proporre definizioni alternative, che restassero strumenti di studio e in cui il confine tra antisemitismo e antisionismo fosse tracciato in modo più chiaro: il Nexus Document (2021), la Jerusalem Declaration on Antisemitism (2021), quest’ultima firmata dalla maggior parte degli storici dell’antisemitismo.ii Tra tali studiosi si distingue particolarmente Kenneth S. Stern, uno dei primi estensori della Definizione operativa, successivamente tra i massimi critici del suo impiego come strumento di repressione illiberale.
Il nuovo antisemitismo è quasi solo antisionismo
Ai governi della nuova destra radicale mondiale fa comodo avere tra le mani uno strumento di delegittimazione e di criminalizzazione degli avversari così perfettamente oliato come l’accusa di “nuovo antisemita”.
Lo dimostrano la campagna di screditamento con la quale nel Regno Unito un leader considerato, anche dentro il suo partito, troppo radicale, come Jeremy Corbin sia stato liquidato proprio ricorrendo a quest’accusa:
Le accuse di antisemitismo servirono a deviare il dibattito da ciò di cui si sarebbe dovuto discutere – fino a che punto fosse vero il motto thatcheriano che all’economia di mercato There Is No Alternative – a questioni solo apparentemente morali che affossarono il dibattito politico prima ancora che cominciasse. Questo è il potere della parola antisemita quando a impugnarla sono soggetti diversi (l’opposizione interna e quella esterna), ciascuno mosso da interessi diversi, ma tutti sostenuti dall’autorità inappellabile dei Guardiani della Memoria, a loro volta intenti a perseguire la propria agenda (pos. 1194).
Quanto avvenuto in Italia dopo l’inchiesta di Fanpage sull’antisemitismo di Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, permette di mettere a fuoco un ulteriore slittamento nella definizione di nuovo antesemitismo. Prima, in modo più indiretto, il generale Pasquale Angelosanto, Coordinatore nazionale per la Lotta all’Antisemitismo, poi, in modo del tutto esplicito il ministro dell’Interno Piantedosi, fecero capire che il “vero” pericolo antisemita non proveniva dalle manifestazioni di odio razziale della base della destra – che continua a fare ricorso a quello che Pisanty chiama «archivio antisemita», ovvero alle configurazioni più tradizionali dell’odio antiebraico: dal complotto giudaico internazionale, al carattere manipolatorio e doppio dell’ebreo –, ma dalla sinistra propal e dal suo anticolonialismo, anti-imperialismo e antisionismo. Commenta Pisanty: «il cosiddetto nuovo antisemitismo ha scacciato quello vecchio dal nucleo semantico del termine. Non solo «“antisionismo è antisemitismo”, ma anche “l’antisemitismo è solo – o quasi solo – antisionismo”» (pos. 1330, corsivi originali).
Il rovesciamento ideologico è davvero perverso: gli eredi di partiti già fascisti, nostalgici, xenofobi, antisemiti, sono diventati i più accaniti sostenitori della definizione di nuovo antisemitismo, perché questa consente loro di mettere ai margini dello spazio pubblico gli avversari, attestandosi al suo centro come i più fieri campioni di valori democratici ormai ridotti a paravento della propria politica spregiudicata.
Ma Pisanty si spinge oltre, parlando di un vero e proprio scambio di favori tra la destra israeliana al governo e gli esponenti della destra radicale globale, da Trump a Bolsonaro, ai quali basta garantire
supporto incondizionato alle politiche delle destre israeliane contro l’immunità da ogni accusa di razzismo e antisemitismo. Una visita ufficiale a Yad Vashem (il Memoriale della Shoah a Gerusalemme), specie se accompagnata da espressioni di dura condanna nei confronti degli attuali nemici dello Stato ebraico, è sufficiente per ripulire l’immagine pubblica di qualsiasi leader xenofobo, e quasi sempre erede di formazioni politiche quelle sì inequivocabilmente antisemite (pos. 136).
Effetti perversi
Gli ulteriori effetti perversi degli abusi della memoria della Shoah e della lotta all’antisemitismo sono inquadrabili in categorie che Pisanty ormai da quasi quindici anni ha messo a disposizione (cfr. Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah, Bruno Mondadori, 2012). La sovraestensione del concetto di antisemitismo e la sua strumentalizzazione ne indebolisce anche il nocciolo storico, il suo senso più strettamente denotativo, il memento leviano che «questo è stato»: la Shoah viene banalizzata e la banalizzazione finisce per lambire il terreno della ancora più pericolosa negazione. Pisanty riporta un paralogismo di questo tipo “se antisemitismo significa stare dalla parte dei palestinesi, ebbene sì, sono antisemita” e un’osservazione di Enzo Traverso: la sovrapposizione tra la reazione sproporzionata di Israele a Gaza, che sarebbe fondata sul diritto alla sopravvivenza – dove quella dello Stato e quella degli ebrei vittime dello sterminio si confondono e Israele diventa figura dell’«Ebreo collettivo»: paradossalmente, uno dei criteri con i quali identificare l’antisemitismo secondo la Definizione operativa –, finisce per diffondere la sensazione che la Shoah sia un pretesto politico, se non addirittura un’invenzione sionista, per giustificare la propria politica estera.
Ma è il terzo fenomeno, la sacralizzazione, ad essere più direttamente coinvolto nella interessata strumentalizzazione politica della definizione di nuovo antisemitismo:
La parola sacra non deve essere capita o interpretata. Va ripetuta liturgicamente e applicata alla lettera in tutti i contesti e le circostanze che i nomoteti-legislatori hanno stabilito essere di sua pertinenza. La parola sacra è incomparabile. […] È unica e isolata, come d’altronde lo è il fenomeno “unicamente unico” che designa (pos. 1201).
Criticare l’abuso del termine ‘antisemita’ diventa così «un’impresa pressoché impossibile per via del sistema di tabù e interdizioni» della cultura della Memoria. «Per mettere in discussione un concetto, bisogna trattarlo come una costruzione umana, fallibile e riformulabile. Ma se a quel concetto viene attribuito un valore sacro, inviolabile e protetto niente meno che dalla ragione di stato [come fece Angela Merkel in una dichiarazione famosa alla Knesset], la sua decostruzione risulta blasfema e socialmente sconsigliabile» (pos. 1258).
Non si tratta naturalmente di avallare ogni critica ad Israele e di sposare necessariamente le tesi dell’antisionismo più radicale: si tratta semmai di ristabilire le precondizioni dialettiche di uno spazio del confronto pubblico in cui le scomuniche e la criminalizzazione politica non siano diventati materia corrente. In questo spazio le affermazioni antisraeliane potranno anche essere politicamente avversate, ma non saranno preventivamente squalificate come inconcepibili perché sottoposte a interdetto: «Come scrivono i duecento firmatari della Jerusalem Declaration on Antisemitism (2021), “la linea tra discorso antisemita e non antisemita è cosa diversa dalla linea tra discorso irragionevole e ragionevole» (pos. 1434).
Lo spirito del nostro tempo è quello della guerra, dovremmo ormai saperlo. La liberaldemocrazia è in crisi molto probabilmente irreversibile. Difendere uno spazio di confronto intellettuale nel quale il lessico dell’assoluto e della caccia alle streghe sia bandito potrebbe essere un modo, e non dei più disprezzabili, per difendere qualche residuo di civiltà,
a meno di non prendere atto che il mondo è entrato in una fase di guerra senza quartiere, o si vince o si muore, di cui la retorica della prevaricazione è il naturale corollario. Forse è sempre stato così, forse no. Se la regola è “lo faccio perché posso”, si smetta almeno di invocare i valori democratici, la Memoria e la falsa promessa del Mai Più, si abbracci senza remore la legge del più forte, ci si assuma la responsabilità delle conseguenze e tanti auguri (pos. 1441).
i Sul carattere etnico della democrazia israeliana, cfr. il capitolo 7 di A. Marzano, Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina, Laterza 2024. Si vedano anche i capitoli 6 e 9, sugli stessi argomenti del libro di Pisanty qui recensito.
ii I due documenti, insieme alla Definizione operativa dell’Ihra, sono leggibili in appendice al libro.
Articoli correlati
No related posts.
Comments (2)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


La storia si è rimessa in movimento, in movimento rapido e imprevedibile, e anche le parole sono diventate uno spazio di senso sfuggente e conflittuale che continuamente ci interroga e ci impone di usarle secondo la nostra particolare memoria del passato. “Antisemitismo”, “fascismo”, “razzismo”, “democrazia”… non sono più stabili punti d’appoggio del discorso pubblico, ma recipienti che possono essere riempiti delle cose più diverse… È un po’ la situazione descritta da Leopardi quando scriveva: «Cum pietatem funditus amiserint, pî tamen dici nunc maxime reges volunt. Quo res magis labuntur, haerent nomina». Certo, in Italia la riflessione è stata sostituita dai talk-show, ma non bisogna scambiare un effetto per la causa, cioè la storia che si è rimessa in moto e che presto ci chiederà di fare scelte difficili e rischiose, in un tempo confuso e contraddittorio…
[…] LEGGI L’ARTICOLO […]