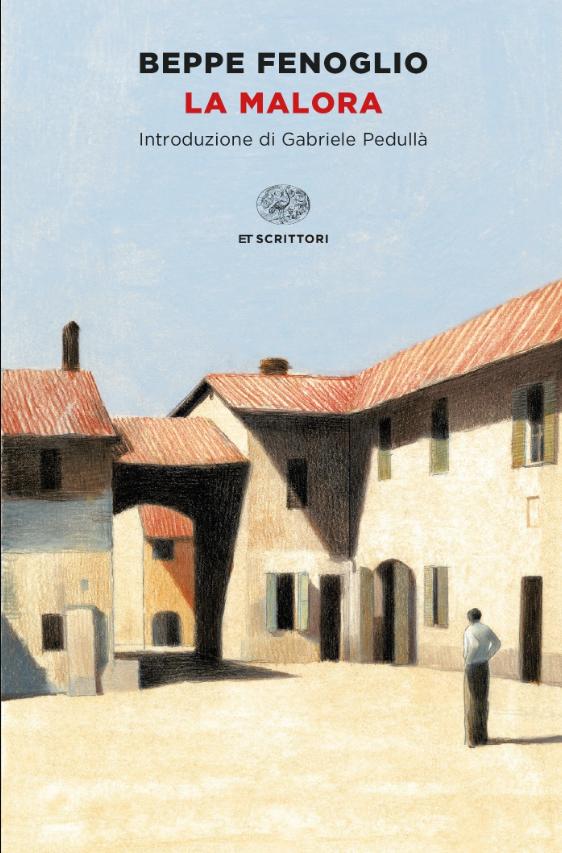
Al di là dei fraintendimenti: una lettura della Malora di Fenoglio
Pioveva su tutte le langhe, lassù, a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Era mancato nella notte di giovedì l’altro e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il mio padrone m’aveva anticipato tre marenghi, altrimenti in tutta casa nostra non c’era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel’avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto tirare un po’ su la testa (B. Fenoglio, La malora. Nota introduttiva di Maria Antonietta Grignani, Einaudi, Torino 1997, p. 3).
Con questo incipit scarno, essenziale, che squaderna subito davanti al lettore una terra dimenticata da Dio, le Langhe, si apre La malora, romanzo, o forse meglio, racconto lungo di Beppe Fenoglio, uscito nel 1954 per la collana di Einaudi «I gettoni»; il direttore Elio Vittorini, due anni prima, nel risvolto di copertina della raccolta I ventitre giorni della città di Alba,aveva sottolineato la capacità dell’autore di sapere «cogliere più ancora che un paesaggio naturale, un paesaggio morale, il piglio in cui si articolano i rapporti umani, un gusto “barbarico”». La malora non può che avvalorare tale giudizio critico che, tuttavia, peserà sullo scrittore albese, tanto da spingerlo a lasciare Einaudi e pubblicare le opere successive per Livio Garzanti.
Messa in secondo piano dalla tematica resistenziale, quella langarola e contadina, ben rappresentata dalla Malora, merita però, a mio avviso, di essere rivalutata, per la capacità di dipingere personaggi e luoghi, ma anche per gli echi dalla letteratura italiana di fine Ottocento e inizio Novecento. Nel presente contributo si indagherà dapprima lo scarto dell’opera rispetto al Verismo e al coevo Neorealismo, si proporranno poi alcuni percorsi tematici all’interno del racconto e, infine, se ne avanzerà un’interpretazione complessiva, cercando di non ricadere in quelli che Nunzia Palmieri, nell’articolo Beppe Fenoglio. Corpo, definisce «abbagli e fraintendimenti che [lo scrittore] sente per tutta la vita come una ferita aperta».
Una costruzione narrativa sapiente
La vicenda della Malora si apre con uno scenario di morte, il già citato funerale del padre a San Benedetto e si snoda per continui flashback volti a motivare le condizioni misere della famiglia Braida, che hanno costretto il giovane bracciante Agostino a lavorare come servitore dal mezzadro Tobia Rabino, e il fratello Emilio ad andare in seminario per saldare un debito con l’avara maestra Fresia. Dopo la retrospezione sul corteggiamento che aveva portato il padre Giovanni a sposare la madre Melina, il lettore è condotto nel centro della storia, la vita di Agostino (voce narrante autobiografica) al Pavaglione di Rabino, con il racconto di una serie di eventi, tra cui l’amicizia con il ribelle Mario Bernasca, il suicidio di Costantino del Boscaccio e la malattia della moglie di Tobia Rabino. Questo ultimo evento porta però all’arrivo di una giovane servitrice di nome Fede, con cui Agostino inizia una relazione platonica fatta di non detti, subito troncata dall’allontanamento della donna, destinata a un matrimonio combinato. La storia, dopo queste alterazioni della fabula, ben descritte da C. Segre nel suo Analisi tematica sperimentale di un romanzo («La malora» di Beppe Fenoglio), si chiude con il secondo e ultimo ritorno a casa di Agostino, che si riallaccia al focolare domestico insieme al fratello morente; le righe finali spostano l’inquadratura sulla madre, sorpresa dall’io narrante omodiegetico a pregare con queste parole: «Non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi a mio povero figlio Emilio. Poi dopo son contenta che mi chiami, se sei contento tu. […] E tutti noi che saremo lassù teniamo la mano sulla testa d’Agostino, che è buono e s’è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mondo» (p. 85).
Tra Neorealismo e fiaba popolare
Com’è noto, La malora venne subito etichettata dai lettori meno avveduti come un racconto verista, per l’ambientazione rurale, l’uso della coloritura dialettale e personaggi appartenenti a strati sociali umili; in realtà, se da una parte è evidente, come vedremo, l’influenza di Verga, è però innegabile lo scarto rispetto alla narrativa ottocentesca. Come sottolinea Palmieri, «rispetto ai codici del naturalismo e del neorealismo va innanzitutto notata la scelta di una voce narrante che racconta in prima persona e che impedisce al romanzo di rientrare nella categoria dei testi “di maniera”: la prima persona della Malora non è l’io “lirico-intellettualistico” dal quale metteva in guardia Calvino né il narratore verghiano che si abbassa al livello dei personaggi» (N. Palmieri, Avventure di un narratore nella «Malora» di Fenoglio, «Allegoria», 61, p. 135).
Il realismo di fondo, poi, è arricchito di coloriture da novella e da fiaba (si pensi al «boschetto» dell’episodio di Costantino del Boscaccio), e sembra di assistere a una proliferazione di racconti, come se Fenoglio si impegnasse a registrare quelli che aveva raccolto sul suo taccuino in occasione di pranzi di famiglia, veglie dei partigiani e altre occasioni conviviali. Emerge quindi una memoria orale e il lettore è condotto in uno spazio senza tempo; come sottolinea infatti Grignani, il racconto si caratterizza per «la vaghezza dell’ambientazione storica, che si può ipotizzare agli inizi del secolo inferendo da alcuni particolari (come la paga in marenghi o la leva militare regolata dall’estrazione a sorte del numero), ma che non è importante determinare».
La tematica della roba tra Verga e il Novecento
Nel suo «Star male oggi per non star peggio domani». Denaro ed etica ne «La malora» di Beppe Fenoglio, Marialuigia Scipione si sofferma sull’insistenza quasi ossessiva del denaro nel racconto fenogliano: «si possono contare ben 116 occorrenze di termini connessi alla sfera semantica del denaro (denaro, soldi, scudi, lire, marenghi, debito, credito, dote, fortuna, roba, vendere, comprare, rubare, giocare, scommettere, debito, prestito…) e in una ottantina di pagine il numero acquisisce un suo peso, perché significa una media di due o tre ripetizioni a cartella». È proprio nella tematica verghiana della “roba” che risiede, credo, il debito più evidente del giovane narratore delle Langhe nei confronti del maestro catanese: oltre al riferimento al titolo della celebre novella con protagonista Mazzarò, va sottolineato come anche in Fenoglio sia l’attaccamento ai beni materiali la causa dell’aridità di sentimenti che caratterizza le relazioni tra i personaggi. Tutto nella Malora si lega al denaro, a partire da quei «tre marenghi» anticipati dal padrone per il funerale e il pranzo del padre, per poi passare ai «sette marenghi» con cui Agostino viene venduto al mezzadro che lo accoglierà al Pavaglione. Anche le visite al fratello Emilio, pur caratterizzate dall’affetto reciproco, sono scandite dal riferimento al denaro; nella prima, il seminarista, subito dopo l’incontro col protagonista, gira la conversazione sul bisogno economico: «-Agostino, hai del denaro appresso? Avevo dieci soldi e li tirai fuori: – Li vuoi? Tanto io non sono buono che a perderli al nove. – Ho fame, Agostino. Esci un momento con quei soldi a comprarmi qualcosa da mangiare» (p. 21); nel secondo incontro, dopo una conversazione che rivela l’amore fraterno, la chiusura è però ancora sul denaro: «Prima ci baciammo sulle guance e io gli lasciai una lira perché si comprasse un po’ per volta qualcosa che lo rallegrasse» (p. 55).
La stessa morale di Rabino, espressa nel momento in cui la moglie lo supplica di procurarle una serva per aiutarla in casa, si basa sulla rinuncia e su un universo in cui tutto è commisurato al denaro:
Qui mi tenete tutti per il vostro aguzzino. Ma lo sapete il perché io tiro e vi faccio tirare e non vi do niente di più del necessario. E se anche fallisco nei miei piani, dovrete sempre ringraziarmi per avervi insegnato a star male oggi per non star peggio domani. E non venite a dirmi che peggio di così non si può stare, perché io ci metto poco a mostrarvi il contrario. Vi contassi d’uno che da bambino gli è morto suo padre e se lo prese in casa un suo zio, dalle parti di Cravanzana. Lo faceva tirare che al paragone voi siete dei signorotti, e a mezzogiorno gli diceva: «Se non mangi pranzo, ti do due soldi», e bisognava pigliare i due soldi, e a cena: «Se vuoi mangiar cena, mi devi dare due soldi». Ero mica io quel bambino là? Voi non avete mai provato niente. (pp. 69-70).
Anche l’amore deve sottostare alle logiche economiche e l’idillio tra Agostino e Fede, in una relazione caratterizzata da un manzoniano eros negato, si interrompe per l’arrivo al Pavaglione del padre e del fratello della ragazza: «Io fui l’ultimo a sapere che Fede era stata chiesta in sposa da uno dei fratelli Busca di Castino e i suoi erano volati su a prenderla nella paura di perder per un’ora l’affare, perché così la loro fede si sposava nella roba» (p. 80).
Il tema del denaro, sottolineato da questi (tra i tanti possibili) riferimenti, non collega soltanto Fenoglio a Verga, ma può essere fruttuoso per legami con altre opere della letteratura italiana novecentesca inserite nel canone; ricordiamo infatti che, nella Prefazione de La coscienza di Zeno, il dottor S., dopo aver sostenuto di pubblicare «per vendetta» le memorie del paziente, aggiunge: «Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura». Nel capitolo finale, poi, intitolato Psico-analisi e scritto in forma diaristica, denaro e salute sono tra di loro connessi: «Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare l’incenso quale un surrogato della resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l’importo che m’era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute». Una ricerca delle occorrenze della parola denaro e denari mostra infatti che la prima ricorre ben 57 volte e la seconda 24 nel romanzo sveviano, che dedica d’altra parte un lungo capitolo, il settimo, all’associazione commerciale con il cognato Guido Speier, col tentativo di Zeno di ripianare i debiti del cognato. La malora può essere a ragione inserita tra le tante opere del Novecento che tematizzano il denaro come elemento che priva le relazioni di autenticità e svilisce l’homo sapiens a homo oeconomicus (per approfondire, si veda la voce denaro nel volume di R. Luperini, E. Zinato, Per un dizionario critico della letteratura italiana contemporanea, Carocci, Roma 2020, pp. 64-68).
Tra Manzoni e Verga: un cortocircuito di intertestualità
Leggendo l’opera, emergono poi dei tasselli tanto manzoniani quanto verghiani, evidenti non solo nell’ambientazione contadina e nella messa al centro di personaggi umili, quanto in determinati snodi testuali e in alcune riprese narrative.
Si pensi anzitutto alla cena dal mezzadro Rabino descritta nelle pagine iniziali: «A mezzogiorno come a cena passavano quasi sempre polenta, da insaporire strofinandola a turno contro un’acciuga che pendeva per un filo dalla travata; l’acciuga non aveva già più nessuna figura d’acciuga e noi andavamo avanti a strofinare ancora qualche giorno, e chi strofinata più dell’onesto […], Tobia lo picchiava attraverso la tavola, picchiava con una mano mentre l’altra fermava l’acciuga che ballava al filo» (p. 12). Anche se è indubbio che Fenoglio, novello demopsicologo, abbia ricavato tale descrizione dai racconti che andava raccogliendo munito di penna e taccuino nelle Langhe non ancora inondate dal progresso, per un lettore attento questo passo non può che ricordare l’arrivo di Renzo alla casa di Tonio, descritto nel capitolo VI dei Promessi sposi: «Andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta d’un certo Tonio, ch’era lì poco distante; e lo trovò in cucina, che, con un ginocchio sullo scalino del focolare, e tenendo, con una mano, l’orlo d’un paiolo, messo sulle ceneri calde, dimenava, col matterello ricurvo, una piccola polenta bigia, di gran saraceno». La polenta viene insaporita da un “pesce letterario”, quelle acciughe che ricorrono con insistenza nei Malavoglia di Verga, già nel capitolo iniziale, con la presentazione della famiglia Toscano e della Longa, definita «una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia». Nel capitolo quarto le acciughe diventeranno poi oggetto dei dialoghi dei popolani, preoccupati delle conseguenze per l’economia locale di una nuova imposta sul sale usato per conservarle: «Metteranno pure la tassa sul sale! — aggiunse compare Mangiacarrubbe. — L’ha detto lo speziale che è stampato nel giornale. Allora di acciughe salate non se ne faranno più, e le barche potremo bruciarle nel focolare».
Ma le similitudini strutturali con il primo romanzo del ciclo dei Vinti non finiscono qui: come la sventura dei Toscano deriva dal desiderio di padron ‘Ntoni di cambiare stato, che lo porta a fare commercio con lo Zio Crocifisso per la partita di lupini, dalle prime pagine del racconto fenogliano apprendiamo che la causa iniziale della miseria in cui versa il protagonista può essere rinvenuta nel fallito tentativo del padre di migliorare il proprio status sociale. Stanco della coltivazione diretta dei campi, Giovanni Braida aveva infatti provato a tirare «il colpo alla censa di San Benedetto» (p. 4), ovvero ottenere in gestione la tabaccheria, solo che, mortificato nell’orgoglio per non averla spuntata, una volta costretto a riabbracciare il lavoro dei campi, «aveva perso molto di voglia e di costanza» (p. 5). Insomma, anche i Braida sono affetti dalla «vaga bramosìa dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio», dipinta nella Prefazione ai Malavoglia. Tuttavia, come hanno sottolineato acuti commentatori (Eugenio Corsini e Valter Boggione tra tutti), la suggestione verghiana, prova che Fenoglio condivideva il clima neorealista, si mescola con riprese dalle Sacre Scritture: Agostino Braida si configura come una sorta di Adamo nel Novecento, in quanto nella sua vicenda, come lo stesso autore aveva chiarito parlando con lo stesso Corsini, «si può vedere un riflesso della […] storia dell’allontanamento dell’uomo dal paradiso terrestre».
Le similitudini con il romanzo verghiano uscito nel 1881però non si esauriscono qui: sotto l’egida di due padri-padroni, Giovanni Braida e poi Tobia Rabino, il personaggio rappresenta una sorta di variante novecentesca di Alessi, in confronto a un novello ‘Ntoni rappresentato dal fratello Stefano Braida. Nelle pagine iniziali della Malora si ripropone infatti una scena del capitolo iniziale dei Malavoglia, con un personaggio che è chiamato alla leva, provoca la disperazione della famiglia e, una volta uscito dal cronotopo dell’idillio familiare, muta radicalmente, dal momento che è riuscito, come ‘Ntoni, «a mangiare pasta e carne tutti i giorni»:
Poi il re chiamò Stefano a soldato, andò alla leva e tirò un numero basso. Nostro padre bestemmiò, nostra madre pianse, ma Stefano lui era contento. […] Ci scriveva, e leggevamo che era in artiglieria e a Oneglia. Di questa città io non sapevo altro che era in riva al mare, avrei aspettato che venisse in licenza per domandargli qualche cosa sul mare. […] Lo congedarono dopo ventun mesi, s’era fatto più massiccio e più superbo, gli ci volle un mese buono per riabituarsi al lavoro e ripigliarlo, adesso andava tutte le sere all’osteria e tante notti rientrava ubriaco del vino che gli offrivano in paga del suo raccontare (pp. 7-8).
Nel finale della Malora, Agostino torna alla casa da cui si era allontanato, come avviene per ‘Ntoni nei Malavoglia, ma la conclusione si presta, a mio avviso, al medesimo conflitto di interpretazioni che aveva opposto, sulla conclusione verghiana, Luperini e Russo. Dopo la partenza di Stefano, chiamato come primo garzone alla «censa» degli zii di Mombarcaro, Agostino saluta i Rabino per ritornare alla dimora del padre. Alcuni critici, tra cui Corsini, vedono nel finale il riscatto del fedele che, dopo aver passato tre anni in esilio, può finalmente godere della visione dell’Albero dell’Eden, in un paesaggio caratterizzato dalla vigna (albero del Signore) e da un melo in germoglio, simbolo di rinascita. Tuttavia, se leggiamo bene le parole della donna, si tratta di un finale, come quello dei Promessi sposi, senza idillio: il fratello Emilio, sorta di alter ego di Agostino, sta per morire, la madre è vecchia, affaticata, e prega il signore di non vivere a lungo: al povero protagonista si prospetta dunque un futuro di solitudine e di duro lavoro. Inoltre, l’espressione «teniamo la mano sulla testa d’Agostino» starebbe a indicare l’auspicio della madre che Agostino non tenti il suicidio nel Tanaro, come hanno fatto tanti della «razza langhetta» (p. 17).
L’interesse dell’opera risiede poi, a mio avviso, oltre che negli echi manzoniani e verghiani, anche nella condivisione di una sorta di “aria di famiglia” con quei romanzi di inizio Novecento che avevano tematizzato il rapporto padre-figlio. Se ritorniamo infatti all’incipit citato in apertura, noteremo che Agostino è introdotto in scena nel momento in cui deve affrontare l’avvenimento, per Freud, più importante della vita di un uomo, ovvero la morte del padre, corrispettivo dell’Überich. Nel racconto, però, alla figura di Giovanni si sostituisce quella di Tobia Rabino, il mezzadro a cui viene venduto, e che ne eredita i connotati di padre castrante e autoritario: i figli «sapevano bene che bastava una tempesta un po’ arrabbiata e un piccolo conto nella testa di loro padre per spedirli tutt’e due a far la mia medesima fine lontano da casa» (p. 12). Bestemmiatore, capace di alzare le mani contro la moglie, definita più volte «bagascia», Tobia sembrerebbe esercitare un’autorità assoluta sul Pavaglione, ma questa viene incrinata da due personaggi che vogliono rovesciarne il potere: il primo è Mario Bernasca, tentatore che prova a coinvolgere (invano) Agostino nel suo disegno utopico di fuga dalla miseria langarola; Bernasca odiava il padre e ripeteva che «la più brutta giornata per lui era quando suo padre veniva da Barbaresco a riscuoter l’annata» (p. 46). Il secondo personaggio che cerca di ribellarsi è Jano che, davanti a un attonito Agostino, vuole vendicare la madre sottomessa al padre:
– Vigliacco d’un padre, ma lo sai che io t’ammazzo con un pugno? Mentre la padrona cominciava a gridare, Tobia disse a Jano: – Che bel gesto che faresti, uno giovane come te a picchiare un vecchio come me, – ma parlando s’era chinato alle patate e quando si ridrizzò aveva un falcetto in mano. […] Salì invece dal rittano la voce di Jano che faceva a suo padre: – Assassino, assassino, sei un assassino! – Tobia andò fin sull’orlo del rittano e gridò giù: – A te ti dico questo: prova solo a non trovarti sul lavoro domani mattina. Ti dico solo questo (pp. 68-69).
Nell’universo fenogliano, però, non è previsto nessun Edipo uccisore del padre, ma si ripete quella dinamica di sottomissione e di forza repressiva ben rappresentata in Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi (uscito nel 1919); il potere che esercita Tobia Rabino sulla famiglia è simile a quello di Domenico Rosi, che si manifesta nella famosa scena della castratura degli animali nel podere, in cui emerge, anche qui, l’enfasi sul denaro e l’uso delle bestemmie, caratteristiche anche del mezzadro presso cui lavora Agostino Braida.
Le donne della Malora
Interessante è anche l’analisi della dicotomia tra uomini e donne, con queste ultime vere e proprie vittime sacrificali di una società patriarcale. Tutti i personaggi femminili della Malora subiscono un medesimo destino di sottomissione e di mancanza di scelta, pedine in matrimoni d’interesse pilotati dalle ragioni della roba; tuttavia, solo da tre di loro, ovvero Melina, la figlia Ginotta e la serva Fede, Agostino riceverà dei gesti di umana compassione. I matrimoni sono concordati tra uomini, senza che la futura sposa possa dire alcunché, come nel flashback che rievoca il fidanzamento dei genitori (la voce è qui del nonno di Agostino): «M’hai fatto un gesto dei più belli, bagascia, ti sei presentata a Braida proprio con un gesto dei più belli. – E poi disse a mio a mio padre: – E va bene. Come per le altre nostre tre figlie. Perché io e questa vecchia qui ne abbiamo messe al mondo quattro di figlie, lo saprai, e tre hanno già famiglia. […] È venuta l’ora anche di Melina» (p. 40).
Una stessa dinamica coinvolge la figlia del mezzadro Rabino, Ginotta, contrattata dal «sensale d’Amabile» come fosse al mercato: «- Rabino, non pigliatevela, ma il mio uomo vuole che gli aggiungiate un marengo. […]. Disse: – Ha considerato Amabile che lui è particolare, mentre io sono solo un mezzadro? Eppure gli do la mia figlia sana, tutt’altro che brutta e ancora così com’è uscita da sua madre, e lo ho fatto quattro marenghi di dote» (p. 23).
Più amara, perché coinvolge il protagonista, è invece la vicenda della terza donna del racconto, la serva Fede, figura mariana che allude nel nome a un amore cristiano tutto spiritualizzato; caratterizzata da umiltà, pudicizia, decoro, pazienza, la ragazza ha la capacità di far diventare il Pavaglione «il posto più bello di tutti» (p. 78). Tuttavia, anche in questa vicenda di amore tra Agostino e Fede si intromette la logica del denaro e dell’amore carnale: la ragazza è ceduta in sposa al più giovane dei Busca, famiglia di soli uomini dai tratti demoniaci, descritti così da Tobia: «Sono tre boia, neri come il carbone, senza una donna in casa, ma hanno il più bel boccone di terra che ci sia a Castino» ( p. 80). A completare il quadro desolante di una donna votata al sacrificio e, verosimilmente, vittima di violenza domestica, è la frase della moglie di Rabino: «Ho paura che quei boia più vecchi abbiano fatto sposar Fede al più giovane per usarla poi tutt’e tre. Povera figlia». (p. 81).
Un bilancio di lettura
Lungi, quindi, dal pericolo di finire catalogato, come aveva temuto Vittorini, insieme ai «provinciali del naturalismo, i Faldella, i Remigio Zena», il Fenoglio della Malora consente ancora oggi molteplici sentieri di ricerca e di approfondimento, all’interno e fuori dal testo. La sensazione è di un’opera che sfugge a un’interpretazione univoca e che lascia spazio a numerosi approcci, che ne illuminano aspetti specifici. Tuttavia, credo che, attraverso la presenza di personaggi privi di grande spessore psicologico e riconducibili a una matrice simbolico-allegoria, con La malora Fenoglio abbia voluto consegnare al lettore una vicenda archetipica, valida per ogni tempo. Avvalorano tale ipotesi di lettura l’uso, come prima parola del racconto, di «Pioveva», un verbo all’imperfetto, tempo della durata e della ciclicità che ricorre, d’altra parte, in buona parte del racconto. L’imperfetto comunica l’idea di una storia che si ripete in ogni tempo e a ogni latitudine: quella di un innocente che deve affrontare una vita di ingiustizie e prove, ma a cui nel finale si prospetta una possibilità di salvezza, che dovrà però guadagnarsi, secondo un’ottica calvinista, con il duro lavoro.
Oltre a questo aspetto, però, è nella frase di copertina, che definisce La malora «Una vivida rappresentazione di quanto può essere aspro l’uomo con l’uomo», che risiede, a mio avviso, un’ulteriore chiave di lettura di un’opera che può ancora dire molto non solo sulle Langhe di inizio Novecento, ma soprattutto sui rapporti hobbesiani di sopraffazione che permeano la società contemporanea. La violenza, significativamente, apre e chiude il racconto: nell’incipit è quella della pioggia incessante, da Diluvio universale, tipica di Fenoglio e presente anche nel finale di Una questione privata. Nel finale la violenza appare, invece, sorprendentemente, associata a un personaggio femminile, Melina, interpretata da vari critici (tra cui Elisabetta Soletti) come una figura cristologica; la donna si rivolge a Dio, scusandosi così: «E […] usami indulgenza per cosa ho fatto per forza» (p. 85). La violenza è quindi un elemento innato nell’essere umano, pervade il mondo, si insinua anche negli individui più puri e il messaggio di Fenoglio è che non sia un dato facilmente interpretabile; tuttavia, l’esempio di Agostino, novello Adamo, e il suo tentativo di ritornare alla terra e ricostruire un Eden nell’ostile paesaggio langarolo attenuano la coloritura tragica del racconto con un barlume di speranza per il futuro del personaggio e, aggiungo, di noi lettori.
Articoli correlati
Comments (1)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Valido articolo, La malora è un testo che nel bene o nel male non può non lasciare un segno, specie nel cuore di chi apprezza Fenoglio. Sono riuscito perfino a farlo leggere a mia madre insieme a Casa d’altri di Silvio D’Arzo…
Ho trovato interessante il paragrafo dedicato alla tematica della roba che si può collegare con la novella verghiana e Mastro Don Gesualdo. Non avevo pensato anche a un possibile aggancio con Italo Svevo, ringrazio l’autore per aver proposto questo rimando prezioso.
Da non sottovalutare la lettura simbolica con rimandi alla Bibbia e la presenza della figura del padre castrante come in Federigo Tozzi.
Segnalo, infine, l’articolo di Guido Baldi “La malora: mondo contadino e male ontologico” (contenuto nel volumetto “Alla ricerca di Verga nel Novecento”). Ne riporto il finale: «La realtà che è al centro dell’attenzione dello scrittore, storica e sociale, appare solo quale la manifestazione fenomenica ed esemplare di una condizione assoluta, metafisica, ma di una metafisica “dissacrata”: è un mondo disperato, segnato dal male e dalla sofferenza, che non offre lo spiraglio di un’alternativa né nella storia né nel trascendente.»