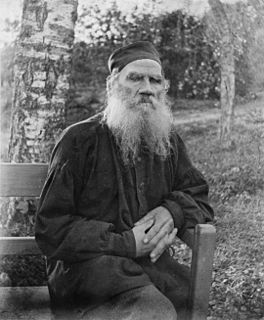
Perché e come leggere Il padrone e il lavorante di Tolstoj
1 – Questo lungo racconto (che appare in qualche traduzione anche con il titolo Il padrone e il servo), apparso nel 1895, dunque nel corso della tarda maturità di Tolstoj, non ha nulla da invidiare a simili opere più note, come La morte di Ivan Ilich (un indiscutibile capolavoro, apparso nel 1886), o La sonata a Kreutzer, o ancora Cholstomer, ma resta probabilmente un po’ in ombra, almeno in Italia, forse perché meno accattivante nell’argomento e apparentemente monotono nella sequenza narrativa. Personalmente lo considero uno fra i vertici di Tolstoj, per le ragioni che esporrò nel seguito, ma in primo luogo per la seguente: per aver Tolstoj disciolto e dissolto in esso, nell’azione e nel dialogo, nei gesti e nelle descrizioni e insomma nella rappresentazione, quel moralismo che spesso permea la sua opera, specie la più tarda, e nell’aver al contempo fornito spunti di critica tanto al vecchio mondo patriarcale quanto al “nuovo” mondo borghese. Per gli studenti e per i docenti può inoltre essere fruttuoso raffrontarne certi temi e spunti con quelli che provengono da Verga, sia da I Malavoglia (per certi dettagli della piccola comunità di villaggio che si incontra a un certo punto) sia da Mastro-don Gesualdo (per i tratti rappresentati nel padrone e nella sua concezione del tempo): ciò, naturalmente, nel migliore dei mondi possibili. Del racconto desidero fornire una sintetica presentazione, alternata a suggerimenti o ipotesi interpretative.[1]
La narrazione si articola in dieci capitoli o forse capitoli di diversa ampiezza, e gli eventi vi si svolgono fra un pomeriggio e una notte di freddo vento e neve, negli anni settanta dell’Ottocento, precisa la voce narrante. Non è un dettaglio inutile. L’abolizione della servitù della gleba, avvenuta definitivamente in Russia nel 1861, svincola il servo dalla terra e lo trasforma in un salariato e più raramente in un piccolo possidente, mentre dà spazio crescente alla proprietà che chiameremo “borghese”, che si era già diffusa nel corso dell’ultimo secolo, a seguito di processi lenti ma simili a quelli che si erano già sviluppati in varie aree europee complessivamente arretrate (basti pensare proprio alla Sicilia fra fine Settecento e guerre napoleoniche, e poi oltre, fino all’Unità e anche dopo): la dinamica messa in moto, ma già pressante all’interno della società russa, e non da pochi decenni, per quanto ne so, è dunque quella di una relativa modernizzazione; ma un nuovo immaginario “mercantile” stenta a diventare culturalmente egemone, in un mondo produttivo e sociale legato radicalmente alla terra e alla struttura feudale, oltre che disperso in un immenso territorio difficile e povero, se non misero. L’ambientazione è apparentemente quella di un vasto e indeterminato territorio, ma in realtà, come scopriremo leggendo, si riduce sensibilmente a un cerchio ristretto di villaggi e strade nella sterminata pianura sarmatica, non troppo lontana da Mosca (sapremo più avanti accidentalmente che la località di partenza di chiama Kresty). I due protagonisti sono Vasilij Andreic Brechunòv, il padrone, e il cinquantenne mužik Nikita, il lavorante tuttofare, di buon carattere e buon umore. Il primo quadro ci presenta, con pochi tratti, una situazione “realistica”. Brechunòv è il tipico affarista arricchito e avido, imbroglione e privo di scrupoli, che ha anche un ruolo sociale nella sua piccola comunità, e deve partecipare di malavoglia a una cerimonia festiva, mentre il suo pensiero è fisso su un affare che vuole a tutti i costi portare a termine, l’acquisto di un boschetto che promette di rendere bene con taglio e la vendita ciclica del legname. Così, appena finiti i rituali, fa attaccare il cavallo alla slitta e parte con Nikita, nonostante il cattivo tempo: vuole arrivare prima di certi altri mercanti che sa interessati all’acquisto. Finito il primo capitolo, in tutto il resto del racconto la cornice realistica si riduce e si disfa pian piano per lasciare spazio crescente a una dominante simbolica, messa in evidenza in primo luogo dall’opacità del paesaggio innevato e minaccioso; d’altra parte tale dominante è marcata da una serie di rilevanti segnali e indicatori spazio-temporali, peraltro dissimulati e quasi dissolti nella fluidità del racconto: e si tratta, a mio parere dell’aspetto più importante e inquietante del racconto. Ma senza lo spazio realistico del primo capitolo e della parte finale dell’ultimo, e di certi passi e dettagli altrettanto e forse più decisivi, la dimensione simbolica (appare problematico parlare di allegorismo, in Tolstoj) perderebbe il suo senso: come sempre avviene negli scrittori veramente grandi. Non posso, naturalmente, entrare in troppi dettagli, ma debbo almeno segnalarne uno: Brechunòv fuma una sigaretta, e altre ne fumerà nel corso della notte di tregenda che segue. Non so se questo fatto potesse essere comune negli anni settanta dell’Ottocento, ma tendo a ritenere di no; nel mondo feudale e patriarcale ci si può aspettare la pipa, il sigaro (per i più ricchi), non tanto una sigaretta, segno di un rapporto nevrotico col tempo; all’opposto il lavorante Nikita ha stabilito quasi un rapporto fra pari col cavallo, soggetto pieno di vitalità, intelligenza e abnegazione quasi intenzionale, decisamente poco credibile, ma indicativo del rapporto che Tolstoj stabilisce con la creaturalità.
2 – Partono dunque i due con la slitta in tutta fretta, quando la tormenta si approssima. Ma Brechunòv, come si è visto (e così è per Gesualdo), il tempo è una funzione del guadagno, il dominus della sua personalità, il suo daìmon, e gli fa commettere azzardi oltretutto irrazionali. Seguiamo il percorso dei due: il primo azzardo è quello di scegliere una scorciatoia meno sicura e meno battuta; Nikita non è convinto, ma cede subito (come sempre farà, del resto, e come ha sempre fatto), così la slitta svolta a sinistra: anche questo dettaglio non è, forse, casuale: la sinistra, nell’immaginario diffuso e consolidato (ne parla anche Freud) indica l’errore, l’allontanamento dalla retta via, e dunque questo cenno ci trasporta già nel simbolico. Ben presto, infatti, smarriscono la via, Nikita sonda il percorso e suggerisce di andare verso destra; ma anche questa soluzione è senza uscita; infine andando diritti s’incontra finalmente una casa, poi un piccolo villaggio, Griškino, che entrambi riconoscono; per strada un uomo dà indicazioni per ritrovare la via, ma suggerisce loro di fermarsi al villaggio e ripartire l’indomani; Brechunòv naturalmente non cede, e riparte fiducioso: la via non è lunga. Ma ben presto i due si perdono nuovamente, e dopo una serie di giravolte e qualche inquietante incontro (una slitta di ubriachi che maltrattano la loro cavallina, una sorta di rappresentazione decentrata del male: un «motivo libero», ossia svincolato dalla trama) si ritrovano ancora a Griškino.
Qui infine Brechunòv si rassegna, e accetta l’ospitalità che la piccola comunità, poco più che parentale, offre ai due dispersi viandanti. Entrati nella confortevole e calda stanza comune che li accoglie, essi si riscaldano, bevono thè (soprattutto Nikita, che ha fatto voto di non bere più alcool), discutono con gli abitanti della casa. Il dato più interessante di questa discussione (siamo al IV capitolo) è la lamentela del capofamiglia i giovani non vogliono più ascoltare i vecchi, fanno di testa loro; uno dei figli è andato a vivere a Mosca, e non torna quasi mai. E soprattutto si lamenta dell’intenzione, che hanno i figli, della separazione, ossia della divisione dei beni familiari. Il vecchio è decisamente contrario: a dividere la casa, «poi sarebbero dovuti andar via tutti a mendicare». Questo passo, non brevissimo, è un rallentamento dell’azione di tipo “epico”, secondo una tradizione interpretativa moderna che risale a Goethe; e, per chi volesse approfondire, tale rallentamento dell’azione contrasta con la brevitas, ossia con la monotematicità sintetica della novella, orientata a scegliere ad oggetto lo stato di eccezione: in questo caso la pericolosa traversata notturna della steppa. Il racconto si pone perciò ai margini del genere “novella”, senza per questo diventare un romanzo. Per tornare all’argomento: ricordate analoghe discussioni in Verga, nei Malavoglia, e l’allontanamento fra il necessario e il volontario di ‘Ntoni? Non siamo poi così distanti. D’altro canto questa digressione non è affatto scollegata dal resto della narrazione, ma in qualche modo ne anticipa e rafforza il tema e il messaggio, anche ideologico. Il mercante-affarista ha già fatto la sua scelta, infatti, e il «tempo del mercante» (di cui ha scritto tempo fa il noto storico francese Jacques Le Goff), discontinuo e segmentato, volto all’utile e al lavoro concitato per fare affari (e qui non possiamo non ricordare Mastro-don Gesualdo), un tempo opposto a quello ciclico e rituale della vecchia cultura contadina e idillica, è quello che lo segna ormai in profondità. Così, dopo un certo tempo di sosta, il padrone decide ancora una volta di ripartire a tarda sera, restio a tutte le proteste dei presenti che lo esortano alla prudenza e ad aspettare il mattino. Nikita, naturalmente, non fa resistenza. L’unica precauzione di Brechunòv è quella di farsi accompagnare per un primo tratto da un giovane del posto, fino a un certo bivio.
3 – Ma nella tormenta i due uomini e il cavallo (grande intenditore e amante di questi animali, Tolstoj li tratteggia quasi come umani) fra varie giravolte si perdono per la terza volta. A nulla valgono, nella notte, i tentativi di sondare il terreno circostante. Siamo al capitolo V. Il cavallo si ferma, stremato, la slitta rimane in un punto indeterminato. Questi passi del racconto sono punteggiati dal ricorrere ossessivo, certo non casuale, della locuzione avverbiale «di nuovo» (o altre consimili). Di nuovo fra la neve e il vento, di nuovo a tastare il terreno, di nuovo a ritrovarsi al punto di partenza. L’indicazione della circolarità del movimento, della sua iterazione, è uno di quei «segni» che Juryi Lotman ci ha insegnato a prendere in esame nei testi (nota è la contrapposizione fra movimento orizzontale, della dispersione e della ricerca, e movimento verticale del rapporto uomo-Dio nel canto di Ulisse nella Commedia dantesca). Ma il cronotopo che qui si costruisce (cioè la convergenze cooperativa di tempo e spazio, e anche di movimento circolare) non è quello della ripetizione tipico dell’idillio o, se vogliamo, del «tempo della chiesa», del circolo ripetitivo delle attività agricole e della convivialità fra vicini, ma l’aggirarsi su se stessi, vano e inutile, angosciante e martellante, determinato quasi dal destino, ma causato dalla colpa (l’abbandono della retta via), dalla hybris di Brechunòv, che non ha trovato ostacolo nella rassegnata passività di Nikita. Il padrone non guarda alla realtà, non la vede neanche. E anche quando deve rassegnarsi a passare la notte nel luogo che la sorte ha scelto, la sua ossessione è sempre quella degli affari. E difatti i suoi pensieri, lungo tutto il successivo capitolo, il VI (egli è comodamente disteso all’interno della slitta con la sua calda pelliccia, mentre Nikita si è seduto immobile in un angolo ricavato nella parte posteriore slitta), sono occupati integralmente dai conteggi sui guadagni che poteva fruttargli il boschetto che si accingeva a comprare (a un prezzo molto inferiore a quello del valore reale) e a lodarsi per la sua sagacia in affari, per la sua ostinazione al lavoro e agli interessi, per il suo vegliare sempre, anche di notte; in tal modo la sua sfera di affari, di lui figlio di un modesto mužik arricchito, si è ampliata; ed enumera i suoi beni, frutto di nuovi acquisti (val la pena richiamare ancora don Gesualdo?). E tuttavia, pian piano, mentre percepisce che «intorno, da ogni parte, davanti, dietro, vi era ovunque una medesima, uniforme, bianca, ondeggiante tenebra», si insinua in lui la paura: la paura della morte (che richiama il finale dell’altro grande racconto, La morte di Ivan Ilich), evocata, fra l’altro, anche dal ricordo di un conoscente che, passata la notte come lui, nella tormenta, era stato ritrovato l’indomani «bell’e morto, tutto duro, come un quarto di bue congelato»; e, visto che non sto dando conto di un giallo, anticipo che con lo stesso enunciato e la stessa similitudine sarà presentato anche lui, a distanza di parecchie pagine, quando a sua volta sarà ritrovato. Ma andiamo con ordine: constatato con angoscia che il mattino è ancora lontano, il mercante decide di tentare la sorte, e faticosamente riesce a montare a cavallo e partire senza meta. Pensa anche a Nikita, ma solo per riflettere sul fatto che a lui, privo di prospettive di vita gratificanti, non può importare granché di morire. Anche Nikita passa la notte sistemandosi come può dietro la slitta (siamo nel breve capitolo VII); ma, a differenza del padrone, egli sta immobile, in attesa paziente di qualunque sorte possa toccargli, prono al destino e alla natura, quasi senza pensieri, se non un breve esame di coscienza, un ripasso dei pochi momenti belli della vita e dei suoi peccati, e la considerazione che se bisogna morire non c’è niente da fare; diversa la situazione del padrone, la cui vita era certamente aperta a benessere e successo. E Nikita, fra questi pochi pensieri, addirittura si addormenta. Si sveglierà presto, quando sente i movimenti del padrone che tenta la fuga. Ma non può far nulla, se non distendersi nella slitta e rivolgere una breve preghiera al «padre celeste», perdendo pian piano conoscenza.
4 -Frattanto (capitolo VIII) Vasilij Andreic Brechunòv si lancia alla ventura nella tormenta; ma il suo è un viaggio alla cieca, accompagnato ormai dal crescente terrore, dalla prima consapevolezza che né i beni e la ricchezza, né le cerimonie religiose o l’offerta di candele ai santi possono qualcosa in quell’angosciante situazione. S’intensificano, nella scrittura, i soliti avverbi che rimandano alla ripetizione e all’angoscia («di nuovo» e simili), e il padrone pian piano perde di nuovo la via, senza trovare alcun punto di riferimento. Il cavallo sprofonda in un fossato, e scappa via, e lui rimane solo; ne cerca per un po’ le tracce, ma non lo ritrova se non per caso mentre vaga per la distesa di neve: il cavallo ha ritrovato la slitta, e lui deve accorgersi che non ha fatto altro che aggirarsi intorno, inutilmente.
Il punto di svolta (il Wendepunkt, come lo chiamavano i novellisti tedeschi del primo Ottocento) si ha solo adesso, nel penultimo capitolo, il nono. Inspiegabilmente il padrone, pur in preda all’angoscia, rivolge per la prima volta lo sguardo al lavorante, vede che è semiassiderato e, dopo varie riflessioni non sempre lucide, prende una decisione incredibile: decide di distendersi su Nikita, con cui è riuscito ad avere un breve scambio di battute, e di salvarlo in questo modo da sicura morte. Vasilij Andreic trascorre così qualche ora, pian piano congelandosi, ma frattanto la sua mente è attraversata da immagini, pensieri, allucinazioni che si affollano caoticamente e che riassumono la sua vita e i suoi valori. E pian piano viene preso, dopo l’angoscia, da una gioia crescente (lo stesso processo leggiamo nel tempo del transito alla morte di Ivan Ilich, quasi a testimoniare il legame fra i due testi): la gioia è legata alla morte stessa, ma anche al fatto che adesso egli sa quali erano i valori veri, da lui sempre trascurati. L’attesa di qualcuno o qualcosa che deve venire (la morte, ma anche lo voce divina, inestricabilmente legati assieme) è per questo gioiosa. Il padrone muore assiderato, ma in tal modo dà la vita a Nikita. Anche quest’ultimo è attraversato da immagini e sogni, molto più semplici, legati sempre alla morte: con paura, certo, ma anche con la consueta rassegnazione. Ma il sacrificio del padrone lo salva, e il finale, nel decimo capitolo, quello conclusivo, ci riporta rapidamente a un quotidiano contesto di vita e lavoro, fino alla fine di Nikita, vent’anni dopo. «È morto soltanto quest’anno», dice bruscamente la voce del narratore, lieto di liberare figlio e nipoti «dal peso di una bocca inutile».
5 -L’interpretazione dell’improvvisa conversione e del conseguente sacrificio del padrone è ardua, una sorta di enigma su cui tenterò di formulare qualche precaria ipotesi. La prima riguarda l’ideologia umanitaria, sebbene di stampo paternalistico, che Tolstoj ha progressivamente elaborato negli anni e che lo porta, fra l’altro, a costituire una sorta di comune contadina nella sua antica tenuta di Jasnaja Poljana, dove da tempo ormai vive: per questa ragione il padrone deve mettersi al servizio del contadino lavoratore e bisognoso. Una seconda ipotesi, aggiuntiva, è tuttavia la seguente: che nello scrittore compaiano echi della cosiddetta teoria (hegeliana) del servo-padrone, secondo la quale il padrone è destinato, nel tempo, a soccombere al servo (si parla, ovviamente, di funzioni sociali, non di relazioni personali). Una lettura di Fortini, contenuta fra i saggi di Verifica dei poteri, darebbe forza a questa ipotesi: «Nell’attimo in cui il proprietario comprende i valori dell’antagonista e cessa di credere ai propri, la sua morte è decretata: ma quella morte è anche la sua salvezza […] La morte di Vassilij è la morte simbolica della classe proprietaria, il prezzo della salvezza di quella, mistica per Tolstoj, storica per noi».». Confesso però che l’improvvisa “conversione” del padrone rimane per me in buona parte enigmatica, come la eco di un indicibile. Indiscutibile è invece la suggestione che scaturisce dall’ etica del vivente che sgorga dalle pagine tolstojane: dall’abbandono che provano i personaggi più umili (ma anche gli animali e le piante, il vento, la luce e il buio), di fronte al susseguirsi delle stagioni, allo scorrere del tempo, alla comunità umana, alla necessità. La presenza della morte, per meglio dire la sua onnipresenza nell’opera, non la smentisce, anzi la conferma. La morte, come lui la concepisce e la rappresenta, è quel limite che ridisegna in un istante il significato di una vita (su questo sono illuminanti alcuni passi di Benjamin, guarda caso dal saggio sul Narratore), ed è per questo, come vediamo nei suoi personaggi, una gioia, un sapere profondo: la morte è in lui null’altro che la vita depurata dei suoi mali, che riconquista i suoi spazi di verità.
[1] Traggo il testo da L. Tolstoj, Tutti i racconti, a c. di Igor Sibaldi, Mondadori, Milano 1991, vol. 2°, pp. 606-669.
Articoli correlati
Comments (1)
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Felice Rapazzo mi ha fatto comprendere ben più di quello che avevo tentato di capire di questo breve enigmatico racconto. Grazie