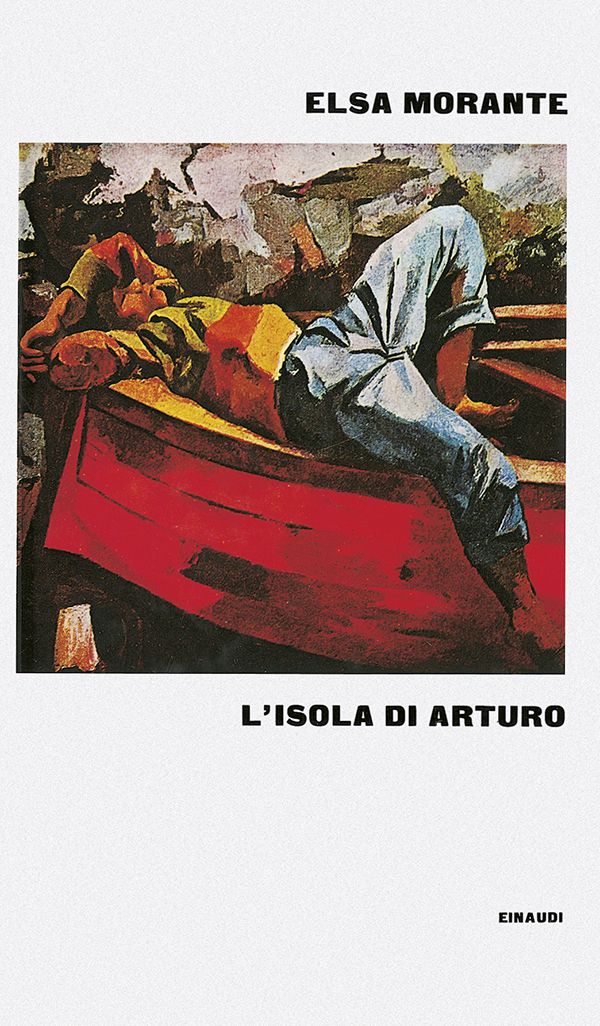
Perché leggere L’isola di Arturo di Elsa Morante
Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato (fu lui, mi sembra, il primo a informarmene), che Arturo è una stella: la luce più rapida e radiosa della figura di Boote, nel cielo boreale! E che inoltre questo nome fu portato pure da un re dell’antichità, comandante a una schiera di fedeli: i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, e dal loro re trattati alla pari, come fratelli.
Purtroppo, venni poi a sapere che questo celebre Arturo re di Bretagna non era storia certa, soltanto leggenda; e dunque lo lasciai da parte per altri re più storici (secondo me, le leggende erano cose puerili). Ma un altro motivo, tuttavia, bastava lo stesso a dare, per me, un valore araldico al nome Arturo: e cioè che a destinarmi questo nome (pur ignorandone, credo, i simboli titolati), era stata, così seppi, mia madre. La quale, in se stessa, non era altro che una femminella analfabeta; ma più che una sovrana, per me.
Elsa Morante, L’isola di Arturo, Einaudi, 1957 [ed.1992, p.11]
Ma non è questo, in verità, l’incipit del romanzo forse più noto di Elsa Morante (Premio Strega nel 1957), perché a precedere il racconto di Arturo Gerace, sospeso tra leggenda e storia, la scrittrice volle una sua poesia, non meno nota, con dedica oltremodo esplicita a Remo N., Remo Natales, anagramma di Elsa Morante; questa:
Quello che tu credevi piccolo punto sulla terra,
fu tutto.
E non sarà mai rubato quest’unico tesoro
ai tuoi gelosi occhi dormienti.
Il tuo primo amore non sarà mai violato.
Virginea s’è rinchiusa nella notte
come una zingarella nel suo scialle nero.
Stella sospesa nel cielo boreale
eterna: non la tocca nessuna insidia. Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e d’Eurialo,
per sempre belli; difendono il sonno del mio ragazzo.
L’insegna paurosa non varcherà mai la soglia
di quella isoletta celeste.
E tu non saprai la legge
ch’io, come tanti, imparo,
— e a me ha spezzato il cuore:fuori del limbo non v’è eliso.
Non ricordo quale dei due incipit dovette apparirmi più suggestivo, se quello poetico o quello narrativo, quando, ancora molto giovane, lessi questo romanzo per la prima volta. So soltanto che ne ho subito per tanto tempo la fascinazione e che adesso, rileggendolo per trarne tre perché, forse ancora mi parla quella suggestione di ragazza; e non mi arrendo ai perché che, da insegnante, magari dovrei più saggiamente indicare ai miei allievi.
La voce narrante – insieme smitizzante e mitopoietica – è quella dello stesso Arturo che, divenuto adulto, racconta la sua adolescenza solitaria in una Procida remota e reale, lontana dagli accadimenti storici, ma fatta di odori, sapori, colori e di ogni sensazione vivissima del vero. Orfano di madre fin dalla nascita, l’ha svezzato a latte di capra un giovane balio, Silvestro, che gli ha insegnato anche a leggere e scrivere e, fino alla chiamata di leva, s’è occupato di lui in vece del padre, Wilhem, indifferente e incurante del figlio, che pure lo adora: frequenti, lunghe, misteriose sono le sue assenze da Procida. L’uomo, nato dalla relazione di un procidano con una donna tedesca, ha vissuto parte della sua giovinezza in Germania e ostenta disprezzo e fastidio nei confronti dell’isola e dei suoi abitanti, che lo ricambiano con egual moneta. Ad accrescere maldicenze e sospetti è anche la dimora dei Gerace: un convento, un tempo imponente, che un eccentrico e ricchissimo spedizioniere, Romeo detto l’Amalfitano, aveva ristrutturato e adibito ad abitazione privata, impedendone sempre l’accesso alle donne e ospitandovi piuttosto spregiudicate riunioni di uomini. L’Amalfitano, divenuto anziano, cieco e solo, è stato per anni l’unico interlocutore dello sdegnoso Wilhem, che, alla sua morte, ne ha ereditato il patrimonio e l’ingombrante casa dei guaglioni, dicerie incluse. Grande scalpore sull’isola, dunque, quando Wilhem vi porta a vivere la sua seconda moglie, Nunziata, una giovanissima napoletana, semplice, ignorante, arrendevole, tutta riccioli bruni; e duro colpo per Arturo, che si vede sottratti dalla ragazza, appena maggiore di lui, anche quei rari momenti che il padre – idolatrato come un dio – gli dedicava. Costretto dalle incessanti partenze paterne a trascorrere lunghi periodi con lei, Arturo ne rifiuta le improbabili attenzioni materne e in tutti i modi tenta di mortificarne il ruolo, le abilità, l’intelligenza, la dignità, la bellezza con offese sfacciate o con l’ostentazione delle sue prodezze o delle sue (invero strabilianti) letture. Sbigottita ma paziente, Nunziata si ritaglia tuttavia la sua dimensione: intreccia rapporti con le donne procidane, cucina, si occupa come può della casa e del figliastro e, alla nascita del piccolo Carminiello, si dà appassionatamente alla nuova esperienza di madre. Arturo, ormai quindicenne, diviene preda di una feroce gelosia; non che il padre abbia più attenzioni per il fratellastro che per lui: a poco a poco Arturo scopre piuttosto che a mancargli sono le attenzioni di Nunziata, e comprenderlo e inorridire sono un tutt’uno. Tutti i baci che Nunziata dà a Carmine, Arturo li vorrebbe per sé; finché davvero, scampato a quella che avrebbe dovuto essere soltanto la simulazione narcisistica di un suicidio, non gliene dà uno. È la frattura: Nunziata, spaventata dalla situazione ambigua e irresistibile, lo tiene a distanza e Arturo, quasi per vendicarsi, intraprende una relazione con una giovane vedova, amica della matrigna, che lo inizia al sesso. Wilhem, rientrato per un periodo insolitamente esteso, sembra non accorgersi di quel che accade tra moglie e figlio, interamente assorbito dalla presenza, nel penitenziario di Procida, di un giovane malavitoso, Tonino, che, terminata la detenzione, si trasferisce brevemente alla casa dei guaglioni. È qui che Arturo lo incontra, scoprendo, in un drammatico faccia a faccia, la vita segreta del padre. Wilhem e Tonino partono insieme e Arturo – disperato, offeso, deluso – cerca dapprima rifugio tra le braccia di Nunziata. Ancora respinto da lei, eppure amato, scappa da casa e, raggiunto quasi miracolosamente da colui che aveva avuto per balio, all’indomani del suo sedicesimo compleanno s’imbarca con lui sul piroscafo che li porterà a Napoli, decisi ad arruolarsi entrambi per l’imminente seconda guerra mondiale.
Tre ragionevoli perché
Da insegnante, dovrei dire che L’isola di Arturo (sottotitolo: Memorie di un fanciullo) ha le movenze di un romanzo di formazione; che Morante lo scrisse come un’acrobata, in bilico tra leggenda e storia, tra cronaca e cuntu, nel clima di un imperante neorealismo, e non fu coraggio da poco; che lo scrisse mescolando gli ingredienti sapienti e solenni di un aedo al dialetto del popolo e alle smargiasserie dei picari, in un impasto sensuale e corposo che oggi mi appare – anche da sola – pietanza assai ghiotta. E avrei già formulato, così, almeno tre ragionevoli perché. Ma voglio provare a rintracciare i perché di allora, che forse sono quelli che oggi mi hanno riportato sull’isola e che forse potrebbero portarci anche i miei allievi; e non solo.
Perché l’Isola è la Reggia di Mida
Non è – ci tengo a precisarlo – retaggio da isolana, benché non nego che l’esserlo mi pare che m’abbia facilitato l’accesso alla grammatica dell’isola. Procida (peraltro capitale italiana della cultura per il 2022), pur essendo riconoscibile, perfino sensibile, è metafora di una dimensione esistenziale i cui confini non sono necessariamente tracciati dall’età giovanile: il limbo fuori del quale non v’è eliso non coincide tout court con l’adolescenza o una fase precisa della vita, ma è rappresentazione simbolica di ogni spazio – necessario eppure disperato, immenso eppure circoscritto – in cui si generano e si alimentano i desideri e le aspirazioni, territorio di sperimentazione su cui ognuno fa la prova solitaria, timorosa e guascona, di sé. Se, da principio, le memorie di Arturo ripercorrono i luoghi dell’isola descrivendoli al modo di un fanciullo che non ammette sovrapposizione o sbaglio, d’altra parte fra le memorie già nelle prime pagine s’insinua la carezza pungente del rimpianto:
Le isole del nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica; e, specie in vicinanza degli antichi crateri, vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rividi mai più i simili sul continente. In primavera, le colline si coprono di ginestre: riconosci il loro odore selvatico e carezzevole, appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno.
Su per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive più piccole, coperte da ciottoli e conchiglie, e nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti, che sovrastano l’acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, s’odono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi accontenterei d’essere uno scorfano, ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua. (p.12)
Man mano che la narrazione procede, l’isola non cambia: non cambiano i «vicoli senza sole», «le botteghe fonde e oscure come tane di briganti», «i procidani scontrosi, taciturni», le donne «che si direbbero delle gatte selvatiche o delle faine» (pp.12-14); ma cambia lo sguardo di Arturo:
La mia disperazione somigliava alla fame e alla sete, pur essendo cosa diversa. E dopo aver tanto sospirato di arrivare a una maggiore età, quasi rimpiangevo le mie età di prima (…) E l’isola, per me, che cos’era stata, finora? un paese d’avventure, un giardino beato! ora, invece, essa mi appariva una magione stregata e voluttuosa, nella quale non trovavo da saziarmi, come lo sciagurato re Mida. (p.267)
Finché, come un giovane Leopardi che scopra la maestosa indifferenza della natura, come un nuovo ‘Ntoni Malavoglia in procinto di lasciare Aci Trezza, anche Arturo dovrà fare i conti con la tragedia di ogni uomo: la scoperta del tempo pulviscolare della propria storia contingente nella ripetizione ciclica del tempo senza scansione:
E d’un tratto, un rimpianto sconsolato mi si appesantì sul cuore, al pensiero del mattino che si sarebbe levato sull’isola, uguale agli altri giorni: le botteghe che si aprivano, le capre che uscivano dai capanni, la matrigna e Carminiello che scendevano nella cucina… (…) Ed era un’orrida gelosia che mi amareggiava, questa: di pensare all’isola di nuovo infuocata dall’estate, senza di me! la rena sarà di nuovo calda, i colori si riaccenderanno nelle grotte, i migratori, di ritorno dall’Africa, ripasseranno il cielo… e in simile festa adorata, nessuno: neppure un qualsiasi passero, o una minima formica, o un infimo pesciolino del mare, si lagnerà di questa ingiustizia: che l’estate sia tornata sull’isola, senza Arturo! In tutta l’immensa natura, qua intorno, non resterà neppure un pensiero per A. G. come se, per di qua, un Arturo Gerace non ci fosse passato mai! (pp.375-376)
Perché è passaporto al varco delle colonne d’Ercole
L’isola si rivela dunque indifferente verso Arturo e si sottrae al suo possesso d’innamorato né per cinismo né per malvagità, ma per natura. È scoperta terribile eppure liberatoria: se l’isola non è di Arturo, il ragazzo non può accampare diritti d’amante, ma non le deve neppure l’obbedienza d’un vassallo o la devozione di un adepto. Arturo pian piano si fa largo verso il varco delle colonne d’Ercole. Lo dice a Nuziata (detta Nunz), sollecita al suo capezzale dopo la sventata messa in scena del suicidio:
Dico le colonne d’Ercole – principiai, – per fare un paragone. Tu lo sai lo stretto di Gibilterra? Quello ai tempi antichi era un punto di lontananza fantastica, perché allora s’andava sempre a remi con barche di misura media. E il passaggio dello stretto aveva le due rive murate da due massicci di roccia, che parevano due pilastri giganti messi per frontiera. Ogni nave ch’era passata là in mezzo, s’era persa con tutto l’equipaggio fino all’ultimo uomo, senza più notizia. (…) Insomma, se lo vuoi sapere, il paragone mio era questo: che anche il destino della morte eterna, dove tutti finiscono, poteva essere un’altra delle tante favole. E che se uno, invece di aspettare e lasciarsi imbrogliare dalla paura come un infimo codardo, si decideva a esplorare, poteva trovare la smentita… (pp.253-254)
E se, nelle memorie di un fanciullo, il varco è solo «invenzione», giacché «il mostrarsi prodi non guasta mai, con le donne» (p.253), nella voce narrante dell’adulto risuona distinta la nota della consapevolezza: avvezzo a lunghe, «silenziose, affascinanti meditazioni sulle carte geografiche», Arturo si sente «simile a un conquistatore nella sua tenda campale»:
…tracciavo delle linee col carbone attraverso gli oceani e i continenti (…) e intorno a questo mio lavoro regnava un grande silenzio sospeso. L’ho chiamato lavoro (…) giacché (…) esso preparava l’azione, della quale nessuna cosa è più bella! Quelle linee di carbone mi rappresentavano la scia sfavillante della nave di Arturo: la certezza dell’azione mi aspettava, come dopo i bei sogni della notte, s’accende il giorno, che è la bellezza perfetta. (…) Io, da quando sono nato, non ho aspettato che il giorno pieno, la perfezione della vita: ho sempre saputo che l’isola, e quella mia primitiva felicità, non erano altro che una imperfetta notte;… (p.187)
Perché insegna com’è fatto il cuore
Ma «uscire per andare alla battaglia» (p.374), uscire, cioè, dall’isola per vivere – e scrivere – consapevolmente la propria storia, è altra cosa che preparare l’azione sulle carte. Alla battaglia non si va senza addestramento e Arturo, «innamorato dell’innamoramento» (p.377), di addestramento, ne ha fatto uno solo: quello del cuore:
Sebbene avessi letto libri e romanzi, anche d’amore, il realtà ero rimasto un ragazzino semibarbaro; e forse anche il mio cuore approfittava, a mia insaputa, della mia immaturità e ignoranza, per difendermi contro la verità? Se ripercorro col pensiero, adesso, fin dal principio, tutta la mia storia con N, imparo che il cuore, nelle sue gare contro la coscienza, è estroso, avveduto e fantastico quanto un maestro costumista. (…) E la coscienza si aggira in questo gioco bizzarro come uno straniero a un ballo mascherato, fra i fumi del vino. (p.262)
Il cuore l’ha protetto: lo ha difeso, perché non fosse mai rubato quell’unico tesoro, perché non fosse mai violato il suo primo amore. Ha mascherato da castello la casa dei guaglioni, Nunziata da sovrana, il padre da eroe, mentre erano chiusi i suoi gelosi occhi dormienti. Ed è per questo che, lasciando Procida, quegli occhi Arturo vuole tenerli chiusi: «Non mi va di vedere Procida mentre s’allontana, e si confonde, diventa come una cosa grigia…» (p.379). Quando li riapre, «la marina è tutta uniforme, sconfinata come un oceano. L’isola non si vede più». Adesso può iniziare l’addestramento della coscienza al vero, e il racconto dell’isola di Arturo.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento