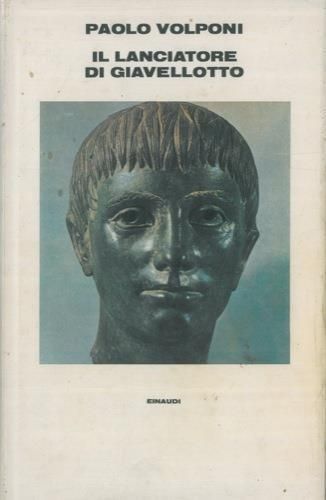
Perché leggere Il lanciatore di giavellotto di Paolo Volponi
Dalla metà di ottobre, con la mattina che batteva più bianca alla finestra e con il rumore del fiume ormai dentro casa, la nuvola e il fico erano diventati un riferimento fisso per Damiano Possanza. Mentre si preparava per la nuova giornata, la matassa grigiastra che si opponeva al sole e la macchia verde dell’albero occupavano la sua vista e il suo pensiero.
La nuvola era ferma sulla foce ormai da qualche giorno, sempre alla stessa altezza, uguale di forma e di colore fino al tramonto, quando si incendiava; e alla sera, quando si spegneva in un bianco di cenere. Anche di notte la nuvola premeva sul varco del fiume, tra le fiancate nere dei monti.
Il portamento del fico era tutto espanso già dall’alba, metà verde e metà giallo sopra il muro di cinta, contro la collina e il bordo della nuvola dall’altra parte del fiume. Per l’effetto dei due colori delle foglie sembrava che di continuo si sovrapponesse a se stesso.
Aveva ben scelto Possanza il getto di un fico sultano e bene anche il sito e la terra dove piantarlo e le correnti cui affidarlo, allo scopo di ricordare e di accompagnare rigogliosamente la nascita e la crescita del primo nipote, quello che per tradizione doveva rinnovare il suo nome.
Adesso il piccolo Damiano e il fico compivano nove anni, entrambi in buona salute. Il nipote era ai primi giorni di scuola e usciva di casa prima di lui dopo averlo ammirato per un momento sbarbarsi alla finestra con il rasoio a mano libera, il pennello soffice di tasso, il vasetto colmo di schiuma odorosa di mandorla. Per salutarlo gli toccava la cintura che gli scendeva aperta sui fianchi e dopo sbatteva la porta di casa senza riaccompagnarla, con un colpo da uomo.
La nuvola fluttuava e il suo riflesso lambiva la ringhiera della scala.
Il fico continuava il giuoco di rincorrersi con i rami diversi finestra per finestra: quella della cucina era socchiusa e la nuora illuminava il raggio che ne veniva con la vestaglia rosa di cittadina. I suoi colpi maldestri sulle stoviglie e sull’acquaio cadevano uno dietro l’altro con uno strano accanimento, tra il richiamo e il canto.
Possanza evitava di guardare quella bellissima donna discinta, con tutto il collo e le braccia nude, con il petto che si muoveva sotto il lucido della camicia. Andava di proposito a dare uno sguardo alla piccola Lavinia, la nipote, ancora dentro la culla in fondo al letto dei genitori. Ma oltre al conforto della tenerezza di quel sonno, gli toccava di raccogliere, anche se evitava di sapere se volontariamente o no, la visione del letto disfatto, più basso dalla parte della sposa e un profumo che l’avrebbe accompagnato a lungo, fino a mischiarsi anche nel tatto con quello della creta lavorata.
La casa ammodernata da meno di dieci anni, in previsione delle nozze del figlio, era piccola, appena sufficiente ad accogliere la famiglia.
Di notte la parete della sua stanza era animata dai rumori della stanza accanto. Era costretto a leggere in quei rumori un romanzo pieno di immagini e di vuoti, che mutavano in modo sempre più insinuante. Era interrogato anche dal silenzio, dal suo peso e dalla sua durata.
Uno sbaglio capitale era stato quello di costruire un solo bagno; adesso pieno di segnali promiscui, di indumenti, di saponi e di boccette che il suo senso non poteva più distinguere e ordinare. Seguiva da tempo il principio di usare il bagno solo di notte o a metà giornata: il più lontano possibile dal passaggio degli altri. Ma l’ultima alla sera, a rinchiudervisi dentro, era proprio la nuora.
Perché mette in conflitto la violenza della storia e la forza del desiderio
Il lanciatore di giavellotto (1981) racconta l’infanzia e l’adolescenza di Damìn Possanza a Fossombrone durante il fascismo fino al 1940. Il testo è composto di ventuno capitoli, ciascuno dei quali corredato di un titolo-sommario: l’impiego di didascalie in apertura di ogni capitolo, inconsueto in Volponi, è indice della volontà dell’autore di sorvegliare dall’alto la narrazione. Ma la vicenda è così densa di dolore che qualcosa di irriducibile sembra fin dall’inizio destinato a sfuggire al controllo autoriale.
E’ la comparsa dell’indimenticabile figura di Norma Coramboni, la madre di Damìn, filtrata inizialmente attraverso lo sguardo desiderante del nonno vasaio, a dividere il testo del Lanciatore in due distinti e conflittuali campi metaforici: quello pertinente all’Eros e quello pertinente al Lavoro. Nel primo è prevalente l’ ordine simbolico, nel secondo spicca lo sforzo conoscitivo: lo spazio della casa, dell’orto, della fornace è rappresentato attraverso il punto di vista del vecchio artigiano, secondo modalità plastiche e luminose e attributi cromatici (“matassa grigiastra”, “macchia verde”, “bianco di cenere”, p. 3) analoghi a quelli da lui quotidianamente impiegati nella lavorazione e ideazione delle crete. “Dare forma” con le mani e con la mente, osservare e rivelare le cose e gli eventi dolorosi, ordinarli e conoscerli: è questa la morale che presiede all’intero romanzo.
Damìn, a nove anni, è ancora immerso in un rassicurante idillio domestico incentrato sulle figure della madre e del nonno paterno e il padre Dorino, piccolo imprenditore sbiadito e incomprensibile fin dall’inizio del racconto, è per il bimbo il solo elemento di disturbo:
Il centro del mondo che ogni giorno cresceva e si illuminava sempre di più era la splendida figura del nonno, forte e alto, manovrabile, utile anche per godere ed esercitare meglio la proprietà della madre. La felicità ricorrente che lo sosteneva in tutto e per tutto era l’immagine di se stesso attaccato al petto della madre, con una mano ficcata tra le due mammelle e con l’altra protesa a cercare di toccare la faccia del nonno: la sua bocca e i suoi baffi. (p. 9)
Nel Lanciatore, tuttavia, la fragilità della figura paterna si carica di significati che la sottraggono all’ordine individuale per immetterla in quello storico e sociale, del lavoro e della produzione. Dorino, arrendevole alle tentazioni del fascismo, è disposto a tradire l’artigianato e a inseguire i nuovi miti piccolo-borghesi dell’arricchimento facile. Damìn non può identificarsi con il padre anche perché questi, a differenza del nonno, non sa considerare il lavoro come progetto creativo ma solo come modo per arraffare denaro.
Il mondo edenico di Damin è destinato a una dolorosa frantumazione quando, ormai adolescente, intuisce in chiesa la relazione della madre col gerarca fascista Marcacci, “l’uomo dal pugnale d’argento”, e arrampicato sul fico, assiste nell’orto allo “spettacolo vero e immenso della colpa della madre” (p. 21). Al procedere dell’apprendistato distruttivo di Damìn si affianca e si sovrappone un esplicito intento persuasivo e pedagogico del narratore. In rapporto a tale didattismo erotico e politico, tuttavia, la verità del dolore di Damìn si apre come una voragine, senza possibilità di redenzione.
Per la Bildung alla rovescia e per il tema del lavoro
Il lanciatore di giavellotto è un romanzo che sconcerta: dal punto di vista dei generi sembra un Bildungsroman alla rovescia, una ripresa del motivo primonovecentesco della gioventù come alterità e “cognizione del dolore”. Damìn è il tipo di adolescente incapace di integrarsi e, all’altezza dei primi anni Ottanta, appare come un personaggio controtempo, di “almeno cinquant’anni indietro” (Fortini). I due poli tematici di maggior rilievo sono, tuttavia, il corpo e la storia. Il tema del corpo è centrale in ogni testo volponiano e in costante tensione con i dati socioeconomici: il corpo di Albino Saluggia e i suoi “mali” nella fabbrica di Memoriale, il corpo-macchina del contadino Anteo in La macchina mondiale, il corpo schizoide di Gerolamo Aspri e le sue ansie di distruzione atomica in Corporale. Anche nel Lanciatore, il corpo e la storia entrano in conflitto: la disastrosa educazione sentimentale di Damìn, il lavoro di artigiano ceramista del nonno, quello già votato ai consumi di massa del padre e la prima acculturazione mediatica del fascismo, interagiscono reciprocamente tra loro, come in un campo di forze.
La rappresentazione del lavoro umano, dunque, affrontata da Volponi fin da Memoriale, contraddistingue anche il Lanciatore. E’ significativo, a questo proposito, che il vecchio Possanza sia “un maestro” (p. 5), i cui vasi, cocci, piatti e orci vengono apprezzati oltre i confini del mondo provinciale come esempio di “arte popolare”.
Per l’intreccio fra modello tragico e oggettivazione pittorica
Nelle pagine di Volponi la straordinaria qualità visiva della scrittura fa del testo letterario un antagonista della “visualità” effimera dominante. Nel Lanciatore l’associazione fra tragedia e rappresentazione pittorica è stata colta da Giovanni Raboni (le «metafore ossessive» vengono «rappresentate come se fossero corpi che fanno ombra, oggetti tangibili» con il «paradossale realismo di un antico pittore».
Nella decisiva sequenza della festa rurale (capitolo XX), a esempio, compare subito, illuminato dalla luce, il dettaglio della roncola che visivamente anticipa la solennità tragica dell’epilogo. Dalla pittura italiana cinque e seicentesca o da quella moderna da Sironi a Carrà (secondo Franco Fortini) ma anche dal cinema (a es. Cognome e nome: Lacombe Lucien di Louis Malle), Volponi trae le sue più specifiche risorse stilistiche e tematiche. Al contempo, la similitudine fra la madre e la città di Urbino, governata dall’uso lessicale della luce, rende esemplare il carattere conflittuale e ambiguo delle radici marchigiane (e, più in generale, di ogni radice e di ogni origine), costante tematica dell’intera scrittura di Volponi:
La luce dorata del tramonto distendeva la città dentro le sue proporzioni, serena e solenne in ogni piazza e strada. Damìn fu colpito anche dalla somiglianza che trovava fervida tra ogni architettura, la sua luce e la sua bellezza, e il volto e la figura della madre: lo stesso portamento e lo stesso ansare calmo della luce e dei gesti. La madre era bella e nobile come Urbino, come quella città piena di tempo e di storia eppure aperta e viva. (…) La luce divenne più bianca, come per seguire il rimorso che ormai risorgeva nel petto di Damìn. A quel biancore cercò di tenersi per non essere di nuovo travolto dalle ondate della sua verità: per potere fermarsi prima delle consuete, inarrestabili scariche di associazioni punitive e di dolore. (p. 165).
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento