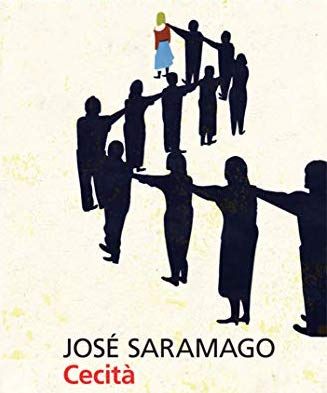
Perché leggere Cecità di Saramago: il realismo dell’allegoria
In questi giorni di “ritiro” la redazione di La letteratura e noi ha pensato che possa essere utile raggiungere i suoi lettori con la rubrica “Perché leggere” nelle giornate di martedì, giovedì e sabato: nel nostro blog troveranno spazio per lo più pezzi inediti ma potrebbero venire riproposti anche suggestioni di lettura già pubblicate in passato.
***
Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. Nel segnale pedonale comparve la sagoma dell’omino verde. La gente in attesa cominciò ad attraversare la strada camminando sulle strisce bianche dipinte sul nero dell’asfalto, non c’è niente che assomigli meno a una zebra, eppure le chiamano così. Gli automobilisti, impazienti, con il piede sul pedale della frizione, tenevano le macchine in tensione, avanzando, indietreggiando, come cavalli nervosi che sentissero arrivare nell’aria la frustata. Ormai i pedoni sono passati, ma il segnale di via libera per le macchine tarderà ancora alcuni secondi, c’è chi dice che questo indugio, in apparenza tanto insignificante, se moltiplicato per le migliaia di semafori esistenti nella città e per i successivi cambiamenti dei tre colori di ciascuno, è una delle più significative cause degli ingorghi, o imbottigliamenti, se vogliamo usare il termine corrente, della circolazione automobilistica.
Finalmente si accese il verde, le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte quante. La prima della fila di mezzo è ferma, dev’essere un problema meccanico, l’acceleratore rotto, la leva del cambio che si è bloccata, o un’avaria nell’impianto idraulico, blocco dei freni, interruzione del circuito elettrico, a meno che non sia semplicemente finita la benzina, non sarebbe la prima volta. Il nuovo raggruppamento di pedoni che si sta formando sui marciapiedi vede il conducente dell’automobile immobilizzata sbracciarsi dietro il parabrezza, mentre le macchine appresso a lui suonano il clacson freneticamente. Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l’automobile in panne fin là dove non blocchi il traffico, picchiano furiosamente sui finestrini chiusi, l’uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall’altro, si vede che urla qualche cosa, dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola, non una, due, infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello, Sono cieco.
(J. Saramago, Cecità, Torino, Einaudi, 1998, pp.3-4)
Si sa che per Benedetto Croce l’allegoria era una astrattezza antipoetica e antirealistica, e che questo pregiudizio lo indusse a limitare il valore della Commedia dantesca di cui venivano da lui salvate solo alcune terzine liriche. Il poeta inglese T. S. Eliot rovesciò questo pregiudizio: la grandezza di Dante, a suo avviso, derivava proprio dall’allegoria che di per sé, a differenza del simbolo, tende a essere realistica. Mentre infatti nel simbolo la concretezza viene invasa e sovvertita dal simbolo sino a perdersi del tutto in esso, nell’allegoria il dato di realtà viene confermato e valorizzato e poi gli viene attribuito razionalmente un significato che rinvia ad altro. Perciò l’allegoria privilegia narrazioni di realtà che abbiano una valenza didattica, apologhi (come le favore di Esopo),vicende storiche che si prestano all’attualizzazione.
Materia di Cecità è un avvenimento attuale: scoppia improvvisamente una epidemia che, mettendo a nudo le ipocrisie e le ingiustizie della società in cui viviamo, rivela la sostanza cinica e crudele della nostra civiltà. A un tratto in una grande città la gente diventa cieca e viene chiusa in una specie di lazzaretto, senza servizi sanitari e senza attrezzature igieniche, sorvegliato da soldati che sparano ai reclusi che si avvicinano all’uscita. Protagonisti sono un medico oculista, una ragazza che porta gli occhiali scuri, un ragazzo che all’inizio cerca ancora sua madre e che viene assistito dalla ragazza con gli occhiali neri,un uomo con la benda su un occhio, uno diventato per primo cieco e sua moglie e infine la consorte del medico, l’unica che non abbia perduto la vista e perciò di fatto si trova a guidare gli altri ciechi del suo gruppo. In quella specie di lazzaretto – un inferno puzzolente – una ventina di ciechi si impossessa del cibo destinato a tutti e sottopone gli altri reclusi a ogni vessazione in cambio del cibo di cui si è impadronito, prima estorcendo loro ogni avere, poi esigendo tutte le donne recluse e sottoponendole a veri e propri stupri. Solo la moglie del medico (l’unica che ha conservato la vista e, con essa, il senso della propria dignità) reagisce uccidendo il capo degli oppressori. A un certo punto i reclusi si accorgono che i soldati sono spariti, forzano la porta ed escono fuori in una città spettrale, dove regnano violenza e sporcizia e gruppi di ciechi si aggirano in cerca di cibo. Capiscono che tutta la popolazione è diventata cieca, con l’unica eccezione della moglie del medico, che si adopera in ogni modo per aiutare e guidare gli altri, in parte assistita dalla ragazza dagli occhiali neri. Alla fine la vista ritorna a tutti ma solo per poter vedere e considerare l’abisso in cui è caduto il genere umano.
La chiave dell’allegoria sta nella battuta finale della moglie del medico, che, si sarà capito, è l’ unico personaggio positivo del romanzo (ma anche la ragazza con gli occhiali neri ha una sua generosità: solo le donne infatti sembrano conservare un po’ di umanità):”Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”. L’aneddoto allegorico ha il suo fabula docet: l’umanità moderna corre ciecamente verso lo sterminio, perché nessuno riesce più a vedere, cioè a leggere e a capire la realtà in cui vive. Si salva solo chi, come la moglie del medico, sa ancora ribellarsi ai soprusi e sacrificarsi per aiutare gli altri; e infatti è l’unica che vede ancora.
Come si può osservare, siamo nel campo del grande realismo e della grande allegoria moderni, che si confermano, anche qui, fratelli gemelli.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 La memoria familiare di Clara Sereni
La memoria familiare di Clara Sereni -
 Anatomia del personaggio romanzesco
Anatomia del personaggio romanzesco -
 La scomparsa di Frate Elia
La scomparsa di Frate Elia -
 Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna
Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -
-
La scrittura e noi
-
 Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti
Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -
 Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone
Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -
 Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar
Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -
 Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King
Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -
-
La scuola e noi
-
 Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento
Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -
 Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee
Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -
 I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria
I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -
 «Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici
«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -
-
Il presente e noi
-
 Il bisogno di un nuovo umanesimo
Il bisogno di un nuovo umanesimo -
 La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024
La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -
 Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza
Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -
 Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola
Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola -
Commenti recenti
- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…
- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.
- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…
- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…
- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento