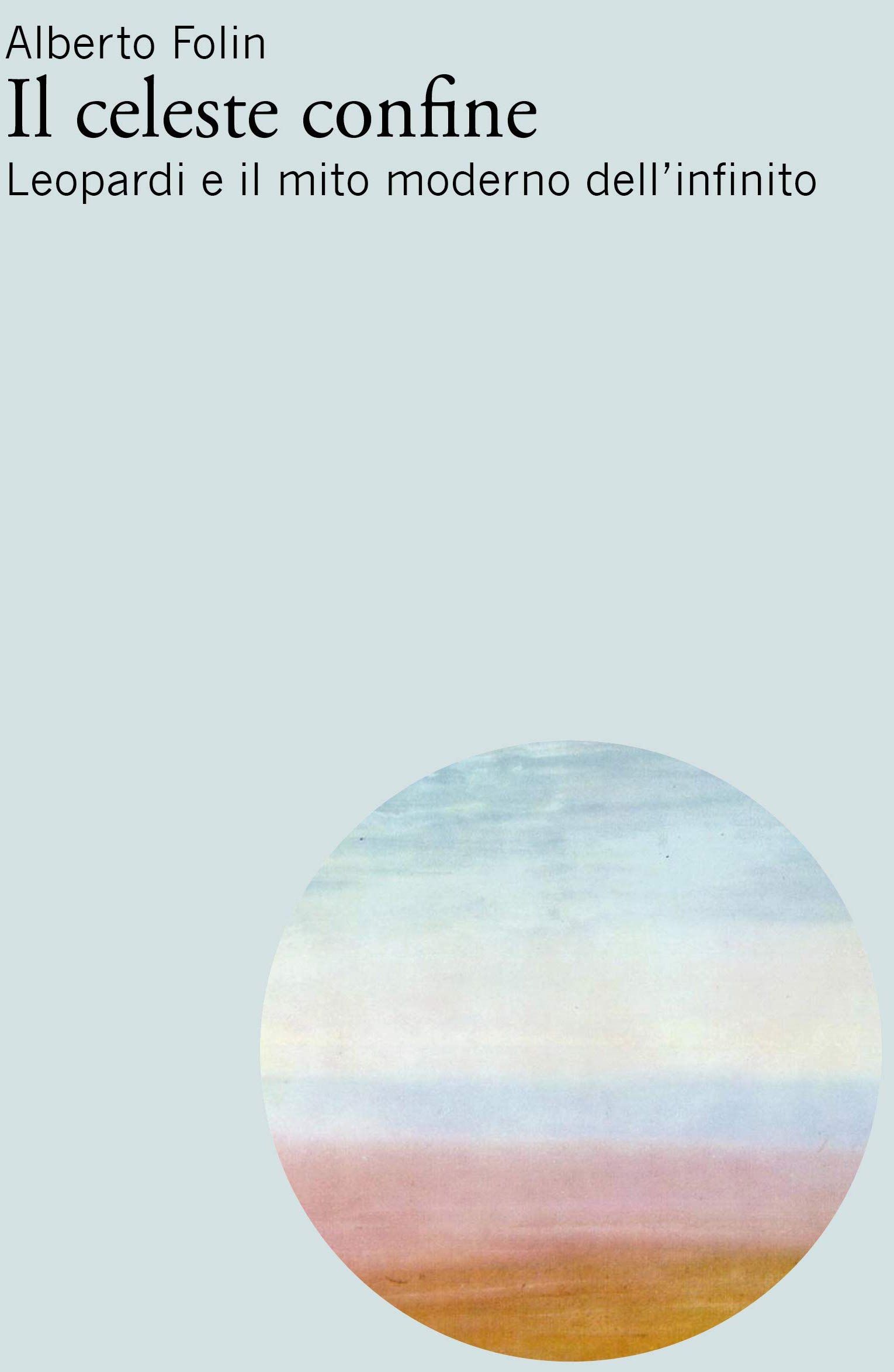
«Il celeste confine. Leopardi e il mito moderno dell’infinito» di Alberto Folin
In poco più di cinque anni, dal 1819 al 1824, Leopardi compone la maggior parte delle opere destinate a renderlo immortale: idilli, canzoni, oltre tremila pagine dello Zibaldone, buona parte delle Operette morali, dozzine di lettere e il Discorso sui costumi degli italiani, oltre a un ampio progetto di volgarizzamenti rimasto a lungo inedito. È forse – insieme al biennio 1828-’29 – il periodo più fertile della sua vita intellettuale, quello in cui si sostanziano le meditazioni sull’origine della società, sulle lingue antiche e moderne, sulle possibilità di una vita felice, sui rapporti tra natura mito poesia. Proprio questo nodo concettuale è al centro dell’ultimo libro di Alberto Folin che, dopo Leopardi e la notte chiara (1993), Pensare per affetti (1996), Leopardi e l’imperfetto nulla (2001), Leopardi e il canto dell’addio (2008), arricchisce la sua ricerca con il recentissimo Il celeste confine, pubblicato come tutti i precedenti da Marsilio.
Folin riparte da alcuni punti cardine della poetica leopardiana, li immerge nel contesto storico in cui l’autore opera (la polarità di neoclassicismo-romanticismo-illuminismo) ma li osserva anche con chiavi interpretative filosofiche e antropologiche utili a ricollocarli in un orizzonte concettuale più proprio: il concetto di passione, per esempio, viene svincolato dalla connotazione edonistica che assume a partire dallo Stürm und Drang e ricondotto alla prospettiva di «dedizione al bene comune», di «supremo principio di ordine morale condiviso dalla comunità» tipica delle posizioni più vicine a Leopardi. Tutto il lavoro di Folin mira in effetti a evidenziare le discontinuità rispetto alle correnti più note del neoclassicismo, del romanticismo e dell’illuminismo: a differenza di quanto ipotizzato a suo tempo da Mario Sansone, secondo cui Leopardi sarebbe l’erede più puro e diretto della straordinaria stagione settecentesca (una posizione sostenuta nel corso dell’importantissimo primo convegno recanatese del 1974, che avrebbe ampiamento influenzato la critica successiva), secondo Folin i caratteri di novità rispetto a Rousseau, Goethe, Vico, Gravina, Voltaire e Condillac sono assai più interessanti rispetto alle pur forti consonanze e si manifestano con particolare evidenza nel campo della riflessione sul mito, cui Leopardi dedica due canzoni (Alla Primavera e Inno ai Patriarchi) e numerose pagine zibaldoniane, a partire dall’importante dichiarazione del febbraio del 1821, quando Leopardi afferma di «non […] credere alle allegorie, né cercarle nella mitologia, o nelle invenzioni dei poeti», e tuttavia di riconoscere ancora nella favola di Psiche un «emblema […] conveniente e preciso» della natura dell’uomo e delle cose tanto da farla apparire ai suoi occhi come il «parto della più profonda saggezza».
Dunque il mito, la poesia e la conoscenza umana sono, o almeno erano un tempo, strettamente correlate: come e perché questo triangolo si sia spezzato è la prima domanda a cui Il celeste confine cerca di rispondere, allacciandosi ai lavori di Cesare Galimberti e Lucio Felici. Se Felici evidenziava il rifiuto leopardiano della prospettiva consolatoria tipica dei romantici e ricordava che per Leopardi ormai «vote son le stanze d’Olimpo» (cioè che il mito è svuotato di senso, inutilizzabile in poesia se non per alludere a un tempo remoto in cui natura, dèi, fato coincidevano), per Galimberti la mitologia a cui Leopardi fa appello è per lo più crepuscolare, talora addirittura tetra, e viene utilizzata come mero apparato iconografico per parlare dell’arcano spaventoso dell’esistenza. In continuità con entrambi, Folin identifica il mito con quell’ultimo orizzonte che, pur non persuadendoci più, continua a parlarci.
Il mito, il suo utilizzo nella letteratura moderna, non deve essere banale “imitazione da scimmie”, scrive Leopardi il 19 settembre 1823 (riprendendo una formula già usata da Petrarca nelle sue Familiari), né tantomeno sfoggio erudito e borioso di un sapere inattuale, bensì «linguaggio privilegiato della verità dell’origine» necessario nella prospettiva programmatica di un rinnovamento della sensibilità che distingue Leopardi da molti altri autori settecenteschi che pure avevano fatto del mito il loro campo di indagine privilegiato (tra gli altri, Dupuis e Fontenelle). La lingua del mito, che per Leopardi è incastonata fin dal principio nella natura umana, è lontanissima da qualsivoglia costruzione della ragione e discende da quelle illusioni presenti ab origine nell’uomo (e forse in tutta la natura, stando all’osservazione di Zib. 55, dove Leopardi attribuisce “voce e canto” alle “erbe rugiadose in sul mattino”), che solo la poesia può tentare di esprimere. Secondo Folin, Leopardi vede nella voce (non solo umana) un elemento ontologico fondante il fenomeno prima che esso si costituisca in parola significante: nella voce del vento, nel suon dell’ora riecheggia di qualcosa di ineludibile che precede una precisa capacità espressiva. Così il mito, ormai inerte dal punto di vista del suo significato (in questo senso Leopardi avrebbe probabilmente potuto condividere la rilettura kafkiana del Prometeo), conserva una sua precipua vitalità sul piano del significante, del mero suono a cui è accreditata la capacità di riconnetterci all’origine.
Che cosa significa tutto ciò? Innanzitutto che il classicismo di Leopardi non avrebbe nulla da spartire con l’estetizzazione dell’antico teorizzata da Winckelmann, o con la “memoria produttiva” volta a trasmettere esempi e valori civili, ma al contrario sarebbe intimamente connesso con una dimensione originaria e innominabile dell’umano, vicina più a Omero che a Virgilio; qui Folin si allontana dalle posizioni di un altro illustre leopardista, Mario Andrea Rigoni, e legge nel classicismo leopardiano non tanto una risposta quanto una domanda, una interrogazione relativa al momento di passaggio dalla brutalità alla civilizzazione, dall’inumano all’umano, da Achille eroe della forza a Ettore eroe della compassione. Questo modo di intendere il classico rende inaggirabile la questione del mito, con cui occorre fare i conti, superandone tanto l’interpretazione eziologica quanto quella meramente estetica, per arrivare alla consapevolezza che rileggere il mito nella modernità implica la necessità di quella “coscienza infelice” di cui parlava Hegel, la consapevolezza cioè che la persuasione su cui si fondava il mito antico è perduta: per questo secondo Leopardi «imitare non è copiare, né ragionevolmente s’imita se non quando l’imitazione è adattata e conformata alle circostanze del luogo, del tempo, delle persone» (Zib., f. 3492).
Muovendosi nel solco della critica leopardiana, ma orientando in modo originale la sua indagine, Folin definisce il mito come «immagine della cosa» e la poesia come «fedele rappresentazione di quella immagine»: per questo, caduto il mito, viene meno anche la poesia ingenua degli antichi e resta spazio solo per la poesia sentimentale che sgorga non dalle immagini ma da quella filosofia che volendo chiarire in realtà mistifica (come Leopardi stesso precisa al foglio 4239 dello Zibaldone). La ripresa dell’antico non è possibile per via meramente individuale (dunque psicologica) né per via di archeologia letteraria, per questo secondo Folin «Fare esperienza del mondo senza riflettere richiede un lungo cammino tra infinite riflessioni, che però devono rimanere velate». In bilico tra illusione antica e razionalismo moderno, Leopardi sa che non basta riesumare parole antiche (come pur aveva tentato fino a qualche anno prima nelle sue contraffazioni erudite), perché una volta perduto lo sguardo pensoso degli antichi non resta che il linguaggio della scienza per parlare della natura. Ma è un linguaggio che Leopardi rifiuta o ignora (come ha dimostrato Zellini nei suoi studi sull’Infinito): di qui la scelta dell’illusione, che viene tuttavia intesa da Leopardi non alla maniera dei romantici, come rifugio, spazio protetto della nostalgia e del sentimento, bensì come ultimo confine del sapere umano. Sintetizza efficacemente Folin che se l’illusione romantica era errore della conoscenza, quella leopardiana meglio andrà intesa come forma della conoscenza.
Proprio alla polisemanticità dell’errore (di volta in volta inganno, illusione, desiderio, salvezza, poesia…), Folin dedica le pagine finali del suo libro dove l’illusione e l’apparenza, discostandosi dal vero, edificano un modo diverso di stare nel vero e così ne redimono il deserto e l’abisso: l’illusione dunque non è errore del soggetto, ma posizione conoscitiva consustanziale alla natura. La natura stessa, peraltro, non è mai in Leopardi mero oggetto reificato, bensì sempre endiadi inscindibile di visibile e invisibile, “cosa veruna” che in ciel, nell’equoreo seno o sull’aprica terra era un tempo (e oggi forse non più) spettatrice dell’affanno umano. Per questo la natura si nasconde, lo sguardo razionale è del tutto inadatto a scoprirne gli intimi segreti e anzi deve essere “escluso” dall’orizzonte conoscitivo del poetico: «l’ostacolo, la negazione, la lontananza, l’indefinitezza del contorno, l’impedimento delle percezioni sensoriali (della vista e dell’udito) diventano la condizione indispensabile per far rivivere, nel moderno, la meraviglia degli antichi». Gli antichi sapevano senza vedere – questa era l’intima essenza del mito – mentre al contrario i moderni per sapere devono vedere con chiarezza. La forma di conoscenza allusa ne L’infinito punta invece tutto sull’invisibile, ma un invisibile cui viene sottratta ogni valenza religiosa (in questo senso andrebbe letta, secondo Folin, la sostituzione della variante “celeste confine” con il definitivo “ultimo orizzonte”): ciò che sta oltre la siepe è escluso dallo sguardo conoscitivo non in quanto divino, bensì in quanto res extensa, cose percepibili e distraenti che vanno messe tra parentesi affinché possa attivarsi la seconda vista, più profonda e conoscitivamente proficua. Questo gioco continuo tra visibile e invisibile conduce Leopardi in direzioni non del tutto analoghe a quelle del sensismo, e vicine piuttosto alla concezione omerica della natura, secondo cui visibile e invisibile sono consustanziali: questo sarebbe dunque il senso del naufragio finale, la coincidenza tra il proprio vissuto e quello del tempo mitico.
Una nuova maniera di vedere le cose, che è insieme antichissima, la “più beata” perché ogni cosa parla all’immaginazione e rende possibile un intimo colloquio tra l’immaginazione e le cose, tra uomo e mondo, consentendo quella coincidenza tra l’archè e la soggettività che si sfrangia subito dopo la stesura de L’infinito: già pochi mesi dopo la stesura dell’idillio resta spazio solo per la nera malinconia e per quell’atteggiamento nostalgico che caratterizza gran parte del romanticismo europeo: «l’esperienza dell’antico» diviene per Leopardi «esperienza perduta di un mondo assente». Con gli anni Venti inizia una nuova fase della meditazione leopardiana, tesa a individuare una lingua adatta a parlare di questa natura, una lingua filosofica che non la vivisezioni ma ne restituisca l’integrità pre-logica: quella che Leopardi riconoscerà nella tradizione orientale (il pastore errante, filosofia indiana del frammento del giardino, i turchi con il calumet sono tutte figure che alludono a quell’orizzonte così strano), in cui trova compimento la ricerca di immagini «allusive a un senso impossibile da cogliere con il linguaggio in piena luce della ragione».
Rielaborando, come già avveniva nei suoi precedenti studi, alcune categorie heideggeriane (quella di poesia pensante, certo, ma anche quella della verità come svelamento, dell’ombra e del nascondimento a protezione delle illusioni) qui mediate dagli studi di Ernesto Grassi, Folin approfondisce ulteriormente la sua lettura ermeneutica di Leopardi e, sottraendolo al discorso nichilista, lo interpreta piuttosto in chiave ontologica, facendone il più grande autore non del romanticismo ma dell’umanesimo italiano, un umanesimo dove l’uomo non è più al centro dell’universo ma solo di fronte ad esso; questa solitudine tuttavia rifiuta la contemplazione del nulla e rilancia il ruolo critico del poeta-filosofo che, pensando per immagini e non per concetti, recupera l’anima del mondo, quella che il razionalismo moderno ha ridotto a un mero nulla. Emerge da questi saggi un Leopardi anti-psicologico, il cui sguardo non assimila a sé la natura, non la «trasforma secondo il proprio vantaggio», per usare l’espressione dello stesso Folin, ma la evoca come necessità, come potente spettatrice che, proprio perché muta, velata, razionalmente inconoscibile, conserva intatta la sua potenza primigenia. Proprio per questo, per avvicinarla, sarà sempre più efficace una piccola idea confusa rispetto a una grande e affatto chiara.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento