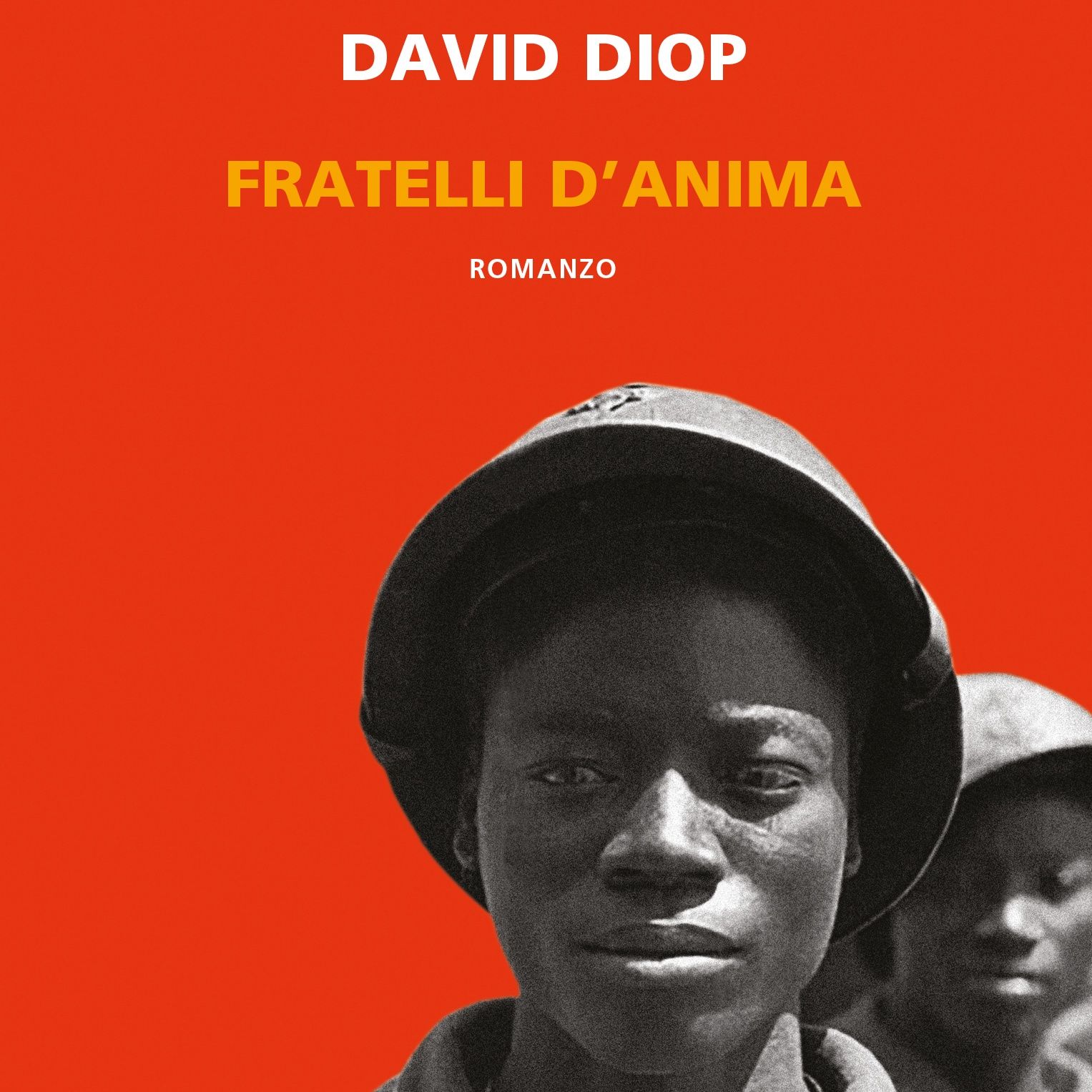
Attraverso la maschera del saldatore: il caso Moro ne Il tempo materiale di Giorgio Vasta
Pensare che siano violenti è sbagliato perché non lo sono: sono fecondativi. Il seme deve rompersi, le cellule devono separarsi, il corpo del neonato deve essere strappato dal corpo della madre. Diversamente non c’è la vita. Sono fecondativi e fondativi. Romolo uccide Remo e fonda una città. Caino uccide Abele e decide la forma della nostra storia. La violenza è coraggiosa perché riconosce e ammette l’esistenza del dolore e della colpa. Le Brigate Rosse hanno il coraggio della colpa e la coscienza del dolore. Le Brigate Rosse nascono dalla paura e dal desiderio. Dalla paura della distanza; dal desiderio disperato di esistere al centro del tempo. Nel cuore infuocato della storia. Per non scomparire, per restare visibili. Perché questo è quello a cui, senza rendercene conto, ci stanno addestrando. A scomparire. [G.Vasta, Il tempo Materiale, p. 83)
1. O con lo stato o con le BR.
Quando nel 2007 il Parlamento italiano sceglie la data del 9 maggio per celebrare la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, viene istituzionalizzato quello che sembra essere già un dato di fatto dell’immaginario nazionale. Il 9 maggio 1978, giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro (anche quello della morte di Peppino Impastato), è il punto in cui si condensa e si riassume un decennio cominciato il 12 dicembre 1969 con la strage di Piazza Fontana e caratterizzato da una radicalizzazione violenta delle tensioni interne. Anche se Moro non è l’ultimo morto degli anni Settanta, i cinquantacinque giorni del suo rapimento e l’immagine del suo cadavere segnano la conclusione di un’epoca, delle sue tragedie e soprattutto delle sue speranze. La crisi politica che si era trascinata per tutto il decennio si risolve e la tanto agognata unità nazionale si ricompone. Tutte le contraddizioni e le complessità di un periodo storico si addensano in un grumo memoriale che prende la forma dello scontro tra lo stato e le Brigate Rosse; tutti i nomi, dei morti e dei carnefici, tutte le posizioni politiche, i ruoli e le forme di partecipazione alla vita collettiva, tutte le visioni del mondo che confliggono, vengono calcate in uno schema bipartito; rispetto al quale ad ogni cittadino italiano viene chiesto – e continua a venire chiesto dalle colonne di Repubblica il 9 maggio di ogni anno – di schierarsi. Chi non prende parola sembra ambiguo, simpatizzante, apologeta dei terroristi. La realtà nazionale trova un’interpretazione forte che da troppo tempo mancava: da un lato c’è l’ordine costituito e dall’altro una critica a quest’ordine che non può che diventare sangue, violenza, morte. E’ già prefigurato lo slogan there’s no alternative. Siamo già negli anni Ottanta.
L’Affaire Moro – come titola il noto pamphlet di Sciascia – incide una linea netta nell’immaginario collettivo che segna gli anni successivi della storia italiana, impone un aut-aut al quale in pochi sono in grado di sottrarsi. Ma non è il silenzio che caratterizza la rappresentazione del caso Moro, anzi. La mole di discorsi è ingente, si potrebbe parlare – sfogliando le bibliografie –di sovrapproduzione: articoli di giornale, saggi, testimonianze, documentari video, programmi radio, fotografie e poi letteratura, film, fumetti, finzione. Come per l’attentato dell’11 settembre, sembra che chi può ricordarlo ricordi in modo indelebile dove si trovava e cosa stava facendo quando ha saputo che le Brigate Rosse avevano rapito il segretario della Democrazia Cristiana. Fin da subito il paese si accorge di essere di fronte a un momento fondamentale della propria storia. Di Moro si parla, si parla degli anni di piombo, si parla perché è necessario parlare, indagare, capire, sciogliere nodi, dire la propria, a proposito di un fatto che viene caricato di significati che vanno ben oltre la sua semplice referenzialità. Tutti, anche i terroristi, sono invitati a prendere parola. Di Moro si parla ma si può parlare a patto che si accetti l’aut-aut, a patto che si rispetti la linea che separa il vivere civile dalla violenza, lo schema bipartito che individua irrevocabilmente le parti. Si può parlare degli anni Settanta a patto che si tenga conto di Moro. Non esiste un’inquisizione che bruci gli eretici o comitati di salute pubblica con le loro ghigliottine, non ce n’è bisogno. L’interpretazione è data: piena libertà all’interno del suo schema; chiunque non ne tenga conto o cerchi di sfumarne le linee viene immediatamente squalificato dal discorso pubblico come apologeta del terrorismo, brigatista sotto mentite spoglie.
Soprattutto per chi non ha vissuto sulla propria pelle quegli anni, la visione bipartita appare come naturale, un dato di realtà auto-evidente. Questo è vero a tal punto che tra quelli che vogliono salvare l’esperienza politica della sinistra extraparlamentare degli anni settanta si assiste a letture o di tipo complottistico (le «cosiddette BR» che non sarebbero che uno strumento del potere statale nell’ottica della strategia della tensione), o di santificazione dell’esperienza del terrorismo armato; in entrambi i casi si ricade nello schematismo di cui sopra. Ogni sguardo sul corpo di Moro nel bagagliaio della R4 sembra condurre al medesimo tic concettuale: o lo stato o le Brigate Rosse. Affrontare direttamente la complessità appare impossibile.
2. Degli strani bambini, uno strano linguaggio.
Il tempo Materiale di Giorgio Vasta (2008) ci offre una soluzione per oltrepassare lo schema dal quale fatichiamo a liberarci, ci permette di guardare i terroristi dall’interno senza cadere nella trappola della semplificazione. I terroristi in questione sono tre bambini di 11 anni di Palermo che, ispirandosi al modello delle Brigate Rosse, si costituiscono come militanti rivoluzionari e fondano la loro cellula armata: il NOI (Nucleo Osceno Italiano). La storia si svolge tra il gennaio e il dicembre del ’78 e si articola come un processo di formazione. Dall’addestramento all’azione, dall’azione contro le cose all’azione contro le persone, dalla clandestinità alla dichiarazione di prigionia politica, fino al tradimento dei compagni, i personaggi mimano la traiettoria esistenziale e politica che ha portato alcuni uomini – «il meglio e il peggio di quella generazione» diceva Franco Fortini citando Tolstoij – alla scelta armata. Le vicende sono raccontate attraverso gli occhi implacabili di Nimbo, uno di questi tre bambini. Il modello che viene in mente è quello dello straniamento che Calvino mette in atto nel Sentiero dei nidi di ragno (1947) in cui, per sfuggire alla retorica della resistenza, la storia partigiana è vista con gli occhi di un bambino.
Lo straniamento in Vasta si compie anche su un piano ulteriore; non solo lo spostamento del punto focale verso l’infanzia ma anche la rappresentazione di un’infanzia fuori dagli schemi consueti. Questi bambini sono e contemporaneamente non sono bambini di 11 anni. La voce narrante e i suoi compagni risultano infarcite di un linguaggio che non si addice – secondo un’idea verosimile o documentaria del testo letterario- alla loro età: lessico politico e filosofico («bambini che parlano come la Scuola di Francoforte», ha scritto Nicola Lagioia), corporeo, parole tecniche dalla medicina e dalla biologia, immaginario profetico; comunque scelte lessicali precise e marcate che nessuno assocerebbe al vocabolario di un undicenne. La lingua di Nimbo poi, nella quale il lettore si trova costretto, sembra tagliare la realtà in tanti piccoli pezzi, come un bisturi analitico che tenta di sezionare le informazioni dei sensi con quanta più precisione possibile, senza sfumature e spazi di ambiguità. Anche quando – e avviene spesso – vengono usate similitudini e figure retoriche, quando vengono accostati campi semantici comunemente distanti, quando le descrizioni diventano surreali, tutto ciò viene fatto per inquadrare le cose in modo più preciso: «il Cotone ha quattro anni meno di me ed è un moderato. È solido senza aggressione, silenzioso senza ostilità» [37]. La finezza e la serietà del taglio non vengono quasi mai meno. La forma delle frasi e la sintassi sembrano andare nella medesima direzione analitica: frasi brevi in cui i punti si sprecano; blocchi sintattici che si giustappongono senza nessi logici espliciti; elenchi. «C’è il cielo. C’è l’acqua, ci sono le radici. C’è la religione, c’è la materia, c’è la casa» [7]. Dialoghi e narrazione si alternano fluidamente, quasi che pensiero e parola fossero nello stesso regime discorsivo. La narrazione è densa di dettagli e sensazioni immediatamente riportati dalla voce narrante dentro i propri schemi categoriali. Moltissime frasi sono apodittiche, dicono il mondo con la sicurezza di quello che è evidente, di ciò che è senza margini di ripensamento o residui. Nimbo è quasi un robot che riceve i dati attraverso i sensi e immediatamente razionalizza la realtà che ha esperito, freddo e calcolatore: «sul disegno di un fiore bellissimo […] la retinatura implacabile della carta millimetrata» [100].
Nello stesso tempo però, in alcuni comportamenti, nei rapporti con i genitori e con i fratelli, nel rapporto tra Nimbo e la Bambina Creola, i protagonisti giocano, si relazionano e si comportano da bambini. Le scelte di date (che marcano ogni capitolo), di luoghi precisi (l’Italia, Palermo, i nomi delle sue vie) e di elementi presi direttamente dal mondo storico e reale di quegli anni (personaggi pubblici, programmi televisivi, eventi storici e sportivi, canzoni, giornali, film…) indicano che il mondo di cui si parla è l’Italia del 1978 e non un paese fantastico di un tempo inventato. L’indicativo presente al quale si coniuga il racconto, inoltre, produce un effetto di presa diretta che impone a tutto quello che succede la temporalità dell’adesso, dal quale si fatica a staccarsi per sguardi più generali, soprattutto sul futuro. Questi elementi contrastivi montati nella medesima narrazione creano una sorta di paradossale realismo allucinato: la sensazione di guardare attraverso una serie di filtri che mentre deformano la realtà storica la stanno mettendo, in qualche modo, a fuoco.
3. Esistere al centro della storia.
Le Brigate Rosse e il caso Moro arrivano dalla televisione e dai giornali e colpiscono l’immaginazione dei ragazzini come una storia di supereroi. «Le Brigate Rosse agiscono. Compiono azioni» [68].
Ho trovato una storia del 1970, dice Bocca frugando tra le copie. Le Br hanno sequestrato il capo del personale di una fabbrica in Sardegna, gli hanno appeso un cartello al collo, l’hanno caricato su un asino e portato in giro per tutto il paese.
È entusiasta, gli piace l’idea della beffa, la punizione creativa. Anche noi, dice, dobbiamo fare così. [71]
La fratellanza che unisce i bambini al gruppo terroristico è costruito attorno al sentimento di estraneità alla nazione. L’Italia tiepida e ammalata, trova la sua rappresentazione più significativa nella nazionale di calcio ai mondiali del ‘78 in Argentina vista in televisione: «la squadra dello sperpero e della codardia […] giochicchia, vivacchia […] una bava madreperlacea che si allunga sul campo» [94]; una squadra che si muove senza schemi, nella quale Paolo Rossi fa gol a caso, capitandogli la palla tra i piedi dopo una serie di rimpalli, senza merito né progetto. Un paese farsesco, «del tutto incapace di assumersi la responsabilità del tragico» [75], «il paese della desensibilizzazione degli istinti civili, del depotenziamento di ogni forma di responsabilità» [74], un paese «che capisce solo le maschere, i personaggi a una dimensione» [137] dove «tutto diventa manierismo, piccola posa. Costume» [82]. Questa insopportabile italianità passiva sembra inglobare tutta la normalità italiana e palermitana nella quale i bambini sono inseriti. Tutto tranne le Brigate Rosse, che appaiono come la necessaria nemesi: seri, responsabili e colpevoli.
Essere colpevoli è una responsabilità. Le Brigate Rosse si stanno assumendo questa responsabilità. Stanno rendendo Moro innocente. […] Quello che le Br hanno capito, dice poi a voce bassissima, è che il sogno deve legarsi alla disciplina, diventare duro e geometrico e proiettarsi verso l’ideologia. [68]
La colpevolezza marca la differenza delle Br dall’indifferenziato nazionale, indica «una capacità», «un compito» [54]. Ma quello che affascina veramente delle Brigate rosse è il linguaggio dei comunicati, completamente diverso dalla lingua in uso nel resto del paese:
Hai visto le frasi? Mi domanda. E con una matita segna le colonne degli articoli. Ha le mani grandi e invertebrate. Mi indica delle fotografie, dei titoli: è il cercatore che ha trovato il filone aurifero.
Si le ho viste.
È come dice Scarmiglia: ogni frase è un ordigno, qualcosa che esplode. [71]
C’è, senza dubbio, un conflitto tra l’ideologo del gruppo, Scarmiglia o Compagno Volo, e la voce narrante. Di fronte all’interpretazione del linguaggio brigatista, Nimbo apre un inquietante spazio di ambiguità. Il linguaggio come strumento ordinatore, «come quando si divide in due la lavagna con il gesso per segnare i buoni e i cattivi» [72] appare anche nella sua carica mortifera e asfissiante.
Da un lato l’ironia (anticamera di cinismo e rassegnazione, «ironia – la nostra bestia nera» [173]) e la passività, dall’altro la serietà, l’ideologia e la lotta. Una volta che è iniziato il processo che porta i bambini a trasformarsi in «macchine militanti» [163] le Brigate Rosse e il caso Moro scompaiono quasi completamente dalla scena. Il terrorismo di estrema sinistra come fatto storico diventa pretesto per dire qualcos’altro, un filtro ulteriore tra la narrazione e il suo difficoltoso oggetto: la militanza. I bambini potrebbero essere affiliati dei NAR o dell’ISIS, quello che diventa importante è la volontà di esistere nella storia, di dominare il caso, e di agire la realtà, anche in forme violente. Assume sempre più centralità la rinuncia ad ogni pretesa individuale. Il modello di riferimento è quello biologico delle api e dell’alveare: l’idea per la quale «ogni ape non sia tanto un corpo individuale quanto la parte di un tutto più ampio» [112]. Come l’Ape regina è il «centro radiante» [109] dal quale partono le direttive per l’intero alveare, l’ideologia è il centro dell’organizzazione militante. Anche qui, la carica di ambiguità con la quale la voce narrante colora il discorso è alta: l’ape/ideologia «è nera e maestosa, una doppia ogiva appuntita a entrambe le estremità, due grandi occhi visionari, un pungiglione che contiene un veleno insieme mortale e vivificatore.» [109]. La scelta dell’acronimo NOI per il gruppo terroristico sottolinea l’importanza della dimensione collettiva:
Noi è la parola in cui coesistono la distruzione del soggetto individuale e l’orgoglio di essere compagni: per me che dico sempre io, che vivo chiuso nel raglio asinino, pensare noi, pensare di stargli dentro è sbalorditivo. NOI è anche l’acronimo di Nucleo Osceno Italiano: Nucleo, identifica la solidità; Osceno è l’unico tempo in cui abbia senso vivere; Italiano è ciò che ci indigna e ciò in cui siamo immersi. [177]
Nimbo cova il dubbio e cerca di opporre le sue critiche alle decisioni del compagno Volo che assume sempre di più il ruolo del capo; tuttavia, in nome dell’obbedienza al progetto rivoluzionario e dell’abnegazione della volontà individuale, accetta la parte che gli viene imposta.
L’altro tema che appare fondamentale nella rappresentazione della militanza è il tentativo di dominio conoscitivo della realtà come necessità fondamentale per affrontare una prassi coerente. In questo senso il linguaggio di Vasta, bisturi analitico che razionalizza il mondo senza lasciare spazio per margini, o punti ciechi, trova un suo corrispettivo tematico. L’«alfamuto», linguaggio costituito da 21 pose tratte dall’immaginario collettivo, oltre che essere comunicazione interna e segreta, è semplificazione, eliminazione dell’inessenziale verso una realtà comprensibile e determinabile:
Il linguaggio è un’esistenza immensa, rispondo. Ma a un certo punto cominci a desiderarne un’altra di esistenza. Più limitata, ma più comprensibile.
Un’esistenza nella quale sia semplice distinguere tra i buoni e i cattivi? Domanda.
Una forma di vita che dice chi siamo e chi siamo stati, dico. [172]
L’imitazione dei goal dei mondiali che sostituisce il gioco del calcio è un addestramento all’eliminazione del caso, all’ortodossia dell’imitazione. Dall’addestramento si passerà alla prassi, alla progettazione dell’azione nella quale niente deve sfuggire. Quando qualcosa sfugge e il progetto di far esplodere l’auto del preside coinvolge, nella sua attuazione, dei passanti che rimangono carbonizzati, il caso viene interpretato come imprevisto: il progetto, autonomo rispetto alla realtà («la realtà che oppone resistenza al progetto» [200]), deve imparare a considerare anche questo tipo di variabili. Il progredire dell’efferatezza delle azioni verso l’omicidio calcolato e volontario di Morana (nel cui nome si riconosce Moro, oramai archetipo della vittima) diventa prova della capacità del nucleo terroristico di agire la realtà fino all’omicidio:
Se il pudore imposto dalla militanza non ce lo proibisse, vorremmo e dovremmo piangere di commozione. Di gioia e di dolore. Perché abbiamo trovato il luogo nel quale tutto si concentra e si rivela. Noi uccidiamo: noi sappiamo uccidere. [227]
(La scena dell’omicidio di Morana ha una forza realistica davvero inusuale rispetto alla normale rappresentazione della morte nell’epoca del pulp e dello splatter. La capacità di Vasta di fare del gesto che toglie la vita una questione lenta – non la pallottola delle Br, ma il soffocamento descritto dettagliatamente – e tattile, riesce a costruire una scena fuori dagli schematismi derealizzanti a cui siamo abituati).
Rispetto a questi processi di costruzione dei militanti, che si configurano come sottomissione dell’individuo all’idea e di sottomissione della realtà al progetto – in due parole come sacrificio della complessità in nome della prassi rivoluzionaria – Nimbo si trova mano a mano sempre più scisso, fino alla conclusione della parabola nel tradimento dei compagni in nome dell’amore per Wimbow, la Bambina Creola. La sconfitta dei progetti rivoluzionari è ineluttabile, pensata dal compagno Volo come fondamentale punto di conclusione di un processo di perfezione militante («la cerniera, la formula magica […] Mi dichiaro prigioniero politico […] la frase con la quale ci si libera della propria angusta storia per entrare nella mitologia rivoluzionaria» [252]); ma, nello stesso tempo, la scelta di tradimento di Nimbo appare come libero rifiuto di tutta la forma di vita che aveva contribuito a creare. La «fine delle parole» (strumento di razionalizzazione e dominio del reale) e l’inizio del «pianto» [274] sul quale si conclude il romanzo, appaiono allora come l’esplosione commossa di tutto quello che in nome della militanza era stato sacrificato: i margini, le sfumature, i punti ciechi, il caso. Ma di fronte a questa conclusione è necessario tornare indietro, affrontare le scelte prima che vengono fatte e capirne le ragioni, anche di quelle che saranno poi rinnegate. Non è la ragione che guida Nimbo a salvare la vita alla Bambina Creola condannata a morte dal NOI, ma un taciuto sentimento. La ragione – dilaniata – sta da un’altra parte. Nimbo non è un bambino ingenuo, un fantoccio nelle mani dell’ideologia, sa cosa sta facendo ed è consapevole delle contraddizioni nelle quali si imbatte. Capisce le dinamiche in cui è inserito fino al punto di affermare che «stato e Br coincidono» [150]: due poteri che si fronteggiano arrogandosi nello stesso modo il diritto la violenza; ma all’interno di questa coscienza sceglie fino alla fine la sua parte tra le file dei terroristi. Le scissioni interne di Nimbo trovano uno spazio di rappresentazione nei dialoghi tra il bambino e una serie di personaggi surreali (lo storpio naturale, il piccione preistorico, Crematogastra…) nei quali, in un alone onirico e sospeso, il conflitto tra ragione e ragioni della militanza viene teatralizzato. In questi dialoghi Nimbo si trova a difendere le sue posizioni di militante e poi di assassino di fronte alla criticità che pongono i suoi fantasmagorici interlocutori. La difesa avverrà fino allo strenuo, fino alla coscienza di Nimbo dell’impossibilità e della necessità, dell’estrema e (forse) insolvibile contraddizione che giace al fondo di ogni rappresentazione del mondo e della corrispettiva pratica che vuole cambiarlo:
Ci credo davvero?
Devo.
È una superstizione.
È necessaria.
Ma è superstizione
Anche quello che la Pietra [la madre di Nimbo, n.d.a.] ci legge sulla Bibbia è superstizione. Ascolto e non ci credo, però mi piace la forma che la Bibbia sa dare al mondo: lì dentro il mondo è una cosa seria.
Già, la struttura tiene, dice lei.
È una macchina che produce senso, chiarisco. All’inizio c’è il disordine, la malattia, l’errore; alla fine il cosmo, la salvezza e la giustizia. [157]
4. La maschera del saldatore
Non è tanto l’interpretazione del delitto Moro come meccanismo di compattamento di una comunità che si riunisce di fronte alle Brigate Rosse come suo capro espiatorio (cosa che già di per sé avrebbe valore) che interessa in questa sede. Quello che si è voluto mettere in luce è la capacità de’ Il tempo materiale di costruire una rappresentazione complessa e articolata di un fatto storico – la Palermo e l’Italia del 1978 – e dei suoi sottofondi antropologici – la violenza, l’innocenza, l’ideologia – attraverso un sistema di filtri. Lo straniamento, fuori dall’essere orpello retorico, diventa lo strumento stesso che rende possibile la rappresentazione delle ragioni e della fascinazione della lotta armata senza celarne le contraddizioni interne; stando per così dire a cavallo della linea che separa lo stato dalle Br – né di là né di qua, sia di qua che di là, ambiguamente. Se il discorso collettivo su Moro, sulle Brigate Rosse e sugli anni Settanta in generale sembra ossificato nell’aut-aut di cui parlavamo all’inizio, tanto da costituirsi come un tabù, il romanzo di Vasta riesce giocare all’interno di queste linee, cogliere sfumature e movimenti che ricompongono una complessità celata, e prendono parola là dove grava un pesantissimo silenzio (silenzio prodotto anche da eccesso di discorso). La possibilità di questa presa di parola sembra esser data però solo all’interno del meccanismo straniante; certi elementi della realtà – come le eclissi solari attraverso il vetro della maschera del saldatore – possono essere guardati solo attraverso un complesso sistema di filtri che li allontanano, mediando il nostro rapporto con essi. Là dove le rappresentazioni immediate delle ragioni dei terroristi e della militanza hanno fallito (e di testimonianze interne alle Brigate Rosse ne sono state prodotte numerose e anche significative), un romanzo che parla di strani bambini di 11 anni rasati e inquietanti sembra riuscire. La differenza è quella che passa tra il realismo e la realtà che, per poter trovare rappresentazione adeguata – soprattutto quando si parla di ferite aperte e nodi mai veramente risolti – dev’essere deformata fino a risultare irriconoscibile e lontana. Questi filtri che, mentre deformano, aiutano a vedere, messi tra l’occhio del lettore e l’oggetto delicato, imbarazzante o scabroso, sono stile, figure, invenzioni: quello che comunemente si chiama letteratura.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento