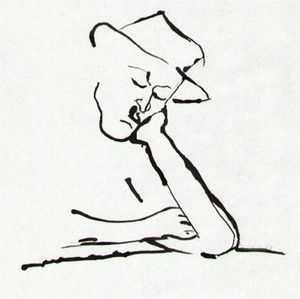
L’Estensione del dominio della lotta: un ufficio alla fine della storia. La figura dell’impiegato nella letteratura dell’Otto e del Novecento/7
Pubblichiamo il settimo di una serie di interventi sul tema dell’impiegato nella letteratura del XIX e del XX secolo. Questi interventi hanno la loro origine nel corso di Letterature comparate dell’Università di Perugia, e sono stati scritti sia da docenti, che da studenti che a quel corso hanno preso parte attivamente. L’introduzione a questo ciclo di post si può leggere qui. Il secondo intervento qui. Il terzo qui. Il quarto qui. Il quinto qui. Il sesto qui.
Michel Houllebecq è sicuramente uno degli scrittori più controversi del panorama letterario contemporaneo. Le sue opere sono un continuo pungolo volto ad evidenziare l’irreversibile cancrena etica e culturale del mondo Occidentale, prono sotto il trionfo del paradigma liberale.
Questo intervento si concentra sulla rappresentazione del mondo impiegatizio nella sua opera d’esordio, Estensione del dominio della lotta, pubblicata in Francia nel 1994.
In linea con la tradizione francese della rappresentazione letteraria dell’impiegato, Houllebecq pone, come protagonista del breve romanzo, un anonimo analista-programmatore di una società informatica la cui posizione è più che soddisfacente:
«il mio stipendio netto equivale a due volte e mezzo lo SMIC; il che significa già di per sé un buon potere d’acquisto. Posso sperare in una carriera significativa all’interno dell’azienda dove attualmente lavoro; a meno che io non mi decida, come molti altri fanno, di passare a lavorare per un cliente. Insomma posso dirmi soddisfatto della mia posizione sociale»
Questa apparente gratificazione lavorativa sarà tutt’altro che un veicolo in grado di portare il protagonista verso quell’appagamento libero e totale che il liberalismo ha da sempre proditoriamente promesso. Nella sua vicenda, il programmatore non soltanto si sentirà oppresso e prosciugato, libero soltanto di fumare pacchetti su pacchetti di sigarette, ma finirà con l’impazzire, implodendo sotto il peso di un sistema lavorativo e sociale incentrato sull’economia divinizzata, e sulla conseguente logica del consumo. Il successo del modello liberale, che si è potuto dispiegare in ogni angolo del pianeta all’indomani del crollo del muro di Berlino, ha generato un nuovo mondo, coronamento dell’ascesa storica dell’individualismo, in cui ogni istanza comunitaria, altruistica, amorosa è cancellata e soppiantata dall’unico orizzonte di senso accettato: la glaciale razionalizzazione, imperniata sulla dicotomia domanda-offerta, di ogni rapporto umano.
L’azienda per cui lavora il programmatore è quindi una delle tante articolazioni di questo mondo individualista, egoistico, competitivo e spersonalizzante. I dipendenti collaborano loro malgrado, pronti a scavalcarsi senza la minima pietà, e non lo fanno neanche per calcolato arrivismo: mors tua vita mea non è soltanto una scottante verità effettuale, ma è il monito che campeggia a caratteri cubitali nel decalogo della società civile, o di quello che ne resta. Nella società informatica, rigorosamente privata, dove il protagonista lavora, i rapporti tra quadri medi sono improntati ad una sorda ostilità o bene che vada all’indifferenza, quasi all’oblio: ad un certo punto il protagonista non è neanche certo del nome di un suo diretto superiore «E’ uno dei miei superiori gerarchici; credo che si chiami Norbert Lejally»
L’ufficio è una piattaforma asettica e disumana, in cui il dipendente è solo strumento volto alla mera utilità; l’unico spazio per la creatività e lo slancio sussiste nella misura in cui collabora all’ottimizzazione del profitto o della tecnica. Non è necessario nient’altro.
Siamo lontani anni luce dalle epopee d’ufficio balzachiane, dove l’ampio spettro delle sfumature umane trovava un suo affresco totalizzante, permettendo così una rappresentazione essenziale del reale. All’altezza de Gli impiegati di Balzac, cioè, era ancora possibile rappresentare i rapporti pugnaci tra esseri umani; la macchina burocratica era sì claustrofobica e farraginosa, ma inserita in un orizzonte comunitario- c’era uno Stato, e non uno stato cliente tra i clienti- e quindi manovrabile dall’essere umano, che, arrancando, provava ad orientarsi nel mondo. Nell’universo di Houellebecq non c’è spazio per questo tipo di narrazione, ma solo per una disincantata costatazione. La macchina ha vinto, è troppo capillare e perfetta, ed è informata dalla spietata logica capitalistica e rafforzata dalla tecnologia informatica; rende insomma l’essere umano una mera appendice, una rotella seriale addentellata ad un ingranaggio che non solo non può cambiare, ma nemmeno inceppare. Da tutto ciò deriva uno scenario apocalittico, atmosfera costante nell’opera dell’autore, all’interno del quale si vive in uno stato di perenne angoscia; la polverizzazione atomistica del tessuto sociale porta all’apatia, alla precarietà, all’aggressività, alla disperazione, alla vacuità universale. O si è integrati al sistema capitalistico unidimensionale, si lavora e si vive per esso, e ci si accontenta di consumare in solitudine le briciole dell’infantile felicità quantificabile, fatta di beni all’apparenza sempre diversi, ma sostanzialmente sempre uguali; oppure, se si ricerca l’amore, quello stato di grazia che, vitale illusione, elude la natura matrigna, si è condannati all’autodistruzione e alla follia. Il carattere monadico del protagonista, quella solitudine crudelmente tangibile, si palesa in tutta la sua irrimediabilità nella chiusura del romanzo: giunto in uno stato semi-allucinato nella foresta demaniale di Mazas, il soggetto non riuscirà nemmeno in un primitivo tentativo di fusione panica con la natura, giacché:
«Sono al centro del baratro. Sento la mia pelle come una frontiera, e il mondo esterno come uno schiacciamento. L’impressione di scissione è totale; ormai sono prigioniero in me stesso. La fusione sublime non avverrà; lo scopo della vita è mancato»
Questo romanzo può essere considerato il manifesto e il punto di partenza di tutta l’opera di Houellebecq. I seguenti romanzi affronteranno con taglio provocatorio il tentativo fallace dell’uomo occidentale di infrangere il diabolico incantesimo che da tempo gli si è ritorto contro: ne Le Particelle Elementari e ne La possibilità di un’isola la via d’uscita sarà il transumanesimo, in Piattaforma il turismo sessuale, fino all’ultimo e controverso Sottomissione, dove verrà profetizzata l’islamizzazione della Francia. Come si vede la provocazione prosegue; il mondo provocato, invece, pare rimanere caparbiamente così com’è.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento