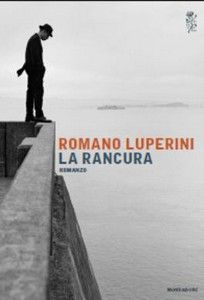
Giustificazioni dell’autore avventizio circa alcune scelte compiute nel suo romanzo/4
Le tre parti del romanzo (Memoriale sul padre, Il figlio, Il figlio del figlio) corrispondono a tre generi narrativi diversi. La prima (la storia del padre negli anni del fascismo e della resistenza) oscilla fra il romanzo storico e il memoriale e si avvicina alla docu-fiction: del romanzo storico ha l’alternanza fra invenzione e ricostruzione di fatti realmente accaduti (molti personaggi, qui come nella parte successiva, sono realmente vissuti e chiamati col loro vero nome), del memoriale il pathos del ricordo, della docu-fiction la documentazione. La seconda (la storia del figlio fra gli anni del dopoguerra e della contestazione e quelli di piombo) ha l’aspetto del resoconto autobiografico in prima persona ma in realtà si muove nell’ambito dell’autofiction; accanto a fatti realmente accaduti all’autore ve ne sono altri invece inventati o ricostruiti su documenti d’epoca. La terza (la storia del figlio del figlio, ambientata nel 2005) è un racconto oggettivo in terza persona, ma vi si incontrano anche riscritture ironiche di precedenti testi dell’autore. I due protagonisti delle prime due parti (il padre e il figlio) dapprima sono visti prevalentemente dall’interno, poi, nella parte immediatamente successiva a quella in cui compaiono per la prima volta, sono considerati e giudicati anche dall’esterno, in modo che il lettore non sia orientato in un’unica direzione e abbia una prospettiva valutativa aperta e problematica.
L’ambizione di chi scrive era duplice: da un lato fornire uno spaccato della storia d’Italia dagli anni del fascismo a quelli di Berlusconi, dall’altro rappresentare l’eterna contesa fra padri e figli, la rancura che li contrappone dall’Edipo dell’antica Grecia al Montale degli Ossi di seppia che appunto impiega questa parola (“rancura”) per dire il rapporto che li unisce e li divide. Chi scrive voleva porre in primo piano una rottura antropologica: fra il mondo dei nonni e dei padri e quello dei figli nati all’altezza degli anni settanta o subito dopo va registrata una frattura. I primi credevano nel cambiamento, lo speravano, a volte lo temevano, ma comunque esso era sempre presente nella loro prospettiva esistenziale; i secondi non lo ritengono plausibile, anzi non lo percepiscono più, non lo pensano neppure. I primi mettevano al primo posto nella loro vita le passioni, le speranze, i sentimenti, le emozioni; i secondi sono costretti a vivere perlopiù privi di aspettative e di grandi esperienze, senza grossi traumi, e temono i sentimenti e le emozioni. I primi sono patetici, i secondi cinici e ironici.
Nel bene e nel male l’autore appartiene al mondo dei primi. Per questo crede alle emozioni e vorrebbe che la loro intensità fosse avvertibile in ogni frase che scrive. Sa bene che in un romanzo sono necessarie anche parti grigie, opache, di mera informazione. Ma, pur facendovi ricorso, le detesta e cerca di ridurle al massimo. Vorrebbe che ogni segmento della sua scrittura conservasse una traccia dell’amore o dell’odio, della speranza o della paura, da cui essa, la scrittura, nasce. È inguaribilmente patetico. Però – attenzione! – lo sa, e cerca di controbilanciare questa pericolosa inclinazione con una buona dose di durezza e, talora, di cattiveria (come gli hanno insegnato Verga e Flaubert, scrittori patetici che si negano nel loro patetismo e lo rovesciano nel suo contrario). Credo che, sulla pagina, il ritmo dell’emozione e quello della sua negazione siano perfettamente percepibili.
D’altronde non riesco a scrivere in modo professionale. I veri scrittori scrivono ogni giorno un certo numero di ore. Per loro scrivere è un mestiere, un bellissimo mestiere artigianale. Scrivere è un lavoro che li impegna quotidianamente. E infatti sfornano un romanzo ogni anno, al massimo ogni due o tre. Io non sono un vero scrittore. Sono un autore avventizio. Sono rapido a scrivere, ma non scrivo sempre. Ho bisogno di un’idea, di un ricordo, di un’emozione. E poi spesso ho anche altri lavori da compiere, studi, saggi critici che rientrano nella mia professione abituale di critico letterario. Mentre scrivevo La rancura, pur avendo rinunciato a ogni impegno di questo tipo a causa della malattia e della convalescenza in cui mi trovavo, ogni tanto mi bloccavo, non riuscivo ad andare avanti, stavo fermo mesi e mesi finché un sentimento o un’intuizione non mi spingevano di nuovo al computer. Così ho impiegato tre anni, fra il 2012 e il 2015, pur potendo usare materiale elaborato per decenni, a partire addirittura dagli anni ottanta.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento