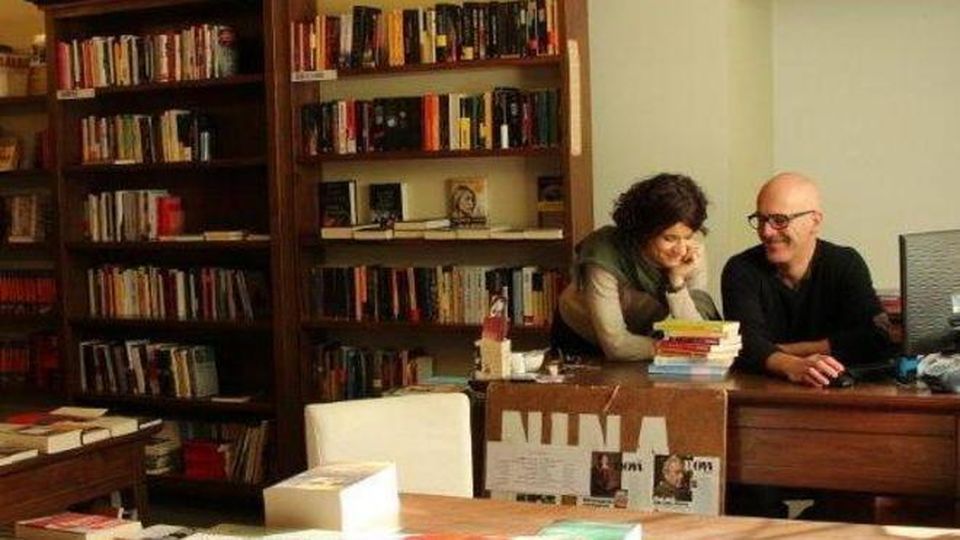
Perché quando la letteratura porta a scuola la vita si grida allo scandalo?
Gli italianisti dell’ADI-SD respingono il grave episodio di oscurantismo civile ai danni della formazione dei giovani e degliinsegnanti occorso al Liceo Giulio Cesare di Roma ed esprimono piena solidarietà alla dirigente, a tutti i docenti e studenti, in particolare alle due insegnanti volgarmente accusate di «aver istigato i loro studenti ad avere rapporti omosessuali», poiché hanno proposto alle loro classi di leggere il romanzo Sei come sei di Melania Mazzucco.
Lo sconcertante episodio confligge con l’esperienza quotidiana di chi a scuola insegna o studia e offre una inconfutabile conferma del valore irrinunciabile dell’incontro con la letteratura da parte dei giovani. Nella scuola, come nella vita, la letteratura consente a tutti di trovare una chiave per far esistere le cose del mondo secondo il loro peso e la loro essenza, oltre il velo di ovvietà o di ipocrisia che le ricopre. Una volta nominate, esse si possono accettare o rifiutare, ma non si possono più ignorare.
Nelle nostre aule deve entrare la complessità dell’esperienza umana, i cui denominatori comuni la scuola democratica è incaricata istituzionalmente di mostrare. La lettura degli autori antichi, moderni e contemporanei, di ogni provenienza geografica, ci insegna a pensarci membri della stessa specie, perché nelle loro opere possiamo riconoscere ciò che ci accomuna al di là delle differenze culturali e storiche che ci separano: con il loro aiuto impariamo a diventare un po’ meno stupidi e a respingereogni ottusità discriminatoria.
Se Borges, a chi gli domandava a cosa servisse la letteratura, rispondeva irritato che a nessuno sarebbe mai venuto in mente di interrogarsi sull’utilità del canto di un canarino o dei colori del cielo al crepuscolo, i mala tempora che attraversiamo ne confermano la funzione necessitante.
In un momento di trasformazioni convulse della nostra civiltà, la lettura di un buon libro si offre come mezzo potente per interrogare il senso del presente, per ascoltare le richieste di emancipazione, per arginare le derive del disagio nell’abbrutimento e nell’aberrazione. Ancor più questo vale a scuola, dove la lettura non è casuale né solipsistica, ma risponde ad un progetto formativo ed è accompagnata dal confronto delle riflessioni, e dove il docente, istituzionalmente chiamato ad una responsabilità educativa oltre che culturale, esercita una funzione di mediazione critica.
Chi come noi si spende ogni giorno per la scuola della cittadinanza attiva non può rinunciare a credere che riconoscere le diversità è un dovere di tutti e che i diritti sono gli stessi per tutti.
Siena, 1. 5. 2014
ADI-SD (Associazione degli Italianisti Italiani- Sezione Didattica)
ADI ((Associazione degli Italianisti Italiani)
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Commento
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Scelta didattica ineccepibile. La questione è ideologica
Concordo con l’intervento, che si tiene su linee generali, senza entrare nel merito della faccenda, che sembra complicata.
In realtà a me non pare complicata proprio per niente: si è voluto affrontare il tema dell’omofobia alla luce di fatti molto gravi (bullismo a scuola, suicidi di giovanissimi) che hanno colpito profondamente la sensibilità degli studenti; se è concordato un testo che affronta il tema delle famiglie di omosessuali; la lettura è stata seguita da un dibattito e un tema scritto: didatticamente nulla da eccepire.
E’ chiaro che ci troviamo di fronte al tentativo di una ristretta minoranza, probabilmente legata a qualche gruppo pseudo-religioso, come ad esempio CL, che vuole imporre la propria egemonia culturale, e politica, nella scuola pubblica, attraverso strumenti infami come la denuncia di due docenti che hanno correttamente svolto il proprio lavoro.
Non credo che ai querelanti interessino le questioni didattiche, né tantomento il punto di vista degli studenti su questa faccenda. Tra l’altro, la ministra Giannini si è espressa in difesa delle docenti: insomma, se perfino una democristiana è d’accordo, evidentemente il problema non è didattico, è unicamente, e vergognosamente, ideologico e politico.
Carlo Zacco
Docente di Lettere