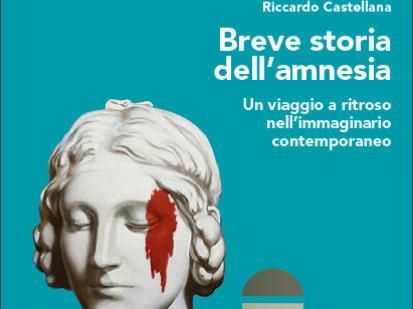
Breve storia dell’amnesia
Pubblichiamo l’introduzione all’ultimo libro di Riccardo Castellana, Breve storia dell’amnesia, Mondadori Università, ringraziando autore ed editore.
Introduzione brevissima a un libro breve
Qualcuno perde la memoria: di punto in bianco, dopo un forte choc. Da questa situazione di partenza molto semplice, vista tante volte nei film o a teatro e letta tante volte nei libri, si sviluppa poi un organismo complesso, una storia simile a un’indagine poliziesca, a un giallo o a un romanzo giudiziario: lo smemorato cercherà di capire chi è (se con la memoria ha smarrito anche l’identità) o almeno cos’ha fatto nell’arco temporale dei giorni, mesi o addirittura anni di cui non ha più ricordi. L’inchiesta potrà poi concludersi con successo, oppure dovrà essere archiviata per insufficienza di prove. Qualunque ne siano l’esito e le cause, però, la struttura narrativa di base si manterrà sempre, grosso modo, identica a sé stessa, tanto che non sembra azzardato parlare di qualcosa di più che un semplice tema o motivo ricorrente, ma di un vero e proprio “mito”; intendendo con questa parola un racconto (mythos), o meglio ancora lo scheletro, l’ossatura fondamentale di un racconto, rintracciabile, a una lettura attenta, in testi anche molto diversi tra loro, proprio come quei mythoi che la critica archetipica di Northrop Frye vedeva alla radice dei generi letterari. Con una differenza sostanziale, però: il mythos di cui parleremo noi non appartiene alle origini lontane di un oscuro passato come i miti cosmogonici greci, non è la «rivelazione» di qualcosa di sacro perchè si situa fuori del tempo (come scriveva Cesare Pavese), per la semplice ragione che, prima del Moderno, questo tipo di racconto non esisteva. Se infatti gli antichi conoscevano bene il topos dell’oblio, il mythos dell’amnesia appartiene invece al Novecento e alle sue propaggini nel nostro millennio. È per questo che la storia dell’amnesia è una storia breve.
Eroi ed eroine senza memoria, come vedremo, trovano ospitalità nell’immaginario narrativo occidentale solo a partire dal periodo compreso tra le due guerre mondiali, inizialmente soprattutto nel dramma teatrale. Poi, dagli anni Quaranta, gli amnesici popoleranno anche la narrativa di genere, tanto che oggi li si incontra spesso al cinema, con i volti di attori e attrici celebri come Harrison Ford, Nicole Kidman e Matt Damon, in film tratti da romanzi di spionaggio o di inchiesta. Ma un mythos, per essere davvero tale, deve essere ecumenico: deve parlare a tutti e superare le barriere di genere e di stile; e infatti di amnesici è piena tanto la grande letteratura (lo vedremo con molti esempi tratti da Pirandello) quanto la produzione seriale e di consumo. È questo territorio, vasto e molto affollato, che percorreremo nelle prossime pagine, senza pregiudizi culturali e cercando piuttosto di rispondere ad alcune domande molto semplici. La prima: perché una genesi così tarda? Perchè mai, cioè, proprio la nostra epoca è così ossessionata dalle storie di smemorati? E poi: com’è fatto un racconto d’amnesia e quali sono le sue costanti strutturali? E per quale motivo anche le storie artisticamente meno riuscite esercitano in noi una suggestione che va oltre il valore estetico e sembra toccare corde profonde della nostra sensibilità? Sono questioni alle quali una storia letteraria di tipo tradizionale non sarebbe interessata. Ma questa è una storia diversa dalle altre e, proprio perché a guidarla è il desiderio di capire il presente, la forma tradizionale della narrazione storiografica è qui rovesciata: inizieremo cioè dai nostri anni retrocedendo poi a passo di gambero fino alle primissime testimonianze del racconto d’amnesia. Non ho finto, insomma, di sapere già quale fosse il mio punto di arrivo: mi interessava invece scoprire quello di partenza e cosa li tenesse insieme, e fare in modo che i miei lettori lo scoprissero con me.
Un’ultima avvertenza: questo libro non parla di una malattia ma di un tema (e di una forma) dell’immaginario. Di conseguenza, i riferimenti alla psichiatria e ad altri saperi specialistici, che pure non mancheranno, servono più a capire in cosa un’opera di finzione si distingua dal discorso medico e scientifico che non a misurarne la fedeltà al reale. Perché se è vero che la finzione narrativa parte molto spesso da un dato oggettivo, che nel nostro caso è una malattia, quasi mai, però, ne offre una diagnosi attendibile; piuttosto, essa tenderà a innestare su quel dato reale elementi di pura invenzione, come il motivo del secondo colpo in testa che, come nelle comiche di Stanlio e Ollio, fa recuperare la memoria allo smemorato; oppure cercherà di alterare il rapporto con cui, nella pratica clinica, le forme più rare (ma più “romanzesche”) di amnesia si manifestano rispetto ad altre più comuni (ma meno narrativamente accattivanti). Eviterò quindi di valutare il racconto d’amnesia assumendo come parametro la fedeltà documentaria, e cercheremo piuttosto di capire insieme come questo mythos interpreti un certo spirito del tempo e riesca, in alcuni casi, persino a prefigurare una visione di ciò che tutti noi saremmo stati in seguito. Il mythos d’amnesia, ormai lo si sarà capito, racconta in modo figurato e quasi allegorico il più fragile e il più prezioso dei beni di cui noi moderni disponiamo: la nostra identità.
Articoli correlati
No related posts.
Commento
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


interessante.