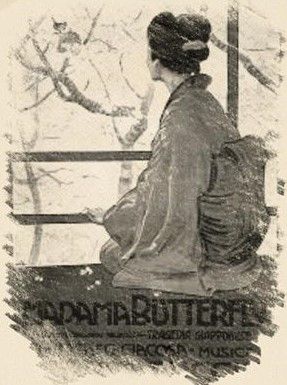
Perché leggere Madama Butterfly di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
Come Madame Chrysanthème diventò Madama Butterfly
Prima che Giacomo Puccini la mettesse in musica, consegnandola alla grande storia della lirica e alla memoria collettiva, Madama Butterfly si chiamava Madame Chrysanthème ed era l’eroina di un romanzo del 1887, scritto da Pierre Loti. A cambiarle il nome non era stato tuttavia il compositore lucchese né i librettisti Illica e Giacosa che, dopo Bohème (1896) e Tosca (1900), lo affiancavano nella stesura anche di questo melodramma, iniziata nel 1901; furono invece un narratore statunitense, John Luther Long, e un drammaturgo, anch’egli statunitense, David Belasco, che, com’è noto, da quel romanzo avevano tratto rispettivamente una novella (1898) e un atto unico, alla cui rappresentazione lo stesso Puccini aveva assistito a Londra nel 1900.
La prima scaligera del melodramma, nel febbraio del 1904, fu – anche questo è notissimo – un clamoroso quanto in apparenza inspiegabile fallimento. Puccini, però, benché amareggiato, convinto che si fosse trattato di una montatura ai suoi danni, e al contempo consapevole del valore della sua opera, volle rimaneggiarne la partitura, rendendola più agile e distribuendone diversamente il peso drammatico; e questo comportò anche un rimaneggiamento del libretto, non privo di dissapori con Illica (che firmava l’allestimento scenico della trama e l’impostazione dei dialoghi) e Giacosa (che ne era versificatore e autorevole revisore). Tuttavia, a soli tre mesi di distanza, l’opera fu rimessa in scena, inaugurando una lunga e interminata serie di successi.
Non è necessario essere melomani per aver ascoltato almeno una volta le arie famose della Butterfly e averne subìto l’incanto; sicché per molti e molte di noi Madama Buttefly è quelle arie, si risolve in quella indimenticabile musica. Ma non è possibile ignorare che, già a partire dalla prima metà dell’Ottocento, la librettistica melodrammatica presenti
un alto tasso, almeno presuntivo, di pedagogicità, perché, come in ogni operazione ‘popolare’, si ritiene necessario insegnare qualcosa, ovverosia convalidare esemplarmente ed esemplificativamente quel che è già stato insegnato, i valori e la loro gerarchia: la famiglia, l’autorità, la patria, Dio imperscrutabile ma provvidenziale, i buoni premiati e i cattivi puniti (con eccezione quando la provvidenzialità lo richieda), la legittimità dell’amore legittimato (che non è tautologia, anzi). E soprattutto l’ordine: purché alla fine venga ripristinato, sono ammessi tutti i disordini (…). (F. Portinari, Introduzione a Il teatro italiano, Il libretto del melodramma dell’Ottocento, Einaudi, Torino 1984, pp.XVI-XVII)
Queste osservazioni si riferiscono in particolare al melodramma di Verdi e a un’epoca in cui chi affollava i teatri della lirica spesso univa all’ammirazione verso il maestro il fervore del patriota e gridava “Viva Verdi!” perché altri intendessero “Viva V.E.R.D.I!”. Circa mezzo secolo separa quell’epoca dal debutto di Madama Butterfly e sicuramente le prime delusioni postunitarie avevano contribuito non poco a mutare la carica pedagogica del virus risorgimentale. Il libretto composto da Illica e Giacosa ne porta tutti i segni e qui proveremo a rintracciarne qualcuno, che possa costituire anche un valido perché: perché leggere il libretto, tentando, almeno per un istante, di mettere in sordina la musica.
Perché capovolge le istanze pedagogiche postunitarie
Cio-Cio-San ha soli quindici anni quando, per il tramite del sensale Goro, sposa il tenente della marina statunitense Pinkerton. La sua nobile famiglia, un tempo prospera, è caduta in disgrazia dopo che il padre di lei è stato indotto dall’imperatore a fare harakiri. La ragazza, che, per fronteggiare le difficoltà, ha accettato di fare la gesha, acconsente dunque alle nozze con lo straniero ravvisando in lui una sorta di eroe liberatore che, «per la vita», la terrà al sicuro:
Adesso voi
siete per me l’occhio del firmamento
E mi piaceste dal primo momento
che vi ho veduto. Sietealto, forte. – Ridete
con modi palesi!
E dite cose che mai non intesi.
Or son contenta. – Vogliatemi bene,
un bene piccolino,
un bene da bambino,
quale a me si conviene. (atto I, p.60) [1]
Lo sposo americano tuttavia non è animato da sentimenti ugualmente delicati, quanto piuttosto da una sorta di «facile vangelo», come lo definisce il più anziano console Sharpless, «che fa la vita vaga/ ma che intristisce il cor» (I, p.33):
Dovunque al mondo il yankee vagabondo
si gode e trafficasprezzando i rischi.
Affonda l’àncora alla ventura.
finché una raffica…(s’interrompe per offrire da bere a Sharpless)
Milk-Punch, o Wiskey?
(riprendendo)…scompigli nave e ormeggi, alberatura.
La vita ei non appaga
se non fa suo tesorle stelle d’ogni cielo,
i fiori d’ogni plagad’ogni bella gli amor.
(…)
Vinto si tuffa, la sorte riacciuffa.
Il suo talentofa in ogni dove.
Così mi sposo all’uso giapponese
per novecento-novanta-noveanni. Salvo a prosciogliermi ogni mese.
“America for ever!” (I, pp.32-33)
Assalito da «furor di rincorrerla», «se pure infrangerne dovessi l’ale», sordo agli accorati quanto deboli appelli di Sharpless («sarebbe gran peccato/ le lievi ale strappar/ e desolar forse un credulo cuor./ Quella – divina/ mite – vocina/ non dovrebbe dar note di dolor», I, p.35), Pinkerton sembra non accorgersi del sacrificio della piccola gesha che, proprio nel giorno delle nozze, per bocca del terribile zio-Bonzo, viene rinnegata e maledetta dalla sua famiglia, indignata da quella unione contraria alle millenarie tradizioni giapponesi. Formulata una vera e propria “promessa da marinaio” («tornerò colle rose/ alla stagion serena/ quando fa la nidiata il pettirosso», II, p.65), Pinkerton l’abbandona in realtà per tre lunghi anni, in condizioni prossime alla miseria, in compagnia della sola e fedele serva Suzuki, ignorando la nascita di «un figlio senza pari» con «occhi azzurrini» e «ricciolini d’oro schietto» (II, p.82). A nulla valgono le insistenze del viscido Goro, che, già all’indomani della partenza di Pinkerton, cerca di convincere Cio-Cio-San a riprendere marito, a nulla vale la corte del ricco Yamadori che, ripudiate già parecchie mogli, le giura tuttavia «fede costante», a nulla valgono i tentativi amorevoli di Suzuki di aprirle gli occhi («Mai non s’è udito/ di straniero marito/ che sia tornato al nido, II, p.65»), né tanto meno quelli imbarazzati di Sharpless, che ha ricevuto da Pinkerton l’incarico difficile di dirle la verità («Di strapparvi assai mi costa/ dai miraggi ingannatori./ Accogliete la proposta di quel ricco Yamadori», II, p.80): incrollabilmente convinta che tutti mentano («tutti!…tutti!…sol io/ lo sapevo – io – che l’amo», II, p-87), a dispetto di ogni evidenza, indossa «l’obi che vestì da sposa» (II, p.92) e, riempita la casa di ogni sorta di fiore profumato, si dispone a ricevere l’amato, della cui nave ha avvistato dall’alto l’ingresso nel porto di Nagasaki, l’attesissimo e vagheggiato «fil di fumo». Ma, dopo aver aspettato sveglia tutta la notte, si addormenta proprio alle prime luci dell’alba, quando Pinkerton, ormai informato da Sharpless dell’esistenza di un figlio, arriva costernato in compagnia di Kate, la moglie americana e, ritrovando «immutata la stanza/ dei loro amori», prorompe in una commozione tardiva e vigliacca:
Sì, tutto in un istante
vedo il mio fallo e sento
che di questo tormento
tregua mai non avrò,
mai non avrò!
Sempre il mite sembiante
vedrò, con strazio atroce.
Addio fiorito asil,
di letizia e d’amor.
Non reggo al tuo squallor!
Fuggo, fuggo: son vil! (III, p.99-100)
Dunque, ad accoglierla, Butterfly trova la sola Kate, confusa e intimidita: dopo un primo momento di autentico terrore («Quella donna/ mi fa tanta paura! Mi fa tanta paura!», III, p.103), si rivolge a lei con struggente gentilezza, ma si rifiuta di consegnarle il figlio del quale, nella prospettiva dei tre americani, «conviene/ assicurar le sorti» (III, p.98) trasferendolo oltre oceano: «A lui lo potrò dare/ se lo verrà a cercare» (III, 104) – dichiara. Rimasta sola, benda il bimbo mettendogli in mano una bandierina americana; chiusa in camera con lui, ma nascosta dietro un paravento, sfodera il pugnale con il quale suo padre si era dato la morte e si trafigge, mentre Pinkerton, sopraggiunto precipitosamente, sfonda la porta e inutilmente e ripetutamente invoca il nome di lei che muore.
Si provi, nel ripercorrere la trama, a isolarne la componente sentimentale e a concentrarsi su quella sorta di etichetta che Illica e Giacosa vollero apporre sotto il titolo del loro terzo (e ultimo) libretto pucciniano: «tragedia giapponese». Erano trascorsi circa vent’anni da quando Verga (che di Giacosa era notoriamente interlocutore e amico) aveva portato in scena la sua Cavalleria rusticana, ed era stato proprio Giacosa a individuarne per primo il portato autenticamente tragico: «Egli scelse l’ambiente rusticano perché i congegni della vita vi sono assai meno complicati, ed è quindi meno temerario il tentare di metterli in azione rinunziando ai vieti amminicoli della tradizione teatrale», aveva scritto Giacosa sulla Gazzetta piemontese nel gennaio del 1884, alla vigilia del debutto verghiano. Si direbbe che, con Madama Butterfly, i due librettisti tentassero – mutatis mutandis – un’operazione analoga, sfruttando la doppia connotazione dell’ambientazione, insieme esotica e domestica, per proiettare le inquietudini, le delusioni, i fallimenti della loro epoca in un contesto apparentemente straniato e distante dal pubblico che affollava i templi della lirica. Ma pure divenuta giapponese, la tragedia non allenta la sua morsa; che non consiste nel nodo alla gola che prende tutti per la fine straziante della sua protagonista: questa è cosa prevedibile perché – nei fatti – non fa che portare a compimento il piano esplicito di Pinkerton, di una superficialità che, a chiamarla spregiudicatezza o cinismo, le si fa un elogio. Altrove bisogna cercare lo spessore tragico dell’opera, nel ribaltamento (per riprendere le parole di Portinari) di quel che è già stato insegnato, i valori e la loro gerarchia: famiglia, autorità, patria, Dio, buoni premiati, cattivi puniti, legittimità dell’amore legittimato. Se di pedagogicità si vuol parlare a proposito di Madama Butterfly, si osservi pure che essa opera nel senso di istruire dolorosamente lo spettatore sulla perdita di questi valori.
Per sposare lo straniero Butterfly non ha esitato a rinnegare la religione degli avi:
Ieri son salita tutta sola
in segreto alla Missione.
Colla nuova mia vita
posso adottare nuova religione.
Lo zio Bonzo nol sa,
né i miei lo sanno.
Io seguo il mio destino
e piena d’umiltà
al Dio del signor Pinkerton
m’inchino.
È mio destino;
nella stessa chiesetta
in ginocchio con voi
pregherò lo stesso Dio.
E per farvi contento potrò forse
obliar la gente mia.
Amore mio! (I, p.49)
La famiglia pertanto rinnega Butterfly («Ci ha rinnegato tutti/ Rinnegato, vi dico/ degli avi il culto antico/ All’anima tua guasta/qual supplizio sovrasta/ Ci hai rinnegato e noi/ ti rinneghiamo», tuona lo zio-Bonzo, I, p.54). Il nesso famiglia-religione è saldo fin da principio tanto nell’ottica cristallizzata dei parenti di Cio-Cio-San, quanto nella prospettiva aperta della giovane gesha. E tuttavia è evidente che zio e nipote interpretino la sacralità del vincolo familiare in termini sostanzialmente diversi: per il Bonzo la famiglia è una sorta di setta, che deve tutelare con intransigenza i suoi princìpi per non rischiare di mettersi in discussione. Ogni elemento esterno rappresenta un pericolo di contaminazione e sovversione. A Bonzo gli altri familiari fanno un’eco ridicola e cattiva, venata d’invidia per una realtà alternativa che a loro resta di fatto preclusa:
PRIMA CUGINA:
In verità
bello non è.
BUTTERFLY (offesa)
Bello è così
che non si può sognare di più.
MADRE
Mi pare un re!ZIO YAKUSIDÉ
Vale un Perù!CUGINA
Goro l’offrì pur anco a me,
ma s’ebbe un no!BUTTERFLY
Sì, giusto tu!
AMICI E AMICHE
Ecco perché prescelta fu,
vuol far con te
la soprappiù.
ALTRI
La sua beltà già disfiorì.
CUGINI E CUGINE
Divorzierà?
ALTRI
Spero di sì! (I, pp.43-44)
Eppure, nonostante tutto, asciugate le lacrime da un Pinkerton infatuato e prodigo di vezzeggiativi («Bimba dagli occhi pieni di malìa», I, p.59), Butterfly si dice «rinnegata… e felice» (I, 58): uscire dagli schemi angusti della sua famiglia le dà accesso a una dimensione più autenticamente sacra della vita, fondata sulla fedeltà alle proprie scelte, sull’amore, sul rispetto. Tuttavia, tanto zelo nell’adempimento delle sue nuove funzioni di moglie e poi di madre, Butterfly lo deve anche all’educazione che le è stata impartita, nutrita di senso dell’onore e del dovere. Pinkerton ragiona solo in termini economici e, con cento yen, acquista, con impegno fluttuante, una casa e una moglie. È un legame contratto con un vizio di forma, evidente nelle parole del Commissario Imperiale che unisce Pinkerton e Butterfly «in matrimonio, per diritto,/ il primo, della propria volontà, / ed ella per consenso dei parenti»(I, p.51). Anche della ingannevole dimensione della legge e del diritto Butterfly avrà modo di fare dolorosa esperienza. Assediata dal sensale, dal nuovo pretendente, dall’impacciato console americano, che le suggeriscono nuove nozze, è al sistema giuridico della nuova patria che la giovane donna si appella:
BUTTERFLY (con serietà)
Già legata è la mia fede.
GORO e YAMADORI (a Sharpless)
Maritata ancor si crede.
BUTTERFLY
Non mi credo: sono – sono.
GORO
Ma la legge…
BUTTERFLY
Io non la so
GORO
…per la moglie, l’abbandono alle nozze equiparò.
BUTTERFLY
La legge giapponese…
Non già del mio paese.
GORO
Quale?
BUTTERFLY (con forza)
Gli Stati Uniti
SHARPLESS
Oh, l’infelice!
BUTTERFLYSi sa che aprir la porta
e la moglie cacciar
per la più corta
qui divorziar si dice.
Ma in America questo non si può – (a Sharpless)
Vero?
SHARPLESS (imbarazzato)
Vero… Però…
BUTTERFLY
Là un bravo giudice serio,
impettito dice al marito:“Lei vuol andarsene?
Sentiam perché?”
“Sono seccato
del coniugato.”
E il magistrato:
“Ah, mascalzone,
presto in prigione!”. (II, pp.74-75)
Ma il marito, per il quale ha rinnegato le leggi non scritte della tradizione, fra quelle leggi ha pensato bene di attenersi alla più iniqua: «l’abbandono al divorzio equiparar». Si polverizzano quindi tutti i consueti punti di riferimento esistenziali, in ultimo anche la legge di natura che lega un figlio alla propria madre. E Butterfly, non più figlia, non più moglie, non più madre, sente di dover morire, al contrario dell’eroina di John Long, per mantenere fede ai ruoli in cui ha creduto. Muore infatti riconciliandosi idealmente al suo universo morale, autoinfliggendosi, imperatrice di se stessa, un harakiri con lo stesso pugnale del padre.
Si può chiamare realmente ordine, quello che si ripristina alla sua scomparsa?
Perché mostra il fallimento della tragedia
La crisi dell’istituto familiare si legge in filigrana attraverso tutto il teatro italiano del secondo Ottocento: basti pensare, oltre alla già citata Cavalleria rusticana, a Miseria e nobiltà di Scarpetta, a Il rosario di De Roberto, a La moglie ideale di Marco Praga, a Come le foglie dello stesso Giacosa e via discorrendo; e tuttavia in questo libretto il crollo dei valori della famiglia e di quelli ad essa fortemente connessi (dio, patria, legittimità) segna anche la morte della tragedia.
Come Giasone a Medea, anche Pinkerton richiede a Butterfly l’affido della prole, benché usando, come tramite, tanto Sharpless quanto Suzuki – gli inascoltati ed impotenti “buoni” della vicenda, corrispettivo di figure antiche del teatro classico, come il pedagogo e la nutrice. A Medea, fremente di indignazione, Giasone spiega così il senso della sua richiesta e delle sue nuove nozze “regolari”, con una principessa greca e non con una maga barbara:
Il motivo principale era di garantirci un’esistenza comoda, fuori dalle ristrettezze (…) E volevo anche allevare i bambini in maniera degna del mio casato, dare dei fratelli ai figli che ho avuto da te, metterli tutti sullo stesso piano e costituire così un’unica famiglia. (…) io devo provvedere a quelli che ho attraverso quelli che dovranno nascere.[2]
Ragioni di comodità, economica e sociale, inducono dunque il fiero comandante della nave Argo a ripudiare la moglie impresentabile, che pure, per lui, ha rinnegato parenti e patria e si è costretta a una vita da esiliata pur essendo discendente nientemeno che dal dio Sole. Analogamente Pinkerton, da vero colonizzatore, si mostra da subito sprezzante verso la comunità giapponese che lo accoglie:
Che burletta la sfilata
della nuova parentela,
tolta in prestito, a mesata.
Certo dietro a quella vela
di ventaglio pavonazzo,
la mia suocera si cela.
E quel coso da strapazzo
che fa salti di ranocchio
è lo zio briaco e pazzo.
Manco male anche il marmocchio,
lustro, giallo e grassottino.
Or complottan, stretti a crocchio,
e mi ponzano l’inchino. (I, p.42)
e brinda pensando già «al giorno in cui si sposerà con vere/ nozze, a una vera sposa… americana» (I, p.36); che – come s’è visto – prende in moglie davvero e alla quale, per ragioni di comodità del tutto analoghe a quelle di Giasone, chiede che venga affidato il bimbo nato dall’unione illegittima, non riconosciuta dalla civilissima legge americana.
Ma Medea, come sappiamo, uccide entrambi i figli pur di non cederli al marito e alla rivale; e il dio Sole le manda addirittura un carro alato che la porterà lontana, insieme ai corpi inanimati dei bambini, per seppellirli nel tempio di Era Acraia, nel quale Giasone non potrà inginocchiarsi mai. Butterfly, invece, cede: «Ah! triste, triste madre!/Abbandonar mio figlio!/E sia. A lui devo obbedir!»(III, p.104); e uccide se stessa. Lo fa – così vuole la logica borghese dell’intreccio – per salvaguardare il bambino da cattiva fama: se restasse con lei, dovrebbe «prenderlo in braccio ed alla pioggia e al vento/ andar per la città/ a guadagnarsi il pane e il vestimento» (II, p.82); oppure dovrebbe tornare a far la ghesha, un «mestier che al disonore porta» (II, p.83). Ma se lo cedesse, e restasse viva, sarebbe la causa di quello che oggi chiameremmo (ma allora non si chiamava ancora) trauma da abbandono: e Butterfly, con moderna preveggenza, lo sa:
Non saperlo mai
per te, per i tuoi puri occhi, muor Butterfly
perché tu possa andare
di là dal mare
senza che ti rimorda ai dì maturi
il materno abbandono. (III, p.106)
La tragedia antica, fondata sulle inconciliabili aporie dell’etica, si dissolve così nella cronaca drammatica del quotidiano borghese, votato all’utile e vittima del giudizio sociale. E la metrica spezzata e diseguale, i versi bizzarri che fanno rimare mai con Butterfly, rischi con wiskey o che combinano, insieme a un dizionario italiano intermittente (a volte elegantissimo, a volte bizzoso), espressioni del parlato americano («How-exiting! Giudizio:/ o il pseudo sposalizio/ vi mena al precipizio», I, p.43), ancora prima di incontrare la partitura musicale, indicano già un ritmo esistenziale deprivato di ordine e simmetrie, come di abissali e insanabili cesure.
Perché segna la crisi del romanticismo
Madama Butterfly è dunque un’opera al bivio, sul crinale pericoloso che separa il romanticismo dal decadentismo; e per questo è esemplare. La rappresentazione della crisi dei valori tradizionali, l’agonia del discorso tragico sembrano i sintomi vistosi della fine del romanticismo. D’altra parte, l’ambientazione domestica, benché esotica (ma di quell’esotismo che solleticava la borghesia senza obblighi di comprensione della diversità), parla il linguaggio del dramma borghese (si è indagata Butterfly perfino come figura ibseniana) e realistiche sono le movenze dei dialoghi e realistici gli interni, i nomi dei personaggi, i riferimenti puntuali alle usanze e alle leggi, perfino i fiori di cui Cio-Cio-San riempie la casa per la cerimonia di accoglienza a Pinkerton – che è insieme festosa e funebre. Ed è qui che si appunta in chiusura la nostra attenzione, su questo dettaglio che celebra insieme pulsioni di vita e di morte, vitalismo e presagi luttuosi. Se non è ancora decadentismo, è già il segno della décadence, della nostalgia corrosiva di un mondo abitato dalle grandi passioni, inesorabilmente soppiantato dall’universo dei Pinkerton&Co.
[1] Qui si cita l’edizione Ricordi del testo, a cura di E. Rescigno, Milano 1988
[2] Euripide, Medea, Garzanti, Milano 2003 [1990], p.35 (traduzione di U. Albini)
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento