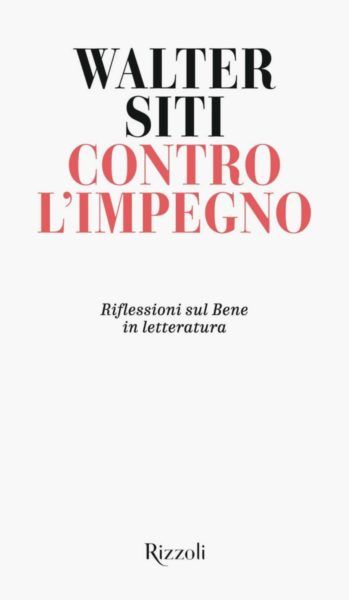
Su Contro l’impegno di Walter Siti
Ho finito di leggere più di un mese fa Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura di Walter Siti (Rizzoli editore). È un libro pieno di conoscenze in ogni campo letterario (poliziesco, romanzo di denuncia, romanzo di intrattenimento, tendenze della critica attuale…) ed extraletterario (TV, giornalismo, fumetti, canzoni, cinema…). Il lettore, nonostante tanto sciorinamento di cognizioni e di titoli, lo legge di un fiato, e finisce per convincersi che il guaio della nostra letteratura più recente sia l’impegno, la tendenza (ad avviso di Siti, dominante) a battersi per il Bene contro il Male, promossa, parrebbe, dal sistema vigente in campo economico, culturale e politico. L’impegno, anzi il “neoimpegno”, caratterizzerebbe l’ultimo ventennio e sarebbe, sembra di capire, il responsabile della decadenza attuale delle lettere.
Chiuso il libro, vorrei parlarne, se posso dirlo, all’ingrosso, senza entrare nel dettaglio, senza citazioni (se non di passi che mi sono rimasti impressi in mente), ma confrontandomi direttamente con la sua tesi di fondo, che ho riassunto sopra brevemente. Ho l’impressione che questa opera brillante e per molti versi intricante e acuta si fondi su una contraddizione non risolta. L’autore afferma di continuo che la letteratura, quando è artisticamente ben risolta, sta non nel contenuto, ma nella capacità della forma di conoscere il mondo, sempre in modo ambiguo, complesso, problematico. La vera letteratura insomma non offrirebbe convinzioni, ma smarrimento. E tuttavia poi l’analisi di Siti è sempre contenutistica: sembrerebbe, per esempio, che occuparsi delle vittime, farle parlare o far parlare i loro aguzzini, mettere in scena gli esuli e così via, sarebbe uno dei tratti più esecrabili del cosiddetto “neoimpegno”. La vittima sarebbe usata, ohibò, per una “visione sentimentale” del mondo, scrive Siti. Ma non è da secoli che la letteratura si occupa di questi temi, dall’Odissea e dalla Eneide ai Miserabili di Hugo sino a oggi? Rosso Malpelo incoraggia una “visione sentimentale” del mondo? Siti sa bene, e lo scrive a chiare lettere, che un testo può sostenere cause etiche e politiche “senza avvilire” (la litote è dell’autore) le potenzialità conoscitive della letteratura. E d’altronde la Commedia dantesca (opera incomprensibile senza pensare alla lotta del Bene contro il Male) sta lì a dimostrarlo. Rosso Malpelo è una vittima perseguitata tanto dal padrone, quanto dalla comunità; ma la grandezza del racconto sta nello stravolgimento per cui la sua vicenda è narrata dalla prospettiva dei suoi aguzzini. In quegli anni (in cui bisognava, fatta l’Italia, “fare gli italiani”) raccontare la storia dei bambini che dovevano imparare a lavorare e a integrarsi nel mondo degli adulti era un topos presente in Collodi, de Amicis, Capuana e molti altri, ma Verga lo riprende solo per rovesciarlo. Eppure Siti, quando passa dalla teoria alla pratica critica; sembra dimenticare la prima e seguire solo il proprio istinto di polemista. Così, per esempio, reso omaggio a Gomorra, intende ridimensionare la figura complessiva di Saviano scrittore. Ma che Saviano, dopo Gomorra, non abbia più scritto opere di sicuro valore letterario lo hanno dimostrato in molti (e io stesso fra questi), senza per questo avvertire la necessità di attaccare l’impegno che infesterebbe la letteratura contemporanea e limiterebbe fatalmente questo autore.
Voglio dire che da sempre alla letteratura è capitato di difendere il Bene contro il Male, o di scandalizzare il lettore difendendo il Male contro il Bene, ma bisogna vedere come lo fa. Che il sistema dominante sostenga questa tendenza secolare può darsi (ma non ne sarei sempre sicuro), però comunque è storia vecchia (si pensi per esempio al rapporto fra Virgilio e la politica di Augusto, decisivo per capire l’Eneide). Per trovarne una ragione, non c’è bisogno di una “mutazione genetica” del fatto letterario, come scrive Siti. Una mutazione probabilmente c’è stata assai prima dell’ultimo ventennio, a partire dal postmodernismo, ma riguarda la scomparsa dello scrittore-intellettuale, la mercificazione ormai totale del genere romanzo e, di conseguenza, l’abbassamento drastico della qualità letteraria. Si vedano i nomi dei finalisti allo Strega negli anni sessanta del Novecento (Fenoglio, Volponi, Primo Levi, Natalia Ginzburg…) e quelli degli ultimi dieci o quindici anni, e si capirà quale mutazione genetica ci sia stata.
Siti parla del poliziesco e attacca Carofiglio ma non nomina neppure Camilleri, che pure introduce nel “giallo” un problematicismo pirandelliano non privo di complessità. Afferma, come già si è detto, che fine dell’arte è lo smarrimento del lettore, non la sua persuasione. Ma, obbietterei, questo è vero sempre? Anche con Dante? Anche con Tolstoj?, o se, piuttosto, Dante e Tolstoj intendessero soprattutto convincere i loro lettori e si servissero anche dello smarrimento per raggiungere il loro fine?.
In conclusione: Siti muove da persuasioni di tipo modernista (come ognuno sa, i principali esponenti del modernismo, come Svevo o Joyce, non sono certo scrittori “impegnati”) non sempre però applicabili all’intero campo letterario e alla sua storia, nonché da pregiudizi, temo, di matrice crociana. Cosicché dal suo libro c’è molto da imparare se si studia la cultura e il costume dell’ultimo ventennio, molto meno, credo, si ci interessano valori e disvalori della letteratura contemporanea.
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento