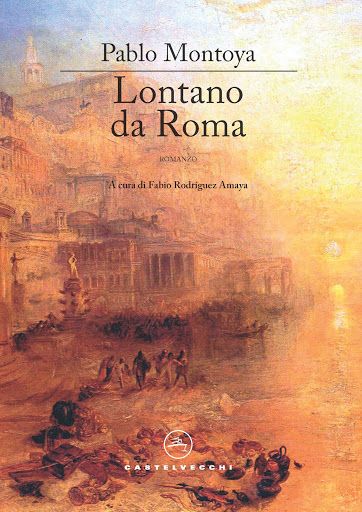
Appunti di lettura, Lontano da Roma di Pablo Montoya
Tendo lo sguardo all’orizzonte. In lontananza si precipita un gabbiano. Sotto il suo volo il mare sorge come un’esaltazione grigia. Poi appare la nave. Al di là delle vele un sole si eclissa tra vaghi splendori. Spuntano uomini, e le loro grida affollano il porto di Tomi. […] Guardo di nuovo il mare, e le onde sembrano il sospiro di un dio immortale ma stanco. Da giorni cade una pioggia fitta.
Le righe sopra riportate sono l’incipit di Lontano da Roma (trad. Ximena Rodriguez Bradfor, Castelvecchi 2020) di Pablo Montoya, l’io narrante che contempla il mare all’orizzonte è Publio Ovidio Nasone, esule a Tomi. Qui è necessario da subito fare una prima riflessione, il romanzo di Montoya non è il solito romanzo storico su un dato periodo, anzi a essere precisi quello dell’autore colombiano non è in nessun modo ascrivibile né al romanzo storico né alla biografia romanzata.
Montoya scarnifica al massimo l’ambientazione romana, tralascia quasi completamente il pettegolezzo del “carmen et error” che condusse il poeta delle Metamorfosi esule in terra di Romania, non si preoccupa volutamente degli intrighi di corte e gelosie, mette in secondo piano anche la ricostruzione oleografica e accattivante che uno scrittore mediocre avrebbe usato per attirare l’attenzione del lettore, e centra la sua attenzione sull’analisi dell’interiorità del poeta, tramite una scrittura evocativa, in cui si avverte la necessità – direi naturale, vista anche la brevità icastica della frase – di un “andare a capo”, il tentativo di una versificazione nascosta, una musica, una scelta delle immagini più per suono che per senso. Insomma verrebbe da dire che quello di Montoya più che un romanzo è un poemetto lirico, tanto da potercelo figurare come l’ultima postuma elegia che Ovidio stesso aggiunge alle sua Tristia, quella che scritto molte volte nella sua mente e che solo in punto di morte riesce a dettare.
C’è nel libro di Montoya una sapiente architettura, un gioco di contrasti tra luce e buio, tra disperazione e quieta accettazione del proprio destino. La parabola, più che la trama, del romanzo è tutta qui. Rileggiamo l’incipit riportato: il mare bagnato dalla pioggia, un cielo oscuro e ostile, un uomo che guarda il mare e si sente come una nota di sorda disperazione, di solitudine completa e totale; a questo si oppongano le righe finali del testo
Come un sussurro, odo la voce che mi chiama dalla spiaggia. Publio Ovidio Nasone, sento arrivare al di là delle onde, dall’altra sponda del mondo. Il mio nome inizia a diluirsi nella luce. E un belato, l’ha di una voce femminile, il suono dell’acqua e di un flauto proveniente da Tomi o da Sulmona svaniscono nell’aria
La parabola esistenziale dello scrittore è tutta racchiusa tra le fosche luci dell’inizio e questo splendore liquido in cui acqua, voce si confondono, in cui presente e passato sono sullo stesso piano. A colpire in queste righe, ma anche nell’intero arco del libro, è il riferimento alla musica e alla voce; potremmo dire che Lontano da Roma è una sorta di stenografia della voce poetica di Ovidio, che si interroga e si domanda perché sia finita in questo posto ostile; non è casuale, allora, che il suo primo incontro con la gente del posto sia nel segno della totale incomunicabilità; e che la rinascita e l’accettazione di tale destino avvenga nel momento in cui Ovidio conosce una donna che parla la sua lingua.
Rimaniamo sull’immagine del nome che si diluisce nella luce, Montoya avrebbe potuto costruire un romanzo in cui emergono nel corso della pagine i personaggi e i fatti che il poeta latino canta nelle Metamorfosi, una cosa simile l’ha compiuta Christoph Ransmayr ne Il mondo estremo (Feltrinelli), ma a ben vedere lo scrittore colombiano rinuncia a questa possibilità e del poema ne evidenzia il nucleo narrativo ovvero raccontare il mutare delle forma in nuovi corpi – “In nova fert animus mutatas dicere formas/corpora” – e ne elegge il mito più conosciuto quello di Eco che si disfa in voce – “sonus est, qui uiuit in illa”. Ovidio vive su di sé lo stesso destino, potremmo dire fato?, del suo personaggio: poco per volta il suo corpo si disfa, si liquefa in solo voce. Se, però, nelle vicende di Eco la metamorfosi è figlia di un dolore e di una disperazione, in Montoya questo cambiamento deriva dall’accettazione dell’esilio, dalla capacità di accettare l’essere ai confini del mondo che Ovidio stesso aveva contribuito a creare, cantandolo.
L’esilio dona a Ovidio una profondità di veggenza, è questa una delle scelte più interessanti del romanzo. Lontano da Roma è diviso in brevi capitoli, che in parte potremmo leggere anche come singoli racconti staccati, in cui si ripercorrono temporalmente i giorni dell’esilio; questa linea diacronica viene interrotta in due occasioni (i capitoli La cicatrice e La moltitudine). Entrambi sono introdotti come se accadessero in sogno, che l’io narrante non percepisce come tale. Anzi ciò che Ovidio osserva è così concretamente reale da lasciarlo incredulo.
Egli romano del tempo di Augusto non riesce in nessun modo a venire a capo di ciò che gli accade di vedere, ma noi lettori sì, noi comprendiamo come il prigioniero, che incontra ne La cicatrice e che gli mostra fotografie, raffiguranti delle torture, sia l’uomo torturato di Abu Ghraib; e allo stesso modo sappiamo che l’allucinante moltitudine del capitolo omonimo, che Ovidio vede passare sotto i suoi occhi, altro non è che la fila ordinata dei deportati di un lager che marciano verso la propria morte.
Questa sensazione di estraneità che Ovidio prova nel vedere qualcosa che è fuori dalla sua comprensione è il dono dell’esilio, il dono dello sguardo verso il futuro, la capacità di vedere oltre il tempo e lo spazio in cui il poeta concretamente vive.
Lontano da Roma quindi è anche una riflessione su cosa significhi essere scrittori e abitare il proprio tempo; scrivere non è un semplice orpello, un gioco combinatorio di forme, ma è una visione traumatica, dove il trauma è appunto ferita aperta, divaricazione che ci permette di guardare e vedere ciò che non è nostro. Per arrivare a questo, Ovidio deve spogliare se stesso, deve rinunciare a tutto: al pubblico, agli applausi, al palcoscenico, alle lodi, alle feste. Scrivere non è ricercare un consenso, non è neppure scrivere il testo necessario, quello che tutti si aspettano, ma è un atto che riguarda l’essere ai margini, lontano dalla macchina culturale
Un tempo scrivevo per vanità. […]. Pensavo che l’erudizione e l’adulazione fossero una prerogativa fondamentale per essere letto. Oggi scrivo con scetticismo, sapendo che nessuno mi leggerà. E solo oggi posso dire di scrivere davvero e di essere davvero me stesso. Gli altri mi interessano poco. Scrivo e sono il mio unico lettore. Non scrivo più nemmeno per te, come ho fatto tante volte in passato. Tutto ciò che esula da questo atto solitario mi lascia indifferente. Un tempo scrivevo vestito, protetto dal manto di Calliope. Mi credevo attorniato dagli dèi, e perfino dall’ombra dei miei morti. Oggi so che la poesia è la parola dell’emarginato, del reietto, del derelitto. E so che solo rinunciando a tutto si riesca a toccarne il segreto
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento