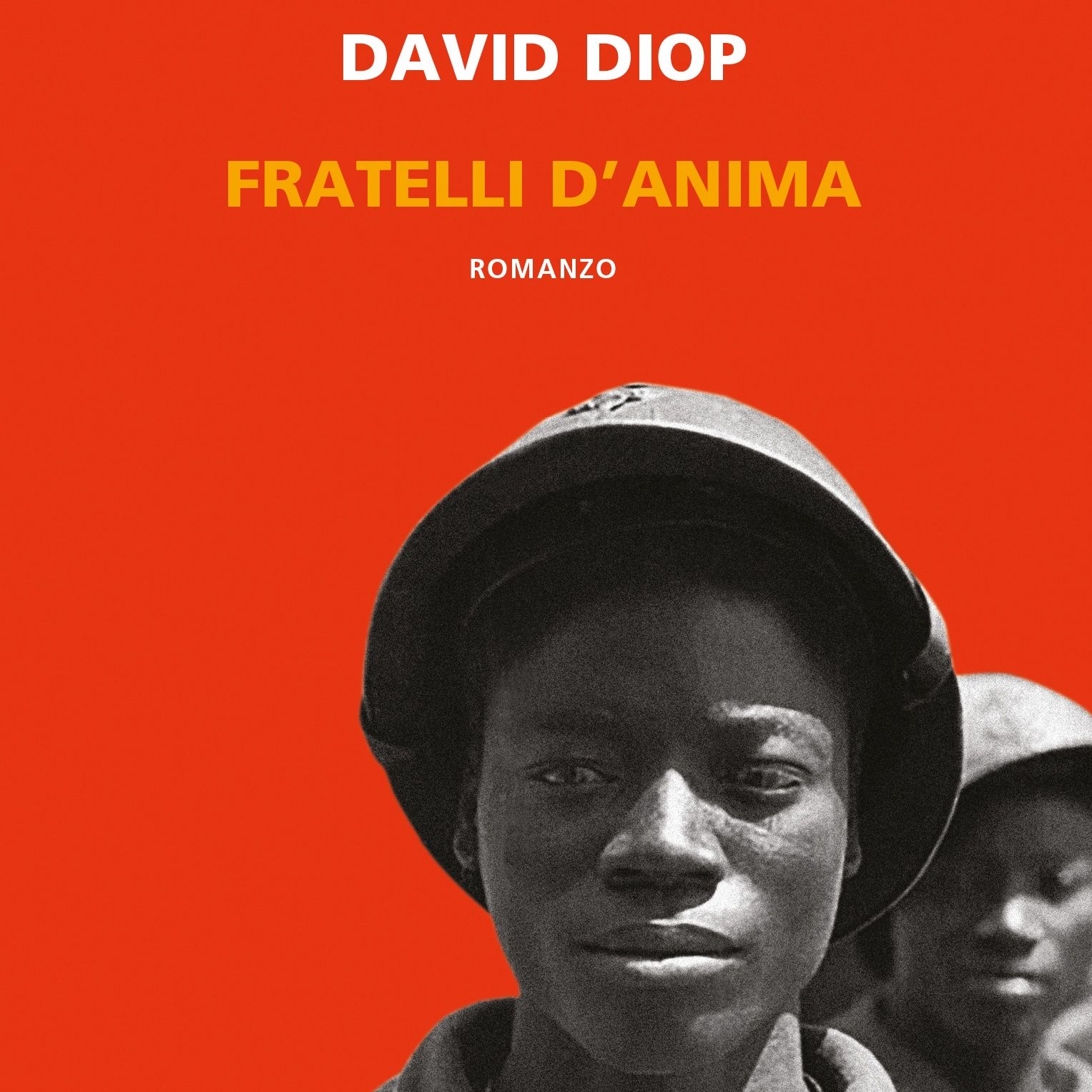
“Ogni cosa è duplice: ha una faccia buona e una cattiva” David Diop, Fratelli d’anima, Neri Pozza, Vicenza 2019
«Sono l’ombra che divora le rocce, le montagne, le foreste e i fiumi, la carne degli animali e quella degli uomini. Scuoio, svuoto i teschi e i cadaveri. Mozzo le braccia, le gambe e le mani. Fracasso le ossa e ne succhio il midollo. Ma sono anche la luna rossa che sorge sul fiume, sono l’aria della sera che agita le foglie tenere delle acacie. Sono la vespa e il fiore. Sono sia il pesce guizzante che la piroga immobile, sia la rete che il pescatore. Sono il prigioniero e la sua guardia. Sono l’albero e il seme da cui è nato. Sono il padre e il figlio. Sono l’assassino e il giudice. Sono la semina e il raccolto. Sono la madre e la figlia. Sono la notte e il giorno. Sono il fuoco e il bosco che ne viene divorato. Sono l’innocente e il colpevole. Sono l’inizio e la fine. Sono il creatore e il distruttore. Sono duplice».
Tradurre non è mai semplice. Tradurre significa tradire sui margini, significa intrallazzare, significa mercanteggiare una frase per un’altra. Tradurre è una delle rare attività umane in cui si è costretti a mentire sui particolari per restituire a grandi linee la verità. Tradurre significa assumersi il rischio di capire meglio degli altri che la verità della parola non è unica, ma è duplice, triplice, quadrupla o quintupla. […]
«Che cosa ha detto?» si chiesero tutti. […]
Il traduttore parve esitare. […] Si schiarì la voce e rispose alle alte uniformi con una vocina quasi impercettibile:
«Lui ha detto di essere al tempo stesso la morte e la vita». (p. 115-116)
Negli ultimi anni, in corrispondenza con il centenario della Grande Guerra, non sono certo marcate le letture (saggistiche, narrative, ma anche ibride) che hanno restituito l’eco di memorie rimosse ed eredità inconfessate. Questi contributi alla conoscenza e alla coscienza storica hanno corroso certi luoghi comuni e hanno dipinto un quadro ricco di sfumature inattese quanto oramai indelebili. La retorica celebrativa dei fatti riceve ora l’ennesimo, deciso colpo dalla pubblicazione del romanzo Fratelli d’anima di David Diop: un libro piccolo solo per la mole, un romanzo breve che, dopo aver vinto il Prix Goncourt des Lycéens nel 2018, è stato insignito del Premio Strega Europeo 2019, assegnato in memoria del giornalista Antonio Megalizzi. Una narrazione potente, eccentrica, che disturba e seduce, che provoca orrore e commozione, che vive di contrasti la cui matrice non è certo estranea alla storia del suo autore: David Diop è nato a Parigi da una madre francese e da un padre senegalese, è cresciuto in Senegal, ma è tornato in Francia: vive ora nel Sud e insegna letteratura all’Università di Pau. È titolare dunque di un’identità meticcia, che confessa felicemente risolta, cui si aggiungono mestiere e sensibilità non comuni nell’uso degli strumenti propri della letteratura: Diop riesce a tradurre le emozioni intense dei suoi personaggi, a consegnarle intatte, nella loro complessità contraddittoria, ai suoi lettori.
I cioccolatini dell’Africa nera
Sul fronte occidentale, in una di quelle «ferite aperte nel cuore della terra che chiamano trincee» (p.10), «labbra socchiuse del sesso di una donna immensa», nell’esercito francese, in prima linea fra le truppe d’assalto, opera un corpo di fucilieri volontari originari del Senegal. Furono circa 200mila i soldati reclutati nelle colonie per diventare «carne da cannone» durante la Prima guerra mondiale. Erano molto temuti dai nemici in virtù del loro aspetto esotico e della loro anima feroce e i superiori bianchi, avvalendosi di un “cioccolatino croce di guerra” che traducesse nella lingua del Senegal, in wolof , non perdevano occasione per incitarli a farsi onore sul campo di battaglia: “Voi cioccolatini dell’Africa nera, siete per natura i più coraggiosi fra i coraggiosi. La Francia riconoscente vi ammira” (p. 18), dice il capitano Armand, “un piccoletto con gli occhi neri gemelli intrisi di una rabbia perenne” (p. 66) che a sua volta prende ordini dal generale Mangin. E per questo, per recitare la parte “dei negri selvaggi, dei cannibali, degli zulù”, con il fucile nella mano sinistra e il machete nella destra “si mettono in faccia degli occhi da matto, […] si fanno ammazzare cantando” (p. 17). Un modo per dimenticare la loro stessa paura. Una prova della loro natura docile: “La Francia del capitano ha bisogno della nostra natura selvaggia, e siccome noi siamo obbedienti, io e gli altri facciamo la parte dei selvaggi. Facciamo a pezzi le carni nemiche, storpiamo, decapitiamo, sventriamo” (p. 18).
Dal sogno alla disillusione
Così dichiara uno di loro, Alfa Ndiaye, del villaggio di Gandiol vicino a Saint-Luis-du Sénegal, voce narrante del romanzo Fratelli d’anima. Alfa si è arruolato per seguire il suo amico d’infanzia, il suo “più che fratello”, Mademba Diop (un omaggio, come si evince dal nome, a un membro della famiglia dello scrittore, morto in trincea durante la Grande guerra). Mademba ha frequentato in Senegal la scuola dei colonizzatori bianchi, dove gli hanno “messo in testa l’idea di salvare la madrepatria, la Francia” (p. 94). Ha inseguito con tenacia il sogno di diventare cittadino francese arruolandosi come fuciliere: poiché il suo fisico “magrolino”, da “mezza cartuccia” (p.73), “troppo gracile, leggero e sottile come una gru coronata” (p. 95) – non a caso il suo animale totem – non era adatto al combattimento e alla fatica fisica, si è rivolto all’amico Alfa. “Per due mesi interi, ho costretto l’esile forza di Mademba a crescere sempre di più. L’ho fatto correre nella sabbia sotto il sole di piombo del mezzogiorno, gli ho fatto attraversare il fiume a nuoto, gli ho fatto spezzare per ore e ore con la daba la terra di suo padre. Per la verità di Dio, l’ho costretto a mangiare enormi quantità di pappa di miglio con l’aggiunta di latte cagliato e pasta d’arachidi, come fanno i lottatori degni di questo nome” (p. 95). La gru coronata si trasforma così in una pernice abbastanza grossa, ottiene di essere arruolata, e naturalmente porta con sé in Europa, al fronte, il suo inseparabile amico alto e forte. Ma “quel giorno, nonostante tutto il suo sapere, nonostante tutta la sua scienza, Mademba Diop non ha riflettuto. […] Non si porta il proprio più che fratello alla follia temporanea in un posto in cui una gru coronata non potrebbe sopravvivere un solo istante; un campo di guerra in cui non cresce neanche più una piccola pianta, un piccolo arboscello, come se migliaia di cavallette di ferro vi si fossero sfamate nel corso di molte lune. Un campo disseminato di milioni di piccoli semi di guerra metallici che non producono nulla. Un campo di battaglia sfregiato predisposto per i carnivori” (p. 39). Ogni volta che i capi toubab, cioè i bianchi, ordinano l’assalto con un fischio “per avvertire il nemico che stavamo per uscire dal ventre della terra, per avvertire il nemico di prepararsi bene a mitragliarci” (p. 41), Alfa si incolla a Medemba; non si illude di riuscire a proteggerlo, vuole solo condividere lo stesso destino: essere ucciso, essere ferito, salvarsi con lui perché “eravamo come due fratelli gemelli usciti lo stesso giorno o la stessa notte dal ventre della loro madre” (p. 41).
Dalla disillusione alla tragedia
Durante una di queste folli sortite Mademba Diop viene ferito e dopo una lunga agonia, che dura dall’alba al tramonto, muore bocconi “con le budella all’aria” (p. 12) nella terra di nessuno accanto al suo fratello d’anima, accanto ad Alfa. Questi rifiuta per ben tre volte di dargli il colpo di grazia, di sollevarlo dalle sofferenze che diventano sempre più atroci, che trasformano una richiesta formulata “con gli occhi asciutti”, “senza cerimonie, gentilmente” (p. 13), “amichevolmente, con un sorriso nella voce” (pp.11-12) in urla, insulti, bestemmie, suppliche indecenti e umilianti: “Non avrei dovuto lasciarti soffrire come un vecchio leone solitario, sbranato vivo dalle iene, con il dentro di fuori” (p. 11). Alfa è devastato dal rimorso:: “Se fossi diventato quello che sono adesso, ti avrei sgozzato come una pecora sacrificale, per amicizia. […] Non ho saputo recidere il filo spinato delle tue sofferenze” (p. 10 Non importa se Alfa ha compiuto un gesto di pietà universale: ha raccolto il cadavere dell’amico e lo ha riportato fra le linee dell’esercito francese: “Ho camminato a lungo nelle buche, portando in braccio Mademba pesante come un bambino addormentato. Bersaglio ignorato dai nemici, invischiato sotto la luce della luna piena sono arrivato al buco spalancato della nostra trincea. Avevo camminato sotto il chiaro di luna, stringendo Mademba, senza accorgermi che un lungo nastro del suo intestino era sfuggito al nodo della mia camicia che gli avevo stretto attorno alla vita. Quando hanno visto lo sfacelo umano che portavo in braccio, hanno detto che ero stato forte e coraggioso. Hanno detto che loro non ce l’avrebbero fatta. Che forse avrebbero abbandonato Mademba Diop ai topi, che non avrebbero avuto il coraggio di raccogliere religiosamente le sue viscere nel sacro vaso del suo corpo. Hanno detto che non l’avrebbero portato per un tratto così lungo con quello splendido chiaro di luna sotto gli occhi dei nemici. Hanno detto che meritavo una medaglia, che avrei avuto la croce di guerra, che la mia famiglia sarebbe stata fiera di me, che Mademba che mi guardava dal cielo sarebbe stato fiero di me”(pp. 15-16). La conclusione amara è che “davanti a te, Mademba, non sono stato capace di essere uomo” (p. 12).
Dalla tragedia alla follia
“Quello che non ho fatto per il mio amico, lo farò per il mio nemico. Per umanità” (p. 22) dichiara Alfa all’indomani della tragedia. La guerra moderna rende possibile l’indicibile, la più spaventosa delle vendette: dopo ogni attacco, come un divoratore di anime, come un dëmm (uno stregone) Alfa riporta in trincea un orribile trofeo, il fucile del nemico (l’arma che aveva colpito Mademba) e la mano che l’ha stretto, pulito, oliato, caricato, scaricato e ricaricato. Alfa sceglie accuratamente la sua vittima fra i soldati tedeschi in base all’unica caratteristica che Mademba agonizzante era riuscito a ricordare di lui: «Per la verità di Dio, tutto quello che posso dirti è che ha gli occhi azzurri», aggiungendo subito dopo: «Dimentica il nemico dagli occhi azzurri. Ammazzami adesso perché sto soffrendo troppo. […] Lui ha avuto la sua opportunità, si è salvato. […] Se sei mio fratello, il mio amico d’infanzia, se sei quello che ho sempre conosciuto, che amo come amo mia madre e mio padre, ti supplico per la seconda volta di sgozzarmi” (p. 27). Alfa non potrà dimenticare e quello che non ha fatto per il suo “più che fratello” lo farà per otto nemici sventrati, uccisi e straziati secondo un rituale che riproduce le ultime ore di vita di Mademba. “Così è la guerra: quando Dio è in ritardo sulla musica degli uomini, quando non riesce a sciogliere i fili di troppi destini in un colpo solo” può accedere che, con la complicità silenziosa della luna e delle stelle, si uccida “per ritrovata umanità” (p. 29); può accadere che simili gesti suscitino prima ammirazione (“fino alla terza mano ero un eroe di guerra” p. 60), poi pragmatica preoccupazione per le conseguenze possibili. “Devi limitarti ad ammazzarli e a non mutilarli. La guerra civilizzata lo vieta” (p. 65) sbotta il capitano Armand prima di spedire Alfa nelle retrovie per riposare o forse, come sospetta Alfa, per liberarsi di lui: “Per il capitano la vita è la guerra. Il capitano ama la guerra come si ama una donna capricciosa. […]Lo so, l’ho capito che il capitano Armand avrebbe fatto tutto il possibile per continuare a fare l’amore con la guerra. Ho capito che mi prendeva per un rivale pericoloso che poteva rovinare tutto nel suo colloquio intimo con la guerra” (p. 66).
Il villaggio e la trincea: due mondi opposti
Nel romanzo ampie digressioni raccontano la vita del protagonista in Senegal, nel villaggio di Gandiol, prima di trasferirsi in Europa, nelle trincee del Fronte occidentale. Si tratta di pagine indimenticabili, dense di poesia, dominate da un’armonia perfetta, in cui le figure umane sono sospese in uno dimensione ancestrale e si definiscono nella relazione con la natura, attraverso metafore evocative e potenti. Ecco dunque le radici, ossia i genitori di Alfa: “Lui era immobile come un baobab, lei era figlia del vento. A volte i contrari si affascinano per quanto sono lontani l’uno dall’altro. Penndo Ba aveva finito per amare mio padre Bassirou Coumba Ndiaye perché era il suo esatto contrario. Lui era vecchio come un paesaggio immutabile, lei era giovane come un cielo mutevole”(p. 85). Ancora sulla figura del patriarca: “Mio padre è un soldato della vita quotidiana che è vissuto soltanto per preservare dalla fame le sue mogli e i suoi figli. Giorno dopo giorno, in quel fiume di tempo che è la vita, mio padre ci ha saziato dei frutti dei suoi campi e dei suoi frutteti. Quel vecchio di mio padre ci ha fatto crescere e diventare belli, noi che siamo la sua famiglia, come le piante di cui ci nutriva. Era un coltivatore di alberi e di frutti, era un coltivatore di figli. Noi crescevamo dritti e forti come i semi che lui piantava nella terra leggera dei campi” (p. 102). E dopo celebrato i genitori, Alfa scopre anche l’amore per una donna, che si dà a lui prima della partenza, perché “ha capito che la Francia mi avrebbe portato via da lei, sia che fossi morto, sia che restassi in vita” (p. 99): “Fary non era la più bella ragazza della mia età, ma era quella che aveva un sorriso che mi scombussolava il cuore. Fary era molto, molto commovente. Fary aveva la voce dolce come lo sciabordio del fiume solcato dalle piroghe nelle mattine di pesca silenziosa. Il sorriso di Fary era un’aurora, il suo sedere era tondo come le dune del deserto di Lompoul. Fary aveva gli occhi da cerbiatta e al tempo stesso da leone. A volte tornado di terra, a volte oceano di tranquillità. Per la verità di Dio, per ottenere l’amore di Fary avrei potuto perdere l’amicizia di Mademba. Per fortuna Fary ha scelto me anziché Mademba. Per fortuna il mio più che fratello si è fatto da parte. È stato perché Fary mi ha scelto di fronte a tutti che Mademba ha desistito” (p. 77). Davvero di grande suggestione è lo scenario naturale che accoglie gli amori di Alfa e Fary in una notte di plenilunio: la luna, complice degli amanti, lascia che il suo chiarore sia momentaneamente oscurato dagli ebani fitti di un bosco perché i due giovani si amino; allo stesso modo la luna, che illumina le trincee, che assiste l’agonia dell’amico Mademba, protegge Alfa nelle sue spedizioni di sangue, nascondendosi per dissimularlo agli occhi dei nemici.
Lo stile “esotico” e il respiro epico
I segmenti testuali presi dal romanzo sopra riportati testimoniano di un’etica della forma come elemento sostanziale, necessario per la costruzione di senso dell’opera. Similitudini, riprese anaforiche, epiteti, formule ricorrenti e andamento paratattico sono segni caratteristici di una matrice epica che la cultura tribale di tradizione orale dei protagonisti giustifica. Un’operazione di mimesi suggestiva e coerente con la scelta del punto di vista interno, ad un primo superficiale sguardo. Interrogandomi tuttavia sulle ragioni profonde dello scarto linguistico che immediatamente avvolge il lettore, mi ha soccorsa l’autorità ermeneutica del primo trattato di estetica e di teoria della letteratura: in un passo della sua Poetica, nel capitolo dedicato al linguaggio poetico[1], Aristotele ritiene che la virtù di esso risieda nella deroga dalla norma attraverso la categoria dell’esotico (xenikón, “straniero” letteralmente, è l’aggettivo che ricorre nel testo greco, con riferimento a glosse e traslati in particolare), al quale si accompagna l’eccezionalità dell’azione. Se l’uso maldestro di traslati e glosse, sempre secondo Aristotele, produce rispettivamente sgradevoli enigmi e grossolani “barbarismi” (del resto i Greci non volevano condividere nulla della cultura, ritenuta inferiore, dei barbari, mentre con gli stranieri stabilivano relazioni di amicizia e di ospitalità), l’introduzione di ciò che è estraneo si qualifica come “solenne” elemento di distinzione. Aristotele sta parlando di straniamento (“glossa è quella parola adoperata da altra gente; è chiaro per conseguenza che la stessa parola può esser sia normale sia glossa, ma non per le stesse persone”) e Diop interpreta magistralmente tale artificio, uno dei più preziosi che la letteratura abbia a sua disposizione. Il rovesciamento della prospettiva, la strategia di allontanamento dalla familiarità, nelle forme così come nelle situazioni che quelle forme definiscono, apre nuovi mondi, costringe ad abitare realtà impensate, a mettere in discussione tutte le consolidate opinioni circa fatti, valori, sentimenti, atteggiamenti. Non si resta uguali dopo aver letto Fratelli d’anima e l’inquietudine, le domande senza risposta con cui torniamo alla nostra routine sono lieviti che consentono alla nostra indagine sulla condizione umana di fermentare.
Letteratura, non storiografia
Sarebbe un errore grave enfatizzare il dato storiografico da cui prende le mosse la narrazione di Fratelli d’anima, ossia lo sguardo obliquo posato su opacità, omissioni, cicatrici e marginalità della storia: certamente la letteratura custodisce nella penombra delle opere le tracce dei dimenticati dando loro quella certificazione di esistenza che solo la letteratura sa dare[2]. In questo senso va certamente interpretato l’episodio dell’ammutinamento di un gruppo di soldati francesi che si rifiutano di ubbidire al fischietto di morte del capitano Armand e, con l’accusa di tradimento, sono costretti a uscire allo scoperto per offrirsi facile bersaglio ai colpi del nemico: la denuncia di questa meschina alternativa alla ben nota pratica della decimazione è affidata alle parole di un cioccolatino dell’Africa nera, Alfa, che ha visto morire da eroe Alphonse in una guerra in cui “quando si ha un problema con uno dei propri soldati, lo si fa ammazzare dal nemico. È più pratico” (p. 61). Tuttavia assegnare questa narrazione alla categoria del romanzo neostorico o del romanzo postcoloniale rischia di depotenziare il messaggio universale. Diop non usa la letteratura come vendetta alla ricerca del riscatto, della riabilitazione, come denuncia di ingiustizie passate che proiettano la loro ombra sul presente e fanno emergere nodi irrisolti nei rapporti fra culture. Non usa la letteratura nemmeno come forma di resistenza e veicolo di controvalori. Non persegue l’obiettivo di illuminare vite sommerse: la microstoria impone un punto di vista situato grazie alla precisione degli elementi di contesto e alla dialettica continua tra particolare e generale, mentre nel romanzo di Diop le categorie di spazio e tempo sono quelle tipiche dell’epica: una distanza temporale assoluta e l’indeterminatezza dei luoghi.
Dentro e fuori
Una spia linguistica (ancora una prova della raffinatezza delle scelte formali) offre una possibile chiave interpretativa del romanzo: fin dalle prime pagine l’accostamento dei termini antitetici “dentro” e “fuori” (”dedans/dehors” nella lingua originale, che restituisce anche un di più di significato attraverso la musica delle parole) ricorre insistentemente, in senso proprio e in senso figurato, in particolare quando questioni ultime e decisive, riguardanti la vita e la morte, si stagliano nitide sul fondale della storia e superano il rumore di fondo della contingenza. “Lui, Mademba, non era ancora morto e aveva già il dentro del corpo di fuori.” (p.10); oppure: “Il dentro della terra era di fuori, il dentro della mia mente era di fuori, e ho saputo, ho capito che potevo pensare tutto quello che volevo a patto che gli altri non ne sapessero nulla. Allora ho chiuso i miei pensieri all’interno della testa, dopo averli osservati molto da vicino. Strani.” (p. 15); o ancora
“Solo quando è morto Mademba la mia mente si è aperta per lasciarmi osservare che cosa si nascondeva dentro” (p. 94). Il protagonista Alfa sperimenta quanto sia poroso, fallace il confine tra il bene e il male, perché “ogni cosa è duplice: ha una faccia buona e una cattiva. […] Per la verità di Dio ogni cosa ha dentro di sé il suo contrario. […] Per la verità di Dio, così vanno le cose, così va il mondo: ogni cosa è duplice” (p. 59-60). Ognuno ha in sé il cielo e l’inferno, il giorno e la notte, la luce e le tenebre, la morte e la vita: chi compie il male spesso non è un mostro, ma un uomo terribilmente, spaventosamente “normale”, abitato da contraddizioni profonde che la civiltà e la storia fanno affiorare e portano allo scoperto, sconvolgendo i rapporti consolidati e gli equilibri fra quello che abbiamo dentro e quello che accade fuori. Così gli incubi peggiori possono diventare realtà.
[1] Aristotele, Poetica 58a.
[2] Combino liberamente espressioni di Hans Magnus Enzensberger (Letteratura come storiografia, “Il menabò”, 9, luglio 1966, p. 7 ss.) e di Leonardo Sciascia (ora in Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero la felicità di far libri, Sellerio, Palermo 2019).
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento