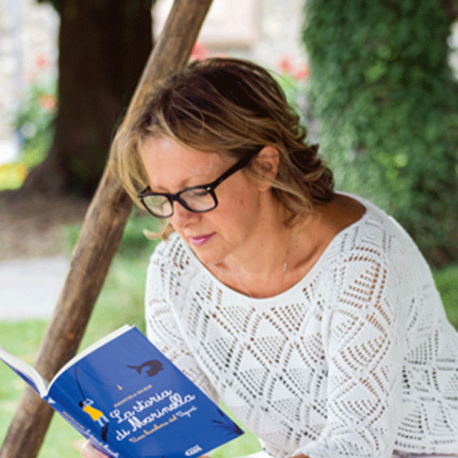
Letteratura per giovani adulti /3. Intervista a Emanuela Da Ros
a cura di Morena Marsilio
1) Quando ha iniziato a scrivere narrativa destinata ai ragazzi e quale è stata la molla che l’ha spinta a scegliere proprio i giovani come destinatari privilegiati dei suoi testi?
Poco prima del 2000 (l’amico Andrea Zanzotto diceva che era ‘l’anno con le rotelle’ e che mi avrebbe portato fortuna) ho inviato al Premio Pippi un testo inedito, che avevo scritto per gioco o – parafrasando il titolo di una commedia di Natalia Ginzburg – “per allegria”. Si trattava del Giornalino Larry. Oltre a fare l’insegnante, avevo iniziato a dedicarmi al giornalismo, e – nel frattempo – facevo la mamma: il mio salotto era una redazione-sala-giochi. Un gran caos, a pensarci. Eppure in quella bagarre mi è venuta l’idea di scrivere una storia, dedicata ai bambini, in cui immaginavo che fossero loro a fare i giornalisti, a scrivere ciò che accadeva nel condominio Larry (che era il posto in cui passavano i pomeriggi). Quel testo – e per me è stato un evento magico – ha vinto il Premio Pippi, è stato pubblicato con Feltrinelli in Italia, e poi da un editore tedesco.
È stato l’inizio di un’avventura ‘preparata’ dalla lettura di tanti libri – soprattutto umoristici – scoperti anche grazie ai suggerimenti di Carla Poesio, che avevo avuto la fortuna di ascoltare durante un corso (per docenti) dedicato alla letteratura per ragazzi.
2) Quali sono i temi più ricorrenti nella sua narrativa e a quale bisogno comunicativo rispondono?
I temi sono diversi. Nascono da urgenze diverse, che a volte sorprendono anche me. Credo di aver spesso centrato le trame sui valori che stanno proprio alla base della vita quotidiana: l’amicizia, l’amore, l’importanza di comunicare coi coetanei, ma anche con gli adulti (obiettivo tutt’altro che raggiunto!), il rispetto (di sé, degli altri, del territorio).
3) Ritiene che sia cambiato il modo in cui la sua generazione ha vissuto l’adolescenza e quello in cui la affrontano i giovani di oggi?
L’adolescenza resta un passaggio (lunghissimo, interminabile…finisce davvero?) che fa annaspare in inquietudini profonde, laceranti a volte. Ciascuno di noi l’affronta come può. Non credo ci sia una strategia che vada bene per tutti. Comunque – immagino di dire delle ovvietà – i ragazzi oggi sono ancora più fragili di quanto non lo fossi io. Sono più disorientati. Hanno le stesse perplessità o incertezze o paure che avevo io alla loro età, ma in qualche modo queste sono amplificate dallo sgretolamento di valori, sicurezze, obiettivi positivi, sogni condivisi.
4) Quali sono state le letture che l’hanno “formata” e quali sono, oggi, i modelli letterari cui si rifà?
Natalia Ginzburg e soprattutto il suo Lessico famigliare sono stati i miei fari. Soprattutto per quanto riguarda lo stile narrativo, anche se Natalia resta un modello irraggiungibile, e unico.
Sono una lettrice onnivora: amo le commedie brillanti, i testi teatrali (classici, soprattutto inglesi: Pigmalione di George Bernard Shaw, o Oscar Wilde…), i gialli (Simenon è un genio), i thriller di Stephen King, la poesia in prosa di Italo Calvino, la profonda lezione civile, storica, umana di Primo Levi, la fantasia di Roald Dhal, la felice narrativa irriverente di Astrid Lindgren…L’elenco dei ‘modelli’ sarebbe troppo lungo…
5) La disaffezione dei giovani nei confronti della lettura è sempre più diffusa: quali pensa possano essere sono le ragioni principali e come le agenzie educative potrebbero operare per remare controcorrente?
È una domanda importante. Fondamentale. A cui è difficile dare una risposta. Propositiva. La disaffezione dei giovani nei confronti della lettura è probabilmente (anche) la conseguenza della disaffezione degli adulti verso i libri. Mi risulta che i giovani, almeno fino ai 18, leggano molto più dei grandi. Perché sollecitati dagli insegnanti o da coetanei che trasmettono loro emozioni legate a certi libri, romanzi, pagine scoperte per caso. Una volta che prendono il largo da un universo come quello della scuola, che con i suoi evidenti difetti, ha ancora il pregio di veicolare alcune strategie formative attraverso i libri, i ragazzi continuano a leggere se trovano a casa sollecitazioni altrettanto vivaci, o se – nel frattempo – hanno scoperto il piacere irrinunciabile della lettura.
È chiaro però che i ragazzi si allontano dalla lettura tradizionale anche perché stimolati da altre forme di comunicazione: fotografia, musica, cinema… di cui fruiscono spesso contemporaneamente, pressoché ovunque, anche negli spazi e nei tempi che fino a qualche anno fa potevano apparire tanto vuoti da giustificare, desiderare, meritare di dare ospitalità a un libro.
Come far recuperare l’abitudine (perché di questo si tratta) alla lettura? Creando il bisogno, la necessità del leggere. Come percorso avventuroso, stimolante, sorprendente, intenso, divertente verso esperienze autentiche, vivide, altre da quelle consuete, prevedibili, o imposte. E per creare questo bisogno, sarebbe necessario mettere a disposizione, con grande libertà ma anche ammiccamenti, il variegato menù di letture che certo non mancano. Attraverso biblioteche fornite, comode, colorate. Luoghi di rifugio, aggregazione, divertimento. Biblioteche che si trovano in qualche comune, ma che non vengono frequentate come dovrebbero, biblioteche che in alcune scuole sono delle appendici accessorie e che a causa delle solite, invadenti, regole e limitazioni vengono visitate sporadicamente.
6) La scuola resta un importante baluardo per cercare di innescare un circolo virtuoso tra giovani e lettura, soprattutto facendo leva su quello spazio, insieme periferico e centrale, di libertà costituito dalle letture personali assegnate nel corso dell’anno scolastico. È in questo ambito, inoltre, si potrebbe utilmente mettere in contatto i ragazzi con la narrativa dell’estremo contemporaneo. Potrebbe indicare tre romanzi o raccolte di racconti italiani o stranieri degli ultimi vent’anni, a suo parere irrinunciabili, che proporrebbe in lettura ad adolescenti tra i 16 e i 18 anni?
Ultimi vent’anni? È una richiesta ardua. Sarei tentata di non rispondere. Ma mi vengono in mente: Jack Frusciante è uscito dal gruppo, di Enrico Brizzi (ha 24 anni!); La luna è dei lupi, di Giuseppe Festa; Stanotte guardiamo le stelle di Alì Ehsani.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento