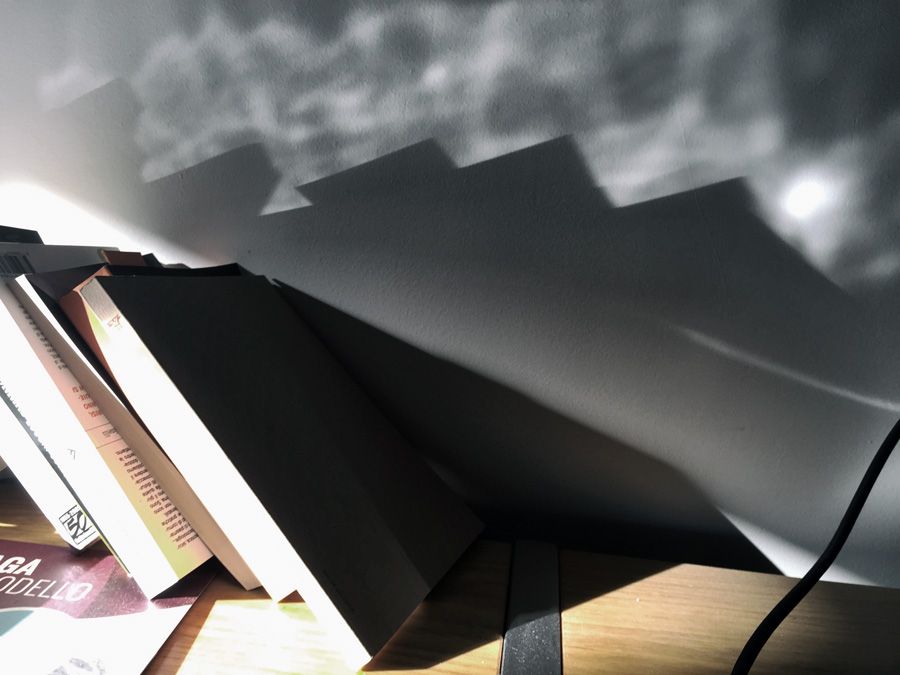
Sul bisogno di pensare la scuola. Il dibattito per l’Appello sulla scuola pubblica/4
In un testo ricco e articolato come l’appello per la scuola pubblica, si possono trovare buone ragioni per aderire o, al contrario, per dissentire. La stessa forma sintetica dell’appello spinge talvolta ad un accordo/ disaccordo poco razionale, quasi emotivo. Analizzando le idee esposte nei “7 temi” che ne costituiscono l’ossatura, ho incontrato quindi passaggi che mi hanno subito convinto, ed altri che mi hanno lasciato (e mi lasciano tuttora) perplesso.
Se ho deciso di firmare è stato soprattutto per la cornice entro la quale gli estensori dell’appello collocano questi temi, cioè per le opinioni espresse nella premessa e nelle richieste conclusive.
La premessa contiene tre elementi indispensabili alla costruzione di un’opinione pubblica consapevole (non solo nello specifico scolastico): una posizione conflittuale rispetto alla direzione in cui la scuola si sta muovendo da anni; la proposta di condividere alcuni valori di fondo; l’esigenza di allargare e qualificare il dibattito.
Questa premessa riceve uno sviluppo coerente nei temi che vengono esposti successivamente, di cui si possono misurare l’importanza culturale e la forza ideale delle proposte e delle provocazioni che veicolano.
Ad esempio, è vero che la contrapposizione netta fra conoscenze e competenze può apparire semplicistica, ma l’accezione in cui il termine “conoscenza” viene usato nell’appello è ben altra cosa rispetto al nozionismo. Riflette piuttosto l’idea forte espressa nel libro La scuola impossibile da Giulio Ferroni sul “corpo e i contenuti delle discipline” come “materialità del sapere”, imprescindibile e fondativa in un percorso formativo. In questa prospettiva, la critica che i redattori muovono alle competenze va nella stessa direzione in cui andiamo noi didattinauti nelle nostre ricerche e nelle nostre azioni: superare il modello trasmissivo tradizionale, facendo della “competenza” non un semplice orpello metodologico, ma una parte attiva e sostanziale del processo di apprendimento, in un costante e vitale rapporto dialettico con le conoscenze.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare, in relazione a ciascuno dei temi portanti che gli autori individuano: dunque la lettura non lascia indifferenti; provoca e scuote nel profondo le nostre convinzioni e le nostre pratiche, con onestà e rigore. Addirittura, mi sembra che questo sia il suo scopo principale: sollevare una discussione, non cercare facili convergenze generiche.
In tempi di burocrazia e di conformismo intellettuale, questo mi sembra di per sé un bel risultato.
Lo stesso accordo profondo ho sentito con le richieste che concludono l’appello: sono infatti domande di puro buon senso, lontanissime da una visione apocalittica e negativa, tanto dell’istituzione quanto di chi ci lavora.
In sostanza, si chiede un rallentamento di alcuni processi che sono stati avviati in modo ideologico ed acritico, come dimostrano ampiamente le difficoltà incontrate nella loro attuazione e il continuo intervento per mascherarle: l’indistinta introduzione di percorsi di alternanza e il loro peso come requisito per l’esame di stato; l’insegnamento in lingua inglese di materie in cui molti studenti faticano a comprendere testi e concetti in italiano; la semplificazione/ unificazione dei processi valutativi, in nome di quello che molti pedagogisti (in modo particolarmente chiaro Mario Castoldi nel suo libro Valutare a scuola ) definiscono “mito della valutazione oggettiva”.
Se torniamo al binomio conoscenze/ competenze, è evidente lo scollamento fra le pratiche valutative proposte nello stile Invalsi, indirizzate a misurare il rispetto di norme e l’uniformità di pensiero su alcune operazioni linguistiche e logiche, da una parte; e dall’altra la complessità delle competenze, la cui più chiara manifestazione è l’ideazione di soluzioni nuove ed impreviste, caratterizzate da una forte soggettività, di fronte ad un problema mai incontrato.
Non è forse ragionevole, allora, interrogarsi a fondo sull’introduzione di un test nazionale come requisito per la validità dell’Esame di Stato, e sulla somma ipocrisia di una valutazione che non fa parte del voto, ma lo affianca, con un valore accessorio ma anche essenziale?
Dunque il cuore dell’appello non risiede in richieste radicali di cancellazione e modifica, ma in un invito a rallentare per riflettere.
Forse per questo l’ho firmato: perché da anni ho l’impressione che chi gestisce la scuola non pensi tanto a quale direzione prendere, a dove vuole arrivare, ma semplicemente a fare presto.
____________________
NOTE
Fotografia di G. Biscardi, Libri, Palermo 2017
{loadmodule mod_custom,Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento