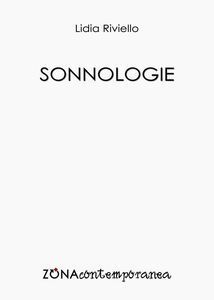
Una poesia laminare Su Sonnologie di Lidia Riviello
È arrivato a una certa distanza dal poema, questo Sonnologie di Lidia Riviello (Zona, 2016), e dopo una lunga e laboriosa gestazione. A otto anni dal poematico Neon 80 (Zona, 2008), questa nuova poesia gravita piuttosto nella zona dell’epigramma, dell’iscrizione su lastra, del cut up. Tuttavia lo spazio poematico, «taggato alle spalle», ne è il punto di partenza e, in un certo senso, anche d’arrivo, come una materia che, sottoposta a tagli e deformazioni, si ripresenti nella forma di lamine resilienti.
I singoli versi e le brevi strofe, disposte spesso a scalare, si collocano sulla pagina come lastre che scivolano l’una sull’altra, si toccano o si allontanano (anche per via di non casuali riprese a distanza di versi o sintagmi), disegnando mutanti forme geometriche in un movimento continuo sulla «superficie di un conflitto» (il sonno), specie di corpi solidi affioranti su una materia liquida, iscrizioni di una collettività ridotta a massa informe di sonnambuli eterodiretti «senza conducente», come la macchina progettata da Sebastian Thrun che è in scena (in senso anche teatrale) nella seconda delle tre sezioni del libro.
«Una volta e per sempre fuori dalla lirica» (come si legge nella Nota di Emanuele Zinato), esclusa la centralità dell’io come del tu senza però raggiungere la dimensione collettiva della prima persona plurale né una stabile terza persona, ma sempre oscillando tra le diverse persone grammaticali, questa poesia riesce a dare voce a un’identità indeterminata, a un’umanità ridotta in uno stato indistinto – perché la distinzione è saltata – tra sonno e veglia, ovvero condannata a una veglia permanente e privata di quella risorsa indispensabile che è il sonno, inteso come baluardo della libertà e dell’utopia nell’epoca in cui produzione e consumo occupano per intero il tempo di vita.
È cruciale, come in molta poesia recente (mi viene in mente, tra gli altri, Nel nosocomio di Rosaria Lo Russo), l’attenzione per i luoghi, o meglio i non luoghi: l’«istituto», ambiguo spazio di «addestramento al sonno» che «lascia accese le vetrate» per i suoi «utenti»/«clienti», e la metropolitana, «cavità» notturna dominata dalla «parata dei passeggeri da un tunnel all’altro» e dall’«assenza dell’uomo» «dentro la cabina di guida» di una macchina «senza conducente», una scena che esclude progressivamente l’umano («siamo noi lo spazio / fuori campo»).
Nel montaggio dei singoli testi Riviello ricorre spesso a un’ottica mobile che da una visione d’insieme si sposta su un particolare («questa specie di sonno», «questo trattato»), dove il deittico fa da àncora tanto alle «barche» in cui possono permettersi «un sonno per intero» quanto al controllo del sonno («di questo sonno conservano molte versioni hd, / la programmazione in sala, l’esaltazione dell’insonnia»).
L’ambiguità, costitutiva di ogni poesia, è qui elevata potentemente al quadrato, a significare una situazione in cui i due poli di ogni dialettica si schiacciano l’uno sull’altro, in un perenne «equivoco fra prospettiva e orizzonte d’attesa» e in cui, con la metamorfosi dell’identità, è in movimento e in ridefinizione il linguaggio. Ecco, allora, che dove «il sonno non è assicurato» «il cliente teme un colpo di sonno» e «nell’insonnia, qui nella posa / la post produzione esalta la specie»; d’altra parte – conclude un testo della seconda parte – «se ne vadano al museo la dialettica / e la trattativa di sebastian thrun».
Se il tempo della «posa», intesa come riposo, è aggredito dalla «velocità commerciale», privato della sua funzione naturale, occupato da una «mercanzia onirica» che non lascia scampo, questa poesia di lamine resilienti fa dell’anfibologia e dell’incidente linguistico uno strumento per provare a riformulare lo spazio dell’utopia «sulle superfici di un conflitto»: «si dorme ancora nel mondo».
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento