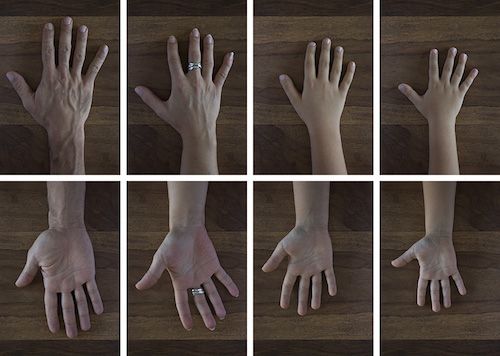
Alice Munro, in memoriam /3. Il perdono in famiglia
Oggi è morta Alice Munro. La ricordiamo con tre traduzioni di Valentina Fedi pubblicate nel 2017 sul nostro blog. Qui la terza.
Traduzione e introduzione di Valentina Fedi
Something I’ve been meaning to tell you è la seconda raccolta di Alice Munro. Dopo essere stati a lungo ingiustamente sottovalutati, questi racconti sono disponibili in lingua italiana da novembre 2016 con il titolo Una cosa che volevo dirti da un po’ e traduzione di Susanna Basso.
Il mio progetto di traduzione nasce otto anni fa e si concentra su tre dei tredici racconti che fanno parte della raccolta: Qualcosa che ho sempre avuto intenzione di dirti, Il perdono in famiglia e Dimmi sì o no. Questa traduzione vuole rispettare la personalità e lo stile dell’autrice attraverso una trasposizione fedele, che riesca a trasmettere in italiano l’immediatezza lessicale e la potenza narrativa dell’originale.
Tre storie, tre protagoniste: integerrime, fragili, tenere, spietate.
Il perdono in famiglia
Ho sempre pensato che se fossi andata da uno psichiatra ovviamente mi avrebbe chiesto della mia famiglia, così avrei iniziato a parlargli di mio fratello e di sicuro mi avrebbe fatta internare ancora prima che finissi di parlare.
Lo dissi a mia Madre; si mise a ridere. «Sei troppo severa con quel ragazzo, Val».
«Ragazzo», dissi io. «Uomo».
Rise di nuovo e poi mi diede ragione: «Ma ricorda», aggiunse, «il Signore ama anche i folli».
«E tu come lo sai?» Risposi io. «Visto che sei atea?»
C’erano alcune cose per le quali mio fratello non aveva colpa. Essere nato, per esempio. Nacque la settimana in cui iniziai la scuola, non è tempismo questo? Ero spaventata, a quel tempo non era come adesso, i bambini non venivano mandati prima al nido e poi all’asilo. Andavo a scuola per la prima volta, tutti gli altri ragazzini erano insieme alla loro madre e la mia dov’era? In ospedale a partorire. Per me fu imbarazzante. C’era molto pudore riguardo a questo genere di cose a quel tempo.
Non è stata colpa sua nascere e nemmeno vomitare al mio matrimonio. Pensaci, Val. Il pavimento, il tavolo, riuscì a prendere persino la torta. Non era ubriaco – come credettero tutti – gli era veramente venuto un violento attacco di influenza, che prendemmo anche io e Haro, in effetti, durante la nostra luna di miele. Non ho mai sentito di qualcuno che a causa dell’influenza avesse vomitato su un tavolo con sopra una tovaglia di pizzo, dei candelabri d’argento e una torta nuziale, ma si potrebbe dare la colpa alla sfortuna; forse tutti gli altri si sarebbero trovati più vicino a un bagno nel momento del bisogno. Probabilmente avrebbero anche tentato di trattenersi un po’ di più, ci avrebbero almeno provato, gli altri, perché nessun altro si sente così speciale, così centro dell’universo come mio fratello minore. Chiamatelo semplicemente “figlio della natura”. Fu lui stesso, in seguito, a farsi chiamare così.
Sorvolerò su quello che combinò tra il giorno della sua nascita e quello in cui vomitò al mio matrimonio, ma non posso trattenermi dal raccontare che gli venne l’asma e che rimase a casa senza andare a scuola per settimane intere, ad ascoltare soap opera. Ogni tanto tra noi c’era una specie di tregua: lasciavo che mi raccontasse quello che succedeva ogni giorno in Big Sister e Road of life e anche nella soap con Gee-Gee e Papa Davis. Era molto bravo nel ricordarsi i nomi di tutti i personaggi e nel venire a capo dei loro intrighi, questo lo ammetto; imparò anche un sacco di cose leggendo Gateways to Bookland, quell’adorabile set di libri che Madre ci aveva comprato e che lui più avanti fece sparire di casa e vendette, per dieci dollari, a un rivenditore di libri di seconda mano. Madre diceva che, se avesse voluto, avrebbe potuto essere bravissimo a scuola. È un’acqua cheta tuo fratello, diceva sempre, ha delle sorprese in serbo per noi. Aveva ragione, ce le aveva.
Iniziò a stare a casa stabilmente durante il secondo anno di superiori dopo aver avuto un piccolo problema: era stato scoperto, insieme a una banda di altri teppistelli, a rubare test di matematica della cattedra di una professoressa. Uno dei bidelli aveva lasciato tornare in classe mio fratello dopo la scuola, era riuscito a convincerlo inventandogli di dover lavorare a un progetto speciale. Ed era così, in un certo senso. Madre disse che lo aveva fatto per acquistare popolarità, perché a causa dell’asma non aveva potuto praticare nessuno sport.
Bene. Il lavoro. La domanda è: una persona come mio fratello – penso di dovergli dare almeno un nome, si chiama Cam, da Cameron, Madre credeva che sarebbe stato un nome adatto a un preside universitario o a una personalità rispettabile (secondo i suoi piani sarebbe stato questo il suo futuro) – che cosa farà, come si guadagnerà da vivere? Fino a prova contraria lo Stato non ti pagava per stare con le mani in mano a fare “il creativo”. Trovò lavoro prima come maschera in un cinema. Fu Madre a trovargli quell’impiego, conosceva il dirigente del posto, il vecchio International Theater, in fondo a Blake street. Tuttavia, dovette smettere a causa della sua fobia del buio. Tutte quelle persone sedute nell’oscurità, diceva, gli facevano accapponare la pelle, reazione alquanto bizzarra. Questa sua paura gli causava disagio solo se doveva lavorare come maschera, non era un problema quando andava al cinema per conto suo. Amava molto vedere i film. In effetti, passava intere giornate seduto nei cinematografi, si sorbiva ogni spettacolo due volte, per poi andare in un altro cinema e vedere quelli che erano in programmazione lì. Del resto doveva pur impiegare il tempo in qualche modo: allora eravamo tutti convinti che stesse lavorando nell’ufficio della rimessa di autobus Greyhound. Andava al lavoro alla stessa ora ogni mattina e tornava a casa sempre alla stessa ora ogni sera, raccontava a tutti del signore mezzo matto responsabile dell’ufficio e della donna con la scoliosi che era lì dal 1919, e di quanto la facevano diventare matta le ragazzine che masticavano i chewing gum. Oh, una storia avvincente, avrebbe potuto inventarsi qualcosa al pari di una soap opera se Madre non avesse telefonato per lamentarsi del fatto che stessero trattenendo il suo assegno di paga – a causa di un errore tecnico su come era stato scritto il suo nome, aveva detto Cam – e avesse scoperto che aveva lasciato il lavoro nel bel mezzo del suo secondo giorno.
Bene. Era meglio che passasse le giornate al cinema piuttosto che in birreria, disse Madre. Perlomeno non se ne stava in mezzo alla strada a contatto con bande criminali. Gli chiese qual era il suo film preferito e lui rispose: Sette spose per Sette Fratelli. Vedi, esclamò lei, gli piace la vita all’aria aperta, non è adatto a un lavoro d’ufficio. Così lo mandò a lavorare per alcuni suoi cugini che avevano una fattoria nella Fraser Valley. Dovrei chiarire che mio padre, mio e di Cam, a quel tempo era già morto, era successo molto tempo prima, quando mio fratello soffriva di asma e ascoltava le soap opera. Questo fatto, la sua morte, non apportò grandi cambiamenti alla nostra vita, papà lavorava come capotreno sulla P.G.E. quando ancora i treni partivano da Squamish, e viveva per la maggior parte del tempo a Lillooet. Non era cambiato niente: Madre continuava ad andare al lavoro da Eaton’s, arrivava dall’altra parte della baia con il traghetto e poi prendeva l’autobus; io preparavo la cena, lei tornava a casa arrancando su per la collina nelle buie serate invernali.
Cam se ne andò dalla fattoria, si lamentò del fatto che i cugini fossero religiosi e stessero sempre a infastidirlo parlandogli della cura della sua anima. Madre poteva capire il suo problema, dopo tutto lo aveva educato affinché fosse un libero pensatore. Si mise a fare l’autostop per andare a Est. Di tanto in tanto arrivava una lettera. Una richiesta di denaro. Gli era stato offerto un lavoro nel nord del Quebec, ma doveva riuscire a mettere insieme i soldi per arrivarci. Madre glieli spedì. Cam inviò un messaggio per dire che il lavoro era saltato, ma non rimandò indietro i soldi. Lui e due suoi amici stavano per aprire un allevamento di tacchini. Ci inviarono i progetti e i preventivi. Avrebbero dovuto lavorare in collaborazione con la Purina Company, niente sarebbe potuto andare storto. I tacchini morirono in un allagamento, ovviamente dopo l’invio di denaro di Madre; gli avevamo spedito dei soldi anche noi, pur contro ogni buonsenso. Tutti i posti in cui mette piede quel ragazzo si trasformano in una zona disastrata, disse Madre. Se tutto quello che gli è capitato lo leggessi in un libro non ci crederesti, ribadì. È così assurdo da essere divertente. Lei conosceva la mia situazione. Di solito andavo a trovarla il mercoledì pomeriggio – il suo giorno libero – spingevo il passeggino con dentro Karen, e poi, con lei già grande da potermi camminare accanto, con dentro Tommy. Camminavamo fino a Lonsdale e poi tornavamo indietro passando per King’s road. E qual era l’argomento di cui finivamo sempre per parlare? Me e mio fratello. Stavamo divorziando, diceva lei. Ho intenzione di cancellarlo completamente dalla mia vita, rispondevo io.
Che cosa ci avrei guadagnato se Cam avesse smesso di contare su di me, mi chiedeva. Io evitavo di ribattere, più o meno. Madre sapeva come la pensavo. Ma ogni volta finiva per dire «Comunque, era un bravo ragazzo da avere in giro per casa. Una buona compagnia. Riusciva sempre a farmi ridere».
Oppure diceva «Ha dovuto affrontare molti problemi: l’asma, l’essere rimasto senza padre. Non ha mai ferito nessuno intenzionalmente».
«Una cosa buona l’ha fatta», continuava «puoi veramente considerarla una buona azione. Quella ragazza».
Si riferiva alla giovane donna che arrivò per metterci al corrente che si era fidanzata con lui, ad Hamilton, nell’Ontario, almeno fino a quando Cam non le fece sapere che non avrebbe mai potuto sposarla, non dopo aver scoperto della malattia ereditaria ai reni di cui soffrivano i membri della nostra famiglia. Le aveva scritto una lettera. E lei era venuta per dirgli che non le importava. Non era per niente brutta. Lavorava per la Bell Telephone. Madre disse che fu una bugia detta a fin di bene, per proteggere i suoi sentimenti e non dirle che non voleva più sposarla. Risposi che le aveva fatto un piacere comunque, visto che in caso contrario avrebbe dovuto sopportarlo per il resto della sua vita.
In realtà, questo a noi avrebbe facilitato le cose.
Ma il passato è passato, questo è il presente e come tutti sappiamo i tempi sono cambiati. Per Cam adesso la situazione è più semplice. Vive a casa, quando sì quando no, da un anno e mezzo. I suoi capelli sono radi sulla fronte, il che non è sorprendente per un uomo di trentaquattro anni, ma dietro sono lunghi fino alle spalle, scompigliati, ingrigiti. Indossa sempre una specie di grezza tunica marrone che sembra ricavata da un sacco di iuta (dovrebbe essere una specie di saio penitenziale – dissi ad Haro – non mi dispiacerebbe passargli la cenere con cui cospargersi il capo); appesi ai polsi ha catene, medaglioni, croci, denti di alce e quant’altro. Ai piedi porta dei sandali di corda. Li ha fatti uno dei suoi amici. Riscuote un sussidio. Nessuno gli chiede di lavorare. Chi potrebbe essere così severo da farlo? Se deve mettere per iscritto da qualche parte la sua occupazione scrive “sacerdote”.
È la verità. C’è una vera e propria scuola formata da queste persone, si fanno chiamare sacerdoti e posseggono una casa oltre Kitsilano, anche Cam vive là ogni tanto. Sono in competizione con la congrega degli Hare Krishna, l’unica differenza è che loro non cantano: vanno solo in giro sorridendo. Ha sviluppato un tono di voce che non sopporto, molto lieve, dolce, monocorde. Mi fa venire voglia di andargli di fronte e urlargli «C’è un terremoto in Cile, duecento mila persone sono appena morte, hanno bruciato un altro villaggio in Vietnam, in India continua a esserci la carestia». Solamente per vedere se avrebbe continuato a dire «Mol-to be-ne, mol-to be-ne», con quella calma. Non mangia carne, ovviamente, solo cereali e verdure con le foglie. Una volta entrò in cucina mentre stavo affettando le barbabietole (ortaggio proibito in quanto verdura con le radici) «Spero tu sappia che in questo momento stai commettendo un omicidio», disse.
«No, non lo so» risposi, «ma ti darò sessanta secondi per andartene di qui o potrei commetterne uno sul serio».
Dunque, come ho già detto mio fratello adesso vive a casa periodicamente e si trovava lì il lunedì sera in cui Madre si sentì male. Stava vomitando. Un paio di giorni prima Cam le aveva fatto iniziare una dieta vegetariana – lei gli prometteva da sempre che prima o poi ci avrebbe provato – e le disse che vomitando stava espellendo tutti i vecchi veleni accumulatisi nel suo corpo per aver mangiato carne, zucchero e così via. Disse che era un buon segno, e che una volta vomitato tutto si sarebbe sentita meglio. Continuò a vomitare, e non si sentì meglio, ma lui doveva uscire. Il lunedì sera è il giorno dell’incontro settimanale alla casa dei sacerdoti, dove cantilenano le loro preghiere e bruciano incensi, potrebbero anche celebrare una messa nera, per quello che ne so. Rimase fuori per gran parte della notte e quando tornò a casa trovò Madre svenuta sul pavimento del bagno. Prese il telefono e mi chiamò.
«Penso che faresti meglio a venire qua e vedere se riesci ad aiutare Mamma, Val».
«Che problema ha?»
«Non si sente molto bene».
«Che cos’ha? Passamela».
«Non posso».
«Perché?»
Giuro che si mise a ridacchiare. «Beh, perché ho paura che sia svenuta».
Chiamai l’ambulanza e la mandai a prenderla, fu così che arrivò all’ospedale, alle cinque di mattina. Telefonai al suo medico, che andò all’ospedale con il Dottor Ellis Bell, uno degli migliori cardiologi della città; sembrava fosse stato questo il problema: il cuore. Mi vestii e svegliai Haro, gli raccontai che cosa era successo e poi guidai fino al Lions Gate Hospital. Non mi avrebbero lasciata entrare fino alle dieci. L’avevano ricoverata in terapia intensiva. Mi sedetti fuori dal reparto, nella pulitissima, piccola, orribile sala d’aspetto. C’erano delle sedie rosse e scivolose, coperte da un rivestimento di pessima qualità, e un vaso pieno di sassi con sopra una pianta finta. Rimasi seduta lì per ore e ore, lessi il «Reader’s Digest». La parte dedicata ai giochi. Pensavo: è così che sta andando, proprio così, sul serio, sta morendo. Adesso, in questo momento, dietro queste porte, sta morendo. Non c’è niente che possa fermarti o tenerti lontano dal credere in qualcosa quando per qualche ragione, anche se contro ogni tuo volere, sei sicuro che quel qualcosa avverrà. Mi misi a pensare alla vita di Madre, a quella che io conoscevo. Andava al lavoro tutti i giorni, prima in traghetto poi in autobus. Faceva la spesa al vecchio Red-and-White e poi, dopo la sua chiusura, al nuovo Safeway – nuovo per modo di dire, è aperto ormai da quindici anni! Scendeva giù alla biblioteca una sera a settimana e mi portava con sé, poi ce ne tornavamo a casa in autobus con il nostro carico di libri e una borsa piena d’uva comprata al negozio cinese, un piccolo regalo che ci facevamo. Ripensai anche ai mercoledì pomeriggio quando i miei bambini erano piccoli e io andavo da lei a bere il caffè e a come arrotolava le sigarette con quell’aggeggio che aveva.
Tutte queste cose non sembrano esattamente vita mentre le fai, sono solo gesti che ripeti, ciò con cui riempi le tue giornate, e mentre li fai continui a credere per tutto il tempo che qualcosa sta per rompersi e aprirsi, e che allora – solo allora ti ritroverai a vivere. Alla fine non desideri nemmeno particolarmente che questo accada, che avvenga questa rottura, come procedono le cose ti va abbastanza bene, ma continui comunque ad aspettarla. E così stai morendo, Madre sta morendo, eppure qua ci sono le stesse sedie di plastica e le stesse piante finte, fuori è un giorno come un altro in cui le persone vanno a fare acquisti in drogheria e tutto ciò che rimane è il ricordo di quello che è stato: andare in biblioteca – adesso ha valore anche solo una cosa come questa – tornare a casa su per la collina in autobus con i libri e la borsa piena di uva, O Dio non è così? Ti si spezzerebbe il cuore tanta è la voglia di rivivere quei momenti.
Quando mi lasciarono entrare per vederla il suo volto era di un colore tra il blu e il grigio e i suoi occhi non erano del tutto chiusi, si erano ribaltati, la fessura che era rimasta aperta lasciava intravederne il bianco. Aveva sempre avuto un pessimo aspetto con i denti in mostra, e comunque non ci avrebbe mai permesso di vederla in quel modo se fosse stata cosciente. Cam la prendeva in giro per la sua vanità. Adesso le si vedevano i denti. L’aveva sempre saputo, pensai, sin da quando era giovane, che prima o poi sarebbe apparsa così.
I medici dissero che non c’era speranza. Arrivò anche Haro, la guardò, poi mi mise un braccio intorno alle spalle e disse, «Val, dovrai essere preparata». Aveva buone intenzioni ma io non riuscivo a parlare con lui. Non era sua madre e non poteva ricordarsi niente di lei. Non era colpa sua ma io non volevo rivolgergli la parola, né volevo sentirmi dire che avrei dovuto prepararmi al peggio. Ci allontanammo dal reparto e andammo a mangiare qualcosa nella caffetteria dell’ospedale.
«Dovresti chiamare Cam», esordì Haro.
«Perché?»
«Vorrà sapere cosa sta succedendo».
«Perché? Credi che gli interessi? L’ha lasciata sola la scorsa notte e non è riuscito neanche a chiamare un’ambulanza quando è tornato a casa stamattina e l’ha trovata svenuta sul pavimento».
«Fa lo stesso. Lui ha il diritto di sapere. Forse dovresti dirgli di venire qua».
«Probabilmente adesso sarà impegnato a organizzarle un funerale hippie».
Ma Haro riuscì come sempre a convincermi e così andai a telefonargli. Nessuna risposta. Averlo chiamato mi fece sentire meglio, mi sentii giustificata per quello che avevo detto sulla sua assenza. Tornai indietro e aspettai, da sola.
Verso le sette di sera si presentò Cam. Non era solo. Si era portato dietro una tribù di compagni-sacerdoti – o almeno credo – dalla casa comune. Indossavano tutti lo stesso tipo di abito che aveva lui: quella specie di lunga camicia da notte – marrone come un sacco – e le catene, le croci e gli ammennicoli sacri, avevano i capelli lunghi ed erano tutti diversi anni più giovani di Cam eccetto che per un uomo anziano, molto anziano, con la barba grigia e riccioluta e i piedi scalzi – i piedi scalzi a marzo! – e neanche un dente. Quell’uomo non aveva la minima idea di che cosa stesse succedendo, lo giuro. Presumo che lo avessero prelevato direttamente dal Salvation Army e gli avessero messo addosso quell’abito perché gli serviva un uomo anziano da usare come mascotte, o come ulteriore elemento sacrale, o qualcosa del genere.
Cam disse, «Questa è mia sorella Valerie. Lui è fratello Micheal. Fratello John, Fratello Luois». etc., etc.
«Non mi hanno detto niente che possa far sperare in una ripresa di Madre, Cam. Sta morendo».
«Noi speriamo di no», rispose lui con quel suo sorriso misterioso. «Abbiamo passato la giornata a lavorare per lei».
«Intendi a pregare?» Dissi io.
«Lavorare è una parola più adatta a descrivere quello che abbiamo fatto rispetto a pregare, se non capisci a che cosa mi riferisco».
Beh certo, io non capisco mai.
«Quando lo si fa veramente pregare è come un lavoro, credimi». Continuò Cam, e tutti gli altri mi sorrisero, nel suo stesso identico modo. Non riuscivano a stare fermi, proprio come i bambini quando devono andare al bagno, dondolavano, si muovevano da una parte all’altra e facevano piccoli passi.
«Adesso, dov’è la sua stanza?» Asserì Cam con tono deciso.
Mi immaginai Madre in punto di morte e pensai che attraverso quella fessura tra le sue palpebre – chi lo sa, forse di tanto in tanto riusciva a scorgere qualcosa – avrebbe visto questa folla di dervisci fare celebrazioni intorno al suo letto. Madre che, persa la fede nella religione all’età di tredici anni, iniziò a seguire la dottrina della Chiesa Unitaria e la abbandonò quando i suoi seguaci si divisero a causa delle decisione di escludere Dio dagli inni sacri (lei era una di quelli a favore), proprio lei avrebbe dovuto passare i suoi ultimi minuti di vita a chiedersi che cosa stesse accadendo, a domandarsi se fosse stata trasportata indietro nel tempo, in un luogo dove dei pazzi saltellavano facendo i loro folli cerimoniali, a cercare di dare un senso ai suoi ultimi pensieri coscienti nel bel mezzo della loro celebrazione.
Grazie a Dio l’infermiere disse no. Fecero venire il tirocinante e lui rispose di no. Cam non insistette, sorrise e annuì verso gli altri come se gli stessero dando il permesso di entrare, poi portò il gruppo nella sala di aspetto e lì, proprio davanti ai miei occhi, iniziarono. Misero l’uomo anziano al centro, seduto a terra con la testa chinata e gli occhi chiusi – dovettero dargli un colpetto sulla spalla per ricordargli quello che doveva fare – poi si accoccolarono attorno a lui in una sottospecie di cerchio, rivolti uno di fronte e uno di spalle, alternativamente. A quel punto, con gli occhi chiusi, iniziarono a dondolare avanti e indietro e a mormorare parole in tono molto lieve, solo che non tutti dicevano le stesse cose, era come se ognuno pronunciasse parole diverse e, ovviamente, non in inglese, ma in swahili o sanscrito o roba simile. Il suono iniziò a farsi più intenso, diventò più forte gradualmente, una cantilena martellante, e a quel punto si alzarono in piedi, tutti eccetto l’uomo anziano, che rimase dov’era, e sembrava come sul punto di addormentarsi, seduto, mentre gli altri iniziarono a fare una specie di danza sul posto, strascicando i piedi e battendo le mani, non esattamente a tempo. Continuarono per un bel pezzo. Il rumore che stavano facendo, nonostante non fosse eccessivamente forte, attirò gli infermieri dalla loro postazione, i loro aiutanti, il personale ospedaliero e alcune persone che come me stavano aspettando di entrare a visitare i loro malati, sembrava che nessuno sapesse cosa fare: tutto era talmente insensato, così assurdo, in quella banale e piccola sala d’aspetto.
I presenti guardavano semplicemente la scena con meraviglia come se stessero dormendo e sognando, aspettando di svegliarsi. Poi un’infermiera uscì dal reparto di terapia intensiva e disse, «Non è possibile tutto questo fracasso. Che cosa pensate di fare qua?»
Afferrò uno di quelli più giovani e lo scosse per le spalle, nessun altro si sarebbe fermato o gli avrebbe prestato attenzione altrimenti.
«Stiamo lavorando per aiutare una donna che è molto malata». Le rispose lui.
«Io non so a che cosa tu ti riferisca quando dici lavoro, ma non state aiutando nessuno. Adesso vi chiedo di andarvene da qui. Anzi scusa. Non ve lo sto chiedendo. Ve lo sto dicendo».
«Si sbaglia di grosso se pensa che il tono delle nostre voci danneggi o disturbi qualcuno dei malati. Tutta questa cerimonia è modulata a un livello che raggiungerà e conforterà le loro menti prive di coscienza ed estirperà le influenze demoniache dal loro corpo. È una cerimonia che esiste da cinquecento anni».
«Buon Dio», disse l’infermiera sbalordita «Ma chi sono queste persone?»
Dovetti andare là e spiegarle la situazione, le dissi che quelli erano mio fratello e i suoi cosiddetti amici, e che io non prendevo parte alla loro cerimonia. Le chiesi di Madre, se era cambiato qualcosa.
«Nessun cambiamento», rispose. «Che cosa dobbiamo fare per mandarli fuori di qua?»
«Innaffiarli con una pompa», tagliò corto uno del personale. Per tutto questo tempo intanto, la danza, o la cerimonia, non si interruppe, anche quello che si era fermato a dare spiegazioni era tornato a danzare. A quel punto dissi all’infermiera «Telefonerò per sapere come sta, vado un po’ a casa adesso». Uscii dall’ospedale e mi resi conto con sorpresa che era buio. Ero stata lì dentro per un giorno intero, da notte a notte. Arrivata nel parcheggio mi misi a piangere. Cam aveva trasformato tutto in un circo per il suo tornaconto, pensai tra me e me, e lo dissi anche ad alta voce una volta arrivata a casa.
Haro mi preparò un drink.
«Probabilmente andrà a finire sul giornale. L’opportunità per Cam di diventare famoso».
Haro telefonò all’ospedale per sapere se c’erano delle novità e gli risposero che non ce n’erano. «Hanno… c’è stato qualche problema con quei giovani ragazzi nella sala d’aspetto stasera? Se ne sono andati tranquillamente?» Haro è dieci anni più grande di me, un uomo cauto, troppo paziente con tutti. In passato, a volte, ho anche creduto che avesse dato dei soldi a Cam senza che io lo sapessi.
«Se ne sono andati silenziosamente» rispose l’infermiere. «Non stia a preoccuparsi per i giornali. Dorma un po’».
Nonostante non ne avessi l’intenzione, finii per addormentarmi sul divano, aiutata dal drink e dalla lunga giornata appena passata. Quando mi svegliai il telefono stava squillando e la luce del giorno illuminava la stanza. Raggiunsi la cucina barcollando, tirandomi dietro la coperta che Haro mi aveva messo sopra, e vidi, guardando l’orologio sul muro, che erano le sei meno un quarto. È morta, pensai. Era il suo medico.
Disse che aveva delle notizie confortanti. Madre si sentiva molto meglio quella mattina.
Raggiunsi con fatica una sedia e mi ci lasciai cadere, con le braccia e la testa distese sulla credenza della cucina. Tornai al telefono e il dottore mi informò che Madre si trovava ancora in una fase critica, le prossime quarantotto ore sarebbero state decisive, ma pur senza alimentare troppo le mie speranze voleva mettermi al corrente che stava reagendo alle cure. Aggiunse anche che questo suo recupero era stato particolarmente sorprendete, considerando che era stata portata tardi in ospedale e che le terapie somministratele inizialmente sembravano non avere avuto molto effetto, ciononostante il fatto che fosse rimasta in vita durante le prime ore era ovviamente un buon segno. Con me ieri nessuno aveva dato particolare importanza a questo buon segno, pensai.
Rimasi lì a sedere per almeno un’ora dopo aver abbassato il telefono. Preparai una tazza di caffè liofilizzato, ma le mani mi tremavano così tanto che riuscii a fatica a metterci dentro l’acqua e poi non ce la feci a portarmi la tazza alla bocca. Lasciai che si freddasse. Alla fine Haro uscì fuori dalla stanza da letto in pigiama. Mi guardò e disse «Calma, Val. È morta?»
«Sta un po’ meglio. Sta reagendo alle cure».
«A giudicare dal tuo aspetto ho pensato il contrario».
«Sono così sorpresa».
«Ieri a mezzogiorno non avrei scommesso neanche cinque centesimi sulle sue possibilità di sopravvivere».
«Lo so. Non posso crederci neanche io».
«È la tensione», continuò Haro. «È normale. Ti tieni pronto al fatto che qualcosa di brutto sta per accadere e poi quando non succede sei sopraffatto da una strana sensazione, non riesci a essere subito felice, è quasi una delusione».
Delusione. Era questo quello che provavo. Ero così felice, veramente, piena di gioia, ma dentro di me continuavo a pensare: così Cam non l’ha uccisa nonostante tutto, non l’ha uccisa con la sua imprudenza, la sua follia, non l’ha fatto andandosene di casa e trascurandola, e io ero – sì, lo ero – dispiaciuta, una parte di me era dispiaciuta di scoprire che questo fosse vero.
Ero consapevole del fatto che anche Haro sapesse quello che stavo provando, ma non me ne avrebbe mai parlato. Per me era stato quello il vero shock, quello il motivo per il quale continuavo a tremare. Non importava se lei fosse viva o morta. Era stata una reazione spontanea.
Madre si riprese, superò alla grande la malattia. Dopo essersi rimessa non ebbe alcuna ricaduta. Rimase in ospedale per tre settimane e poi tornò a casa dove restò a riposo per altre tre, dopodiché tornò a lavorare, riducendo un po’ l’orario: dalle dieci alle quattro invece che per tutta la giornata, il cosiddetto “turno delle casalinghe”. Raccontò a tutti di quando Cam e i suoi amici andarono all’ospedale. Iniziò a dire cose del tipo «Be’, il mio ragazzo potrà anche non avere successo in nient’altro, ma dovete ammettere che ha una particolare abilità nel salvare le vite». Oppure «Forse Cam dovrebbe mettersi a fare miracoli, con me c’è sicuramente riuscito». Nel frattempo lui continuava a dire, tutt’ora lo fa, di non essere più sicuro riguardo a quel tipo di religione, di aver iniziato ad annoiarsi degli altri preti e del non poter mangiare carne e ortaggi da radice. È stato un periodo, dice, è felice di averlo attraversato, gli è servito per scoprire se stesso. Un giorno passai da casa e lo trovai mentre si provava un vecchio completo con tanto di cravatta. Disse che avrebbe potuto approfittare di uno dei corsi d’istruzione per adulti, stava prendendo in considerazione l’idea di diventare ragioniere.
Io invece mi misi a riflettere su come diventare un tipo di persona diversa rispetto a quella che ero. Cominciai a pensarci seriamente. Lessi un libro intitolato L’arte di amare. Mentre lo leggevo mi sembrava che molte cose fossero chiare, ma una volta finito tornai a essere più o meno quella di prima. In fin dei conti che cosa aveva fatto Cam di così tremendo per ferirmi? Mi fece notare Haro una volta. E con che diritto avrei potuto sentirmi migliore di lui dopo il modo in cui avevo reagito la notte in cui Madre era sopravvissuta invece di morire?
Promisi a me stessa che ci avrei provato. Un giorno andai a trovarli, gli portai anche una torta dalla pasticceria – che Cam adesso è felice di mangiare tanto quanto nessun altro al mondo – sentii le loro voci fuori in giardino (siamo in estate e loro amano stare seduti al sole), Madre stava dicendo a degli ospiti «Oh sì lo ero, ero proprio sul punto di andarmene a finire lassù, nel blu sconfinato del cielo, e Cam, questo sciocchino, è arrivato e si è messo a ballare fuori dalla mia porta con un gruppetto di suoi amici hippies».
«Mio Dio, donna». Urlò Cam, ma con un tono dal quale si intuiva che la questione non gli interessava più ormai «seguaci di un’antica e sacra disciplina».
Provai una strana sensazione: mi sentii come se stessi camminando sui carboni ardenti e stessi disperatamente cercando di farmi venire in mente un incantesimo per non bruciarmi.
Il perdono in famiglia è un mistero per me: come si arriva a concederlo o come si riesce a farlo durare nel tempo.
Fotografia: G. Biscardi, Ritratto di famiglia, Palermo 2011.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento