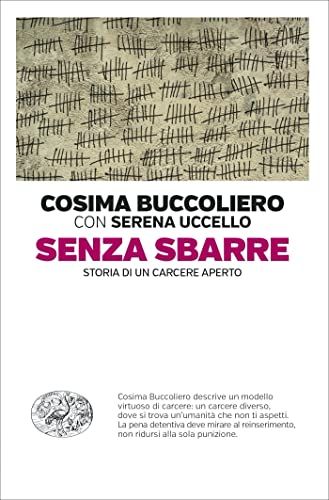
A scuola dal carcere
In Senza sbarre – Storia di un carcere aperto, Cosima Buccoliero racconta con Serena Uccello la propria esperienza nella direzione carceraria, segnata dalla vicenda pilota del carcere di Bollate e dalla persuasione che garantire i diritti nel carcere è anzitutto garantirli a chi sta fuori, che la violenza nel carcere è la violenza per tutti, che la speranza nel carcere è la speranza e la rinascita di tutti. Non si tratta del referto a consuntivo di un’esperienza personale, ma di una luce accesa a partire dalla domanda su quanto ciascuno di noi sia capace di decifrare, di vedere il carcere, ché i bambini non lo disegnano il carcere nelle mappe delle loro città, ma anche noi troppo spesso lo cancelliamo il carcere, il carcere che però c’è, e che c’è soprattutto nella nostra vita, personale e collettiva, come rimosso di quel male che parrebbe non riguardarci ma che, il libro sa dircelo magistralmente, ci potrebbe mostrare quanto la sua elaborazione e la sua presa in carico degna da parte dello Stato sia il primo banco di prova dove fondare il senso della nostra civiltà.
Il libro compie dunque questo servizio preliminare, attraverso lo sguardo della Buccoliero, anzitutto di portarci a incontrare e poi a guardare il carcere (capitoli primo e secondo), lo fa attraverso gli occhi di chi sa collocare tale invito necessariamente sotto la lente complessa dell’esperienza e a riguardo utilizza consapevolmente anche il rispecchiamento narrativo (a mezzo di riferimenti a opere importanti della narrazione carceraria, come il recente Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, ma anche lo splendido e troppo in fretta dimenticato Cattivi di Maurizio Torchio). Ma già in questa parte introduttiva, facendo proprio l’esempio del cardinale Martini, la Buccoliero impone l’interrogativo su cosa fare di quell’ipotetico deposito di male a fondo perduto che dovrebbe essere per alcuni il carcere: lasciare che così sia o farne luogo rigenerativo di una dignità che si potrebbe irradiare nella società intera?
Perché poi l’importanza di questa testimonianza emerge e si fa domanda nei due capitoli centrali: Vivere nel carcere o vivere il carcere e Decidere, rischiare, sbagliare in carcere. Leggendo i passi della quotidianità della cella, della ridefinizione del tempo e dello spazio, dei sensi e dei pensieri, incontrando il guardaroba di Antonia o l’amore incomprensibile di Soquellochefaccio, subendo il carico della disperazione silenziosa e sfinita delle madri recluse, dell’estremo dire al mondo il proprio «esisto» dell’adolescente del penale minorile attraverso la minaccia del suicidio che a volte tragicamente giunge a compimento, ammirando infine lo sforzo continuo della Buccoliero alla ricerca della «giusta distanza», della prossimità assoluta all’apparentemente irrimedibile, a partire dai tanti Marcello e di tutto il dolore scandaloso del mondo, io – da insegnante – non ho potuto non pensare alla scuola.
Eh sì, perché questo libro, nel momento in cui ci racconta con le scelte minute come organizzare, liberare, ricaricare di dignità il tempo, lo spazio, tutta la vita di ogni giorno in carcere, nel momento in cui attraverso la prassi ci dice a lettere di fuoco «che la persona che ho difronte, chiunque essa sia, non è il reato che ha compiuto», che ognuna di quelle persone «preesisteva al carcere e a quello che era accaduto, esisteva prima del reato che aveva compiuto», ecco, in quei momenti ci svela come possa esistere a partire dal luogo apparentemente più lontano, la possibilità di mostrare ai nostri figli e alle nostre figlie come la dignità dello Stato, della Costituzione, del bene comune che si fa carico di non lasciare indietro, di non cancellare nessuno, sia possibile storicamente e non solo negli astratti propositi dei libri o delle parole degli insegnanti.
Ogni scuola dovrebbe andare in carcere, ogni scuola dovrebbe ripartire da un carcere quando questo luogo fisico e morale cerca di essere quello descritto in questo libro: questo mi sono detto concludendo la lettura e in particolare gli ultimi due capitoli, Rinascere in carcere e Cambiare il carcere. Quest’ultimo, ma è onestà che percorre tutto il libro, mette difronte alla drammaticità delle condizioni attuali del regime carcerario in Italia, all’ignoranza di certa politica e di certe leggi che troppo spesso hanno dimenticato il valore sacro e costituzionale della giustizia riparativa e lo fa proprio perché nelle pagine precedenti ci ha mostrato invece cosa dovrebbe essere non tanto il carcere, quanto l’uomo, la donna, l’adolescente che si sono trovati ad aprire un conto personale con la giustizia e che uno Stato degno ha saputo rendere semi di speranza.
Articoli correlati
Nessun articolo correlato.
-
L’interpretazione e noi
-
 Capuana tra gli «ismi»
Capuana tra gli «ismi» -
 Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024
Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -
 La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach
La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -
 L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia
L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -
-
La scrittura e noi
-
 Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?
Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -
 «Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti
«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -
 “Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni
“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -
 Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto
Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -
-
La scuola e noi
-
 Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana
Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -
 CCC*
CCC* -
 L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato
L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -
 Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.
Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -
-
Il presente e noi
-
 La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina
La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -
 La resistibile ascesa delle destre
La resistibile ascesa delle destre -
 Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo
Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -
 L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso
L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -
Commenti recenti
- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…
- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…
- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…
- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione
- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Daniele Lo Vetere
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento