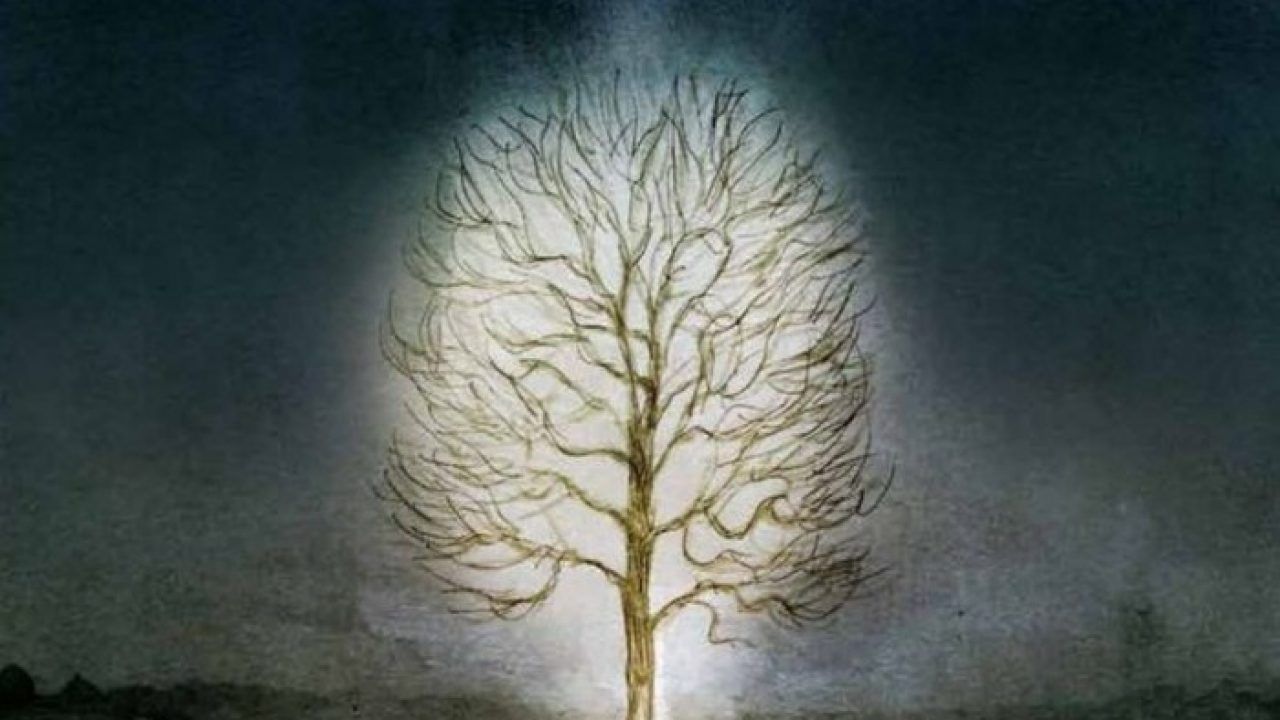
Il principio speranza
“La letteratura e noi” è il nostro titolo. Ma questo “noi” cosa significa oggi?
Si vive in un momento storico in cui la pandemia ha accresciuto frantumazione sociale e isolamento dei singoli e dei gruppi familiari. Il narcisismo, fenomeno tipico di questa epoca, si è sviluppato in forme di individualismo esasperato e di egoismo senza limiti. L’idea di libertà ha perduto la sua dimensione sociale e collettiva, per assumere l’aspetto di una diffusa egolatria, ignara dei diritti degli altri. La dimensione del “noi” si è smarrita. Contemporaneamente la pandemia ha rivelato però anche la necessità di un fronte comune nella lotta contro il virus e suscitato il bisogno di una solidarietà collettiva. È una contraddizione su cui lavorare.
In questa situazione il “noi” può essere quello di un piccolo gruppo che fa un blog per difendere uno spazio di intervento e la propria sopravvivenza come comunità ristretta che pretende di interpretare i testi letterari e fornire spunti e temi a chi opera nel mondo della scuola. Nel medesimo tempo però questa comunità ristretta sa, o dovrebbe sapere, che esiste anche una comunità più grande. L’unica ontologia dell’essere, diceva un vecchio filosofo e critico letterario del secolo scorso, è l’essere sociale. Da questo punto di vista, insomma, la sfera del “noi” tende ad allargarsi e ad abbracciare tutti i possibili interpreti di un testo letterario, la comunità dei lettori nel loro complesso, e addirittura la società tutta come potenziale interprete non solo delle opere artistiche ma dei destini del mondo che esse raffigurano. Scrivere per un “noi”, e non per un “io”, comporta l’esigenza di confrontarsi con questo orizzonte più vasto. Il nostro “noi” da questo punto di vista vorrebbe preservare questa prospettiva. Non è solo uno stile di pulizia, di lavoro e di scrittura, ma un modo, pur consapevole della propria modestia, di tendere – anche attraverso questo stile – a un noi prospettico o “figurale”, come avrebbe detto Auerbach. Il nostro “noi” non è tanto appello a una difesa comune di uno spazio: è qualcosa da costruire insieme. Tende a un futuro non a salvaguardare un passato. Un’utopia? Forse. Ma senza una utopia come si fa oggi a insegnare letteratura in una scuola, a occuparsi dei testi letterari e di didattica, ad avere ancora fiducia nel lavoro culturale?
Nella nostra attività di insegnanti abbiamo ormai a che fare direttamente con il linguaggio burocratizzato del potere che è penetrato in ogni interstizio del nostro lavoro. Sappiamo bene di essere parlati da questo linguaggio, anche nostro malgrado e anche involontariamente e inconsapevolmente. Un tempo gli intellettuali potevano contrapporre al linguaggio del potere il potere del proprio linguaggio. Oggi il potere del nostro linguaggio è stato sostituito dal linguaggio del potere che domina incontrastato nei documenti ufficiali dei ministeri, col suo similinglese e il suo aziendalismo. Fra potere del linguaggio e linguaggio del potere c’è ormai coincidenza.
E tuttavia la scuola è pur sempre una scuola. La trasmissione del sapere, che esige complessità e rigore, passa ancora attraverso la voce dell’insegnante. Esiste una “memoria” storica che ancora non è stata cancellata perché semplicemente resiste nelle cose, a partire dalla relazione diretta fra allievo e insegnante. Nello studio dei testi letterari lo stesso rapporto fra commento e interpretazione, fra filologia ed ermeneutica, è una lezione democratica che non vale solo per la letteratura.
Anche gli organi collegiali, pur essendo ormai ridotti a canali di trasmissione del linguaggio del potere, conservano una traccia della loro originaria affermazione come organi democratici, e per questo vanno tutelati anche attraverso lo smascheramento della loro, oggi prevalente, funzione burocratica e servile. Inoltre dovremo occuparci sempre di più, col blog e attraverso il blog, della formazione degli insegnanti, difendere la loro specifica professionalità, il loro spazio disciplinare.
Esiste insomma, nel mondo della scuola, una memoria storica sepolta che può riaffiorare. Un tempo il professore non era un impiegato o un burocrate, ma un intellettuale. Quel passato non può tornare più. Lo sappiamo. Sono mutate le condizioni storiche. Ma quanto c’era in esso di vitale va salvaguardato e adeguato alle conoscenze e anche alle competenze richieste dal presente.
Noi siamo un piccolo gruppo. I suoi componenti provengono da zone diverse del paese, dal Nord di Piemonte, Lombardia e Veneto al Sud della Sicilia. Molti non si conoscevano prima di incontrarsi nel blog. Eppure abbiamo imparato a lavorare insieme. Sarebbe già molto se in questo momento difficile potessimo, da qualche parte e in qualche modo, preservare, come diceva un altro pensatore del secolo scorso, il “principio speranza”.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento