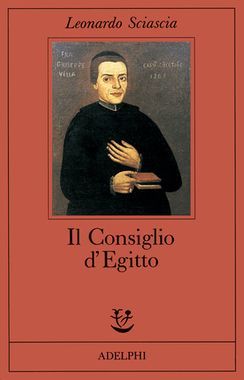
Perché leggere questo libro: Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia
Il benedettino passò un mazzetto di penne variopinte sul taglio del libro, dal faccione tondo soffiò come il dio dei venti delle carte nautiche a disperdere la nera polvere, lo aprì con un ribrezzo che nella circostanza apparve delicatezza, trepidazione. Per la luce che cadeva obliqua dall’alta finestra, sul foglio color sabbia i caratteri presero rilievo: un grottesco drappello di formiche nere spiaccicato, secco. Sua eccellenza Abdallah Mohamed ben Olman si chinò su quei segni, il suo occhio abitualmente languido, stracco, annoiato era diventato vivo e acuto. Si rialzò un momento dopo, a frugarsi con la destra sotto la giamberga: tirò fuori una lente montata, oro e pietre verdi, a fingerla fiore o frutto su esile stralcio.
«Ruscello congelato» disse mostrandola. Sorrideva: chè aveva citato Ibn Hamdis, poeta siciliano, per omaggio agli ospiti. Ma, tranne don Giuseppe Vella, nessuno sapeva di arabo: e don Giuseppe non era in grado di cogliere il gentile significato che sua eccellenza aveva voluto dare alla citazione, né di capire che si trattava di una citazione. Tradusse, perciò, invece che le parole, il gesto: «La lente, ha bisogno della lente»; il che monsignor Airoldi, che con emozione aspettava il responso di sua eccellenza su quel codice, aveva capito da sé.
Sua eccellenza era di nuovo chino sul libro, muoveva la lente come a disegnare esitanti ellissi. Don Giuseppe vedeva i segni balzare dentro la lente e, prima che avesse il tempo di coglierne uno solo, sfrangiati ricadere sulla pagina tarlata.
Sua eccellenza voltò il foglio, ancora si attardò nell’esame. Mormorò qualcosa. Voltò altri fogli velocemente scorrendoli con la lente, sull’ultimo che guizzava di piccoli vermi d’argento si soffermò.
Si sollevò, voltò le spalle al codice: lo sguardo gli si era di nuovo spento.
«Una vita del profeta», disse «niente di siciliano: una vita del profeta: ce ne sono tante».
Don Giuseppe Vella si voltò con faccia radiosa verso monsignor Airoldi: «Sua eccellenza dice che si tratta di un prezioso codice: non ne esistono di simili nemmeno nei suoi paesi. Vi si racconta la conquista della Sicilia, i fatti della dominazione…». (L. Sciascia, Il consiglio d’Egitto, Milano, Adelphi, 2009, pp. 15-16)
Per la rivisitazione del romanzo storico
Nella produzione romanzesca di Sciascia Il Consiglio d’Egitto (1963) si colloca tra Il giorno della civetta (1961) e A ciascuno il suo (1966), ossia tra le due opere con cui denuncia il fenomeno mafioso tramite il genere del giallo ad inchiesta che viene rinnovato e sottratto ai cliché del romanzo d’evasione. Il Consiglio d’Egitto condivide con i romanzi coevi dello scrittore siciliano la rappresentazione di uno dei temi a lui più cari: gli sforzi della ragione alla ricerca di una giustizia sociale e di una verità per raggiungere le quali vanno smascherate le imposture su cui si fonda lo statu quo. Tuttavia, il genere letterario cui Sciascia ricorre in questa “opera di mezzo” non è l’inchiesta poliziesca ma il romanzo storico. Al suo apparire, Il consiglio d’Egitto fu definito l’“anti-Gattopardo” da Giancarlo Vigorelli che vi ravvisava un tentativo di rottura rispetto alla rappresentazione ritenuta camaleontica, trasformista della nobiltà siciliana nell’epoca risorgimentale a partire da I viceré (1894) di De Roberto e I vecchi e i giovani (1909) di Pirandello per giungere a Il Gattopardo (1958) di Tomasi di Lampedusa.
Ambientato nella Sicilia del tardo Settecento e incentrato sulla vicenda del massacro dei presunti giacobini di Caltagirone, l’opera è basata su ricerche d’archivio e, in particolare, sulla Storia letteraria della Sicilia di Domenico Scinà, sulle cronache del marchese di Villabianca e sugli scritti dello storico Isidoro La Lumia. Uno dei due personaggi su cui si costruisce la narrazione storica è l’avvocato Francesco Paolo Di Blasi, promotore in quegli stessi anni di una congiura destinata a venire repressa: con questo personaggio Sciascia delinea una figura che non si limita “affatto a guardare le stelle, come fa il Principe di Salina” (G. Traina, Leonardo Sciascia, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. 193)
Dalle fonti storiche Sciascia mutua inoltre il personaggio dell’abate Vella, artefice dell’”impostura” su cui la vicenda narrata si fonda: costui, infatti, falsifica la traduzione di un codice arabo – una “banale” vita del profeta – in modo tale da minare alle fondamenta le basi dei privilegi feudali dell’isola; non soddisfatto, in seguito ne redige uno di suo pugno, falsificando perfino i caratteri arabi che, di fatto, non padroneggia.
Ne Il Consiglio d’Egitto Sciascia, dunque, rivisita il romanzo storico, quella forma “mista di storia e d’invenzione”, con una narrazione intessuta dei chiaroscuri del modello manzoniano: «Come già Gadda, che nei “lividori caravaggeschi” della prosa manzoniana scorgeva “il disegno degli avvenimenti segreti e inavvertiti”, anche Sciascia si concentra sul valore ermeneutico dell’opera, su quel “disperato ritratto delle cose d’Italia” che ancor oggi “resiste”» (R. Palumbo Mosca, L’invenzione del vero, Roma, Gaffi, p. 31). Nei suoi romanzi storici, e su tutti proprio ne Il consiglio d’Egitto, lo scrittore assume un atteggiamento molto vicino a quello di Manzoni: se, da una parte, le fonti storiche sono necessarie per la ricostruzione del contesto e della vicenda, dall’altra è solo lo scrittore a poter cogliere «intuitivamente la verità» dei fatti (Sciascia, Nero su nero, 1979).
In tal modo il narratore siciliano è tra i primi contemporanei a contaminare indagine storico-saggistica e romanzo con una lettura “obliqua”, critica e perfino provocatoria delle fonti, al punto da far pronunciare all’abate maltese le seguenti parole:
E allora don Giuseppe pianamente gli spiegava che il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri […]. (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit., p. 59)
Paradossalmente l’impostura letteraria, la finzione realizzata dalla mente e dalla penna del Vella è quanto di più vicino alla verità si possa immaginare, mentre la «storiografia diventa […] oggetto di un sentimento di profondo scetticismo, in quanto giustificazione ideologica di un Potere che perpetra il sopruso e la menzogna e mistifica soltanto le gesta dei grandi personaggi ignorando invece la vita degli umili” (I. Pagliara, «Il mondo della verità: su Il consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia).
Per le contraddizioni dei protagonisti intellettuali
I due protagonisti, l’abate Vella e l’avvocato Di Blasi, sono due intellettuali diversi fra loro ma in qualche misura complementari. Il primo, il letterato, si fa portavoce del sostanziale scetticismo autoriale nei confronti della Storia, mentre il secondo, il politico, sembra mantenere – in linea con i “lumi” che giungono d’Oltralpe – una strenua fiducia nel riscatto futuro dell’uomo nonostante la prassi politica che egli stesso incarna sia destinata al fallimento. La costruzione di entrambi i personaggi, tuttavia, rivela interessanti ambivalenze e contraddizioni.
Nei confronti dell’abate Vella – personaggio dalla valenza fortemente metaletteraria – lo scrittore manifesta la posizione più incerta e ambigua. Nel corso della vicenda il Vella passa da «smorfiatore di sogni» a vero e proprio falsario e inventore di codici: da ermeneuta di scritti altrui diviene, cioè, inventore di storie. Ma l’esercizio della creatività, dell’invenzione letteraria non viene adoperato primariamente con finalità demistificanti rispetto alla Storia: l’abate, infatti, è mosso più dal desiderio di raggiungere il prestigio e la rispettabilità che dal bisogno di giustizia sociale. Anzi, la confessione della sua impostura avverrà soprattutto per vedere riconosciuta la grandezza della sua opera letteraria:
Il carcere davvero non gli faceva paura, era caduto in uno stato di assoluta indifferenza riguardo alle comodità e ai piaceri dell’esistenza: più forte era il gusto di offrire al mondo la rivelazione dell’impostura, della fantasia di cui nel Consiglio di Sicilia e nel Consiglio d’Egitto aveva dato luminosa prova di lui. In lui, insomma, il letterato si era impennato, aveva preso la mano dell’impostore: come uno di quei cavalli di Malta, neri, lucidi, inquieti, lo trascinava nella polvere, il piede attaccato alla staffa. (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit., p. 154)
Per quanto riguarda l’avvocato Di Blasi, risulta chiaro fin da subito che la sua azione rivoluzionaria – vanamente eroica – sarà destinata a essere svuotata di efficacia dalla plebe stessa, adusa a schierarsi dalla parte dei poteri consolidati, baronali ed ecclesiastici. Nonostante la sconfitta, Di Blasi manterrà fino all’ultimo la sua fiducia in un mutamento futuro che è volto a cancellare dal mondo gli orrori dei soprusi politici e della tortura. Nel corso del supplizio che gli viene inflitto prima della condanna capitale, l’avvocato conclude tra sé e sé: «”Questo non deve più accadere a un uomo pensò: e che non sarebbe più accaduto nel mondo illuminato dalla ragione.» (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit., p.165). Tuttavia è la voce autoriale a smentire subito di seguito, con un inciso assai significativo, questa illusione, prendendo definitivamente le distanze dal personaggio che conserva, in modo volontaristico, un residuo di speranza nella ragione:
(E la disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell’avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri; che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari dell’amore familiare e rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani: con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura; e che persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo […]). (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit., p. 165-166)
Per la problematica compresenza fra Barocco e Illuminismo
Sciascia è noto per l’attitudine a una razionalità laica che affonda le sue radici nel secolo XVIII e che ha in Voltaire il suo nume tutelare. Eppure in questo breve romanzo storico sembrano affiorare «una serie di cariche esplosive sotto i pilastri del povero illuminismo», come Calvino scriveva a Sciascia: si tratta di quelle «polveri tragico-barocco-grottesche» che un siciliano non può non aver respirato lungo l’asse che tiene unite la Spagna alla Sicilia e che riemergono anche in altre prove narrative dello scrittore di Racalmuto: basti pensare a Morte dell’inquisitore (1964).
Ne Il consiglio d’Egitto queste “cariche esplosive” si innescano in coincidenza con la terza parte del romanzo e trovano i momenti apicali rispettivamente nei funerali del vicerè, il principe di Caramanico, e nella descrizione del corpo straziato dalla tortura del Di Blasi.
Nel primo caso prevale la nota grottesca e barocca, a segnalare la vacuità del governo del principe di Caramarico, mandato a Palermo per rimediare alle “caracciolate” riformiste del suo predecessore; lo sguardo del narratore onnisciente si appunta sullo sfarzoso corteo funebre del vicerè, morto con ogni probabilità per avvelenamento, e mira a evidenziare da una parte come la processione dai tratti spettacolari sortisca l’effetto di «commuovere le viscere dei bottegai e dei vastasi» e dall’altra come la rappresentazione del corpo del viceré, colto per frammenti, subisca un abbassamento dal solenne al carnevalesco:
Un battaglione di cavalleria apriva il corteo. Tra due ali di alabardieri, solo al centro della strada, con passo lento e con faccia inespressiva, camminava il capitano di città. Appresso venivano i nobili, vestiti come lui di nero: un migliaio di persone che tentavano di mantenere rigido passo ek ordine di riga, ma senza apprezzabile risultato. Seguiva un battaglione di fanteria e la banda musicale del corpo, dai cui ottoni vibrava, a commuovere le viscere dei bottegai e dei vastasi, una straziante marcia funebre. […] Adagiato su una bara coperta da un drappo si seta e d’oro, don Francesco d’Aquino, principe di Caramarico, viceré di Sicilia, pareva un otre a metà sfiatato cui avessero sovrapposto la cera insegna di due mani incrociate e applicata una testa tutta naso, da carnevale. […] Il principe di Caramarico se ne andava, dopo quasi dieci anni, con più fasto di com’era venuto. (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit.,pp. 83-84)
Le pagine dedicate al Di Blasi, al contrario, fanno capo a quanto di più truce è ispirato dall’oscurantismo seicentesco: la descrizione dei piedi torturati dell’uomo – il lezzo, il dolore, lo spettacolo informe delle «sanguinolente e grommose zolle di carne» (Ivi, p. 147) -, la rappresentazione del suo sforzo sovrumano per far prevalere il controllo della ragione a fronte della sofferenza fisica sono non solo tra le pagine stilisticamente più riuscite del romanzo ma testimoniano l’ambivalente attrazione che Sciascia prova per i due poli del Barocco e dell’Illuminismo
i piedi informi come zolle che si attaccano agli arbusti sradicati, sanguinolente e grommose zolle di carne. E facevano lezzo di unto bruciato, di decomposizione. […] Davanti ai giudici, toccava ai piedi esprimere la serenità, la forza della mente: i piedi che già per sette volte, qual suole il fiammeggiar delle cose unte, avevano subito la tortura. E il diciannovesimo dell’Inferno l’aveva aiutato a sopportare, e altri versi di Dante, dell’Ariosto, del Metastasio: forme di quel maleficio in cui i giudici, non a torto, credevano. (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit.,pp. 147-148).
Le pagine su cui il romanzo si chiude, dedicate all’esecuzione capitale del Di Blasi, ripropongono con teatralità barocca la morte di questo personaggio tragicamente lucido che sa di restituire la libertà – parola per antonomasia settecentesca – al boia che gli taglierà la testa:
«Voscenza mi perdoni».
«Pensa alla tua libertà» lo rincuorò il condannato. (L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, cit.,p. 170)
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento