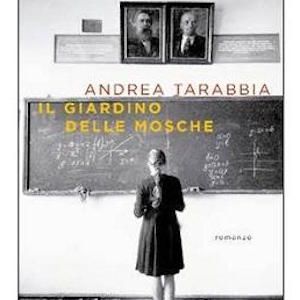
Mutilazione e delirio: il coraggio dell’invenzione ne “Il giardino delle mosche” di Andrea Tarabbia
«Questo le chiedo, di ascoltarmi e credermi, ma non mi domandi, non ancora, perché io mi sia deciso a raccontare» (p.11). Sotto forma di una lunga, allucinata confessione – come nella migliore tradizione della narrativa russa – Andrea Tarabbia ha scelto di trasfigurare in voce narrante Andrej Čikatilo, il killer che tra il 1978 e il 1990 è stato artefice di una serie di omicidi tra i più truci e indicibili del secondo Novecento: un fatto di cronaca nera che il senso comune ha biasimato e condannato, alimentandosi però morbosamente dei dettagli diffusi da un giornalismo sempre più indistinguibile dallo sciacallaggio mediatico.
Tarabbia, studioso di letteratura russa già cimentatosi con la storia più recente di questo paese ne Il demone a Beslan (2011), contro ogni tentazione cronachistica o voyeuristica, pur partendo dai documenti ufficiali relativi al caso, ha scelto coraggiosamente di rappresentare il delirio di un serial killer trasfigurando la vicenda di un uomo in metafora politica. Ha dunque esaltato, nel suo protagonista, l’assoluta fedeltà all’ordine gerarchico del socialismo reale («sono sempre stato un comunista, fin dalla prima infanzia ho vissuto e lavorato e lottato per la nostra Grande Causa Comune.» p. 12), che rivendica una radice storico-politica ai suoi omicidi. Le vittime prescelte sono infatti per lo più persone deboli e reiette, ai margini di una società in via di un millenaristico disfacimento: di questo in effetti il narratore autodiegetico Andrej le considera irrimediabilmente colpevoli e perciò “degne” di essere eliminate. Se è evidente come le uccisioni, le mutilazioni, gli atti di cannibalismo dell’uomo siano, per l’autore, gli esiti di una mente gravemente dissociata e malata nella quale riusciamo a penetrare grazie alla forza dell’immaginazione narrativa, risulta altrettanto chiaro come l’inattendibilità della voce che narra diventi strumento letterario d’indagine e di svelamento non solo di una coscienza ma di un intero dispositivo sociale. La trasposizione letteraria di questa storia vera, va detto fin d’ora, è perfettamente riuscita grazie a un’operazione che, nell’epoca dell’imperversare del non-fiction novel, restituisce alla narrativa tutto il suo potere “d’invenzione”. L’uomo che si aggira nel distretto russo di Rostov è un personaggio finzionale di quelli che Testa non esiterebbe a definire ab-solutus, «una monade irrelata che s’alimenta della sua sola volontà e che traccia la sua orbita nel cielo della disperazione» (E. Testa, Eroi e figuranti. Il personaggio nel romanzo, Torino, Einaudi, 2009, p. 9).
Nel romanzo, diviso in tre parti disposte in progressione cronologica – La morte per fame (1936-1978), Dissoluzione (1987-1990), Il supplizio e la festa (1990-1994) – Andrej Čikatilo, posto di fronte al capo della polizia Kostoev, ricostruisce in modo digressivo la sua vicenda biografica (nell’ultima parte del libro, tuttavia, sarà quest’ultimo a succedergli, creando non solo un avvicendamento di voci ma una sorta di “doppio” del protagonista: di etnia inguscia, musulmano e per questo perseguitato e deprivato durante il periodo staliniano, anche Issa Kostoev assiste al crollo dell’ideologia comunista ma diverge nel modo in cui sceglie di esercitare il suo potere di vita e di morte sugli altri: non nell’onnipotenza del delirio come Čikatilo, ma nella legalità dello stato). In tal modo, la duplice tragedia del Novecento russo (lo stalinismo e l’invasione nazista) si fa trasparente e nitida nelle azioni dissociate e cruente di un solo soggetto, che da vittima diventa carnefice.
La parola chiave, vero e proprio leit-motiv del testo, volta a caratterizzare quest’uomo, ma anche il mondo che lo circonda, è “mutilazione”: fin dai primi anni di vita Andrej è vissuto in uno “stato di minorità” per una carestia così feroce da indurre i vicini al cannibalismo (è forse così che ha perso il fratello maggiore Stefan Romanovič); per l’assenza del padre, reclutato in guerra; per l’enuresi notturna che la madre esibisce perfino con disprezzo; per la violenza sessuale che questa subisce dai soldati tedeschi sotto i suoi occhi (è dai “rabdomanti” che Andrej avrà una sorella); infine per la sodomizzazione che a sua volta vive durante il servizio militare. I soprusi e le sopraffazioni esitano in un senso di spaesamento e di scissione («Per molto tempo, non so più nemmeno quanto, io ho vissuto in luoghi astratti. Stavo, qui, nella mia casa, o sul posto di lavoro, eppure non c’ero, disse, ero altrove […] era come se non sapessi chi ero» p.11). Ma il sintomo più grave, quello più umiliante, che Andrej trascina con sé è la “mutilazione” per antonomasia della sua vita, l’impotenza sessuale, quel «pene morto […] che è la più grande delle mie mutilazioni (pp.36-37)».
Perché Tarabbia abbia scelto di romanzare questa “storia vera” lo si può evincere da un’intervista: «Mi interessa entrare dentro alle cose, provare fastidio, anche, ma cercare di capire che cosa succede quando il male e la violenza esplodono: per far questo, a volte devo mettermi per così dire “dalla parte sbagliata”, e provare a vedere e immaginare il mondo per come lo vede e lo immagina chi compie atti terribili, straordinari» (Il cannibale e il comunismo. Un’intervista di Alessandra Sarchi a Andrea Tarabbia in http://www.nazioneindiana.com/2015/10/10/il-cannibale-e-il-comunismo/).
Per il lettore, la parte più convincente del romanzo di Tarabbia sta, più che nella rappresentazione del farsi concreto del male – l’individuazione della vittima, il rituale dell’adescamento, gli atti di efferata violenza, il godimento delirante del carnefice che tiene in pugno la vittima inerme (cfr. per esempio l’uccisione di Larisa pp. 119-126) – proprio in quel «vedere e immaginare il mondo» con gli occhi paranoici di Andrej. L’autore, per il tramite della voce narrante, mette in scena l’allucinazione di un uomo che “sposta” psicanaliticamente le ragioni profonde dei suoi abusi sessuali e del suo delirio di onnipotenza in termini di ordine sociale. Sintomatico è, a questo proposito, il sogno in cui, con la guida di Černenko, Andrej si ritrova al cospetto del corpo mummificato di Lenin:
È per questo che l’ho portata qui, Andrei Romanovič, perché lei mi aiuti, mi aiuti a fare in modo che nessun Gorbacëv possa mettere la pietra tombale su tutto questo. […] Lei deve continuare la sua opera, compagno Čikatilo […] lei ci deve aiutare a tenere pulita l’Unione (p. 200).
Altrettanto paradigmatici sono i ricorrenti dialoghi con il fantasmatico fratello Stëpa che, cencioso e sporco, saltuariamente appare, fungendo da coscienza, nella sua «tana» segreta – un luogo dove Andrei si rifugia e dove ha compiuto alcuni dei suoi delitti -:
Le stazioni, le fermate degli autobus. Sembri qualcuno che vive sulla linea dell’električka che porta a Rostov. Io ci vado spesso, sai, sui treni, sui pullman urbani…nelle stazioni trovo sempre vagabondi, vecchi e giovani. Chiedono l’elemosina e sono ubriachi già di prima mattina. Tra loro ci sono anche dei minorenni. È un’umanità ributtante, Stëpa […] Le stazioni sono piene di barboni, vagabondi – persone che hanno rifiutato il nostro sistema o che, per qualche motivo, ne sono esclusi. Essi sono la nostra ferita, e andrebbero eliminati, deportati per il bene del Paese e della nostra gioventù. (pp. 110-112)
Ma le figure spettrali e oniriche che si alternano nella sua «tana, in vicolo Meževoj» sono anche altre e, tra tutte, campeggia quella della piccola Lena, la sua prima vittima.
È lì, nel rifugio segreto, che Andrej, uomo buono e mite come lui stesso si definisce, costruisce le sue mosche di rame, rappresentazioni oggettuali delle sue vittime, come loro imperfette, sbilenche, “doppio” dei loro corpi mutilati: «Mi piacerebbe metterti gli occhi […] tutti capirebbero all’istante che tu sei una mosca, perché l’essenza delle mosche è, prima che nelle ali, nella forma degli occhi. Ma tu non li avrai, tu sei la mia mosca imperfetta, il mio tentativo di mosca» (pp. 44-45).
Tarabbia si situa in quella linea narrativa che, dando voce ai carnefici, cerca di fare emergere le ragioni profonde che scatenano il Male e, in questo senso, Il giardino delle mosche si può affiancare a L’avversario (2000) di Carrere e a Le Benevole (2006) di Littel. Per quanto riguarda l’area italiana, invece, Tarabbia sembra ripetere, a qualche anno di distanza, l’operazione narrativa compiuta da Paolo Sortino con il suo romanzo Elisabeth (2011): questi ha dato spazio alla vicenda della diciottenne austriaca sequestrata e violata per anni dal padre e divenuta madre dei suoi stessi fratelli, Elisabeth Fritzl. Per il suo personaggio l’autore ha rivendicato una totale autonomia dalla cronaca: «Tra possibilità e scelta si muove ondivaga la totale libertà della mia Elisabeth e degli altri personaggi, per i quali ho inventato una vita che non vuole essere né migliore né peggiore di quella reale, ma solo possibile.» (Avvertenza al romanzo).
Tarabbia, da parte sua, servendosi della cronaca ha, dunque, inventato un mondo possibile e un personaggio ab-solutus anche nel senso etimologico di “sciolto”. Andrej-personaggio, erede contemporaneo degli io-narranti inattendibili e tragici del modernismo, è infatti altro dall’uomo che ci viene proposto nel web tra filmati di repertorio e ricostruzioni fattuali. Nelle pagine de Il giardino delle mosche si fa uomo supposto e ri-creato dall’invenzione narrativa e la costruzione di una personalità mutilata finisce col dirci qualcosa di più sul funzionamento psichico di un ordine dittatoriale solo in apparenza dissolto e liquidato.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento