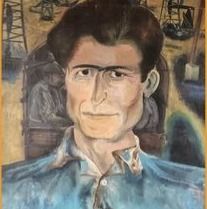
Le Labour narratives
È uscito di recente presso la casa editrice Peter Lang il saggio “Labour narratives” di Carlo Baghetti, di cui pubblichiamo un estratto. Ringraziamo l’autore e l’editore per la gentile concessione.
Le labour narratives, una serie di domande e una premessa
Ragionando sulle categorie appena analizzate e, allo stesso tempo, sulle varianti più ampie e accoglienti di “letteratura del lavoro” e di “nuova letteratura del lavoro” che servivano a segnare la differenza, in ambito italiano, tra la produzione del secondo dopoguerra (con i prodromi che vanno dalla fine dell’Ottocento agli anni Trenta) e la nouvelle vague che inizia dalla metà degli anni Novanta1, è emersa una domanda sempre più pressante, tendente a definire in modo più appropriato il limite in cui si può parlare di letteratura del lavoro, di letteratura sul lavoro o, più generalmente, di letteratura che tematizzi il lavoro e quando invece non fosse applicabile. Il lavoro, infatti, come dice Giorgio Falco «è ovunque»2, è onnipresente, è una presenza infestante che si mescola a ogni forma di racconto, a diversi livelli. La domanda allora diventa la seguente: a partire da che punto se ne deve rilevare la presenza, e a partire da che tasso di presenza si può iniziare a ricollegare un’opera all’ecosistema e all’arcipelago delle narrazioni sul lavoro? E poi, a un livello più generale, un principio quantitativo è adatto a definire il legame tra un’opera e una delle varie categorie finora evocate o sarebbe preferibile impiegarne uno qualitativo?
In via del tutto teorica siamo in presenza del tema lavorativo già quando un personaggio della diegesi si presenta indicando il proprio mestiere, oppure quando un narratore si riferisce e caratterizza un personaggio attraverso il suo habitus sociale, la sua professione oppure il suo grado gerarchico all’interno di una società che segue un ordinamento particolare, come può capitare nei romanzi russi analizzati da Luciano Vandelli nella sua sapiente ricostruzione della figura dell’impiegato pubblico attraverso la letteratura3. E questo senza considerare le sfumature interne al concetto stesso di lavoro a cui si è fatto riferimento in precedenza (per esempio la differenza fra un’attività “lavorativa” e un intrattenimento piacevole, un hobby); oppure come considerare quell’ampia zona grigia del lavoro non salariato, che si svolge volontariamente per accrescere le possibilità di riuscita professionale o involontariamente, producendo indirettamente valore attraverso le nostre azioni e le nostre attività online4; dobbiamo annoverare anche il lavoro “invisibilizzato”, come quello di cura o il lavoro riproduttivo5; o, ancora, quello svolto contro la propria volontà o in assenza totale di diritti6. Come cogliere questi segni all’interno delle opere? Bisogna trascurarli o tenerne conto? Oppure, in un caso di ancora più difficile classificazione: che fare dinanzi a descrizioni o dichiarazioni di personaggi che riflettono su alcuni valori-lavoro che hanno marcato un’epoca storica? Come comportarsi con le rappresentazioni di affidabilità, dedizione, disciplina, produttività, cooperazione, integrità, responsabilità, professionalità, e via di seguito, una volta incontrate in una rappresentazione culturale? Bisogna coglierli o ignorarli, sforzarsi di riportarli a un discorso più ampio oppure trascurarli?
Quella appena evocata è la difficoltà maggiore del campo di studio che vogliamo chiamare Labour narratives, di cui cercheremo di chiarire nei prossimi paragrafi i contorni (molto larghi), le finalità e le metodologie di studio. Prima però è necessaria una premessa che solo ad uno sguardo superficiale potrebbe sembrare scontata: accordiamo alla letteratura e alle altre rappresentazioni culturali – in particolare il cinema e le serie televisive, di cui non ci occuperemo qui direttamente ma che potrebbero, anzi dovrebbero, essere analizzate con gli stessi mezzi e la stessa attenzione7 – una profonda capacità “performativa”.
Questa capacità “performativa” implica la possibilità di influenzare il nostro modo di percepire la realtà, di modificare le categorie attraverso cui leggiamo il flusso degli eventi, non sulla base di un atteggiamento dai toni vagamente nostalgici che tenti di restituire alle rappresentazioni culturali un ruolo che – del resto – non hanno mai o solo raramente posseduto, al di fuori di ben determinati e ristretti circoli, ma considerando il loro potenziale narrativo di creazione di un discorso sul lavoro che circola e si propaga nella semiosfera all’interno della quale siamo tutti costantemente immersi. Il discorso acquisisce un senso particolarmente rilevante all’interno di una società dello spettacolo, che si struttura per narrazioni e fa dello storytelling una pratica connaturata alla propria essenza, ma la si vede operante anche in società più antiche e in cui le forme della comunicazione di massa fossero meno aggressive e onnipresenti e dove le rappresentazioni culturali fungevano da deposito delle narrazioni circolanti, cristallizzazione di un determinato discorso sociale. In qualità di deposito d’idee o come forza agente e performante dell’immaginario collettivo le rappresentazioni culturali sono un veicolo molto potente dell’ideologia e la mancanza di studi sistematici che analizzino la relazione con il lavoro risulta sorprendente e comprensibile solo di fronte alle difficoltà nell’approcciare una materia così vasta e dalle implicazioni così variabili.
Labour narratives: una categoria lasca
In virtù della grande diffusione del tema del lavoro in letteratura e della capacità che le narrazioni hanno d’influenzare l’immaginario collettivo, ci sembra necessario ridisegnare i contorni di un insieme di rappresentazioni culturali che possiamo genericamente qualificare come “labour narratives”: un insieme di storie, racconti, testimonianze, riflessioni, rappresentazioni che intrattengono con il lavoro un rapporto d’intensità variabile. Intendiamo le labour narratives come una categoria estremamente generica e lasca all’interno della quale rientrano testi che contengono una qualsivoglia rappresentazione del lavoro: un riferimento estemporaneo, una descrizione, la presenza di una categoria socio-professionale o di una riflessione metanarrativa su alcuni di quei valori-lavoro, ma anche narrazioni più strutturate, pensate e scritte per raccontare un preciso universo lavorativo, oppure dare voce a una precisa categoria socioprofessionale, ovvero quando il lavoro diventa perno centrale della narrazione. Tale categoria, in virtù della propria genericità, ci permette anche di superare quella sterile suddivisione delle rappresentazioni in base all’universo economico raccontato e così è possibile considerare una labour narrative tanto un racconto di fabbrica quanto la narrazione dell’universo impiegatizio; tanto il racconto del precario dalle diverse vite lavorative con la possibilità di variare i settori economici, quanto la rappresentazione del lavoro agricolo o di qualsivoglia altra forma di impiego.Come dicevamo, in questa sede cercheremo di tracciare i contorni di un approccio nuovo alla materia traendo i nostri esempi principalmente dalla letteratura, ma la categoria di labour narratives trascende e include al suo interno tutte le forme di rappresentazione e di discorso: dalla poesia al cinema, dal teatro alla musica, dalle serie tv alle rappresentazioni pittoriche, dalla fotografia al fumetto, e via di seguito, con l’ovvia implicazione che ogni linguaggio possiede i propri codici e la propria storia e che per farne un’analisi precisa la specificità del linguaggio dev’essere presa nella giusta considerazione scongiurando il grande avversario della critica di natura tematologica che è il “contenutismo”.
Solo in questo modo, cioè aprendo la categoria delle labour narratives a ogni forma di racconto che intrattenga anche una debolissima relazione con il tema del lavoro, possiamo aggirare l’ostacolo dell’arbitrarietà nella selezione dei corpora e il corrispettivo rischio di non includere o rilevare narrazioni che, per quanto periferiche, ci offrano una chiave di lettura importante per interpretare il cangiante rapporto che l’uomo contemporaneo intrattiene con la sfera della praxis.
Rendendo la categoria delle labour narratives così inclusiva, il campo di studi che viene a crearsi diventa sterminato e difficile da analizzare ed è qui che intervengono due nozioni e l’introduzione di alcune indicazioni metodologiche che possano facilitare il compito degli studiosi permettendo d’ordinare e analizzare le fonti discorsive individuate. Le due nozioni che proponiamo per ordinare l’eterogeneo e vasto campo di studi sono (1) quella d’“intensità” della narrazione e (2) quella d’“impatto”. Solamente la prima delle due verrà qui analizzata, essendo il vero e proprio oggetto di questo saggio, mentre l’altra, per il momento, ha un valore puramente indicativo e verrà ripresa, chiarita e approfondita in studi successivi. Così come in studi successivi verranno date indicazioni metodologiche per analizzare in maniera quantitativa e digitalizzata l’enorme quantità di testi che potrebbero potenzialmente essere inclusi nel terreno delle labour narratives.
Il principio d’“intensità” nelle labour narratives
Il concetto d’intensità va associato alla presenza e alla ricorrenza di quattro elementi che abbiamo potuto identificare all’interno delle labour narratives e possiamo suddividere in rispettive macroaree: la prima, riguarda la struttura della narrazione, poiché spesso le labour narratives presentano uno schema e una concatenazione di sequenze narrative simili che possono fungere da primo elemento di ricognizione; il secondo, consiste in alcune metafore ricorrenti che trasfigurano persone, tempi e spazi dell’universo lavorativo; il terzo, raccoglie dei topoi specifici a questo genere di racconti quali possono essere, per esempio, il momento del colloquio o dell’assunzione, la descrizione delle mansioni che il personaggio deve svolgere all’interno della diegesi, il momento del licenziamento o delle dimissioni, quello delle lotte, degli scioperi, delle manifestazioni e via di seguito. Sono momenti particolarmente importanti all’interno della sfera professionale e la loro presenza all’interno delle rappresentazioni culturali ha la medesima funzione di una spia che indica, da una parte, la presenza del tema lavorativo all’interno dell’opera che si sta analizzando, dall’altra l’afferenza di tale opere all’eterogenea categoria di labour narratives. Il concetto d’intensità è molto semplice e quasi lapalissiano: più fattori o spie sono presenti nel testo, più la rappresentazione analizzata presenta un’intensità elevata; viceversa, minori sono gli elementi nel testo, inferiore sarà l’intensità.
Il funzionamento del concetto d’intensità è di facile intuizione e presenta un’applicazione persino meccanica, mentre meno scontato è l’uso che se ne deve fare e soprattutto il modo in cui determiniamo gli elementi utili all’individuazione delle labour narratives. L’intensità ci serve a stabilire una prossimità della rappresentazione all’oggetto raccontato, quanto cioè il referente (il macroconcetto di “lavoro”) sia presente nel testo e come elementi precipui di esso finiscano direttamente nell’ingranaggio narrativo. Il funzionamento di un’opera culturale, sia essa letteraria o d’altra natura, non deve chiaramente essere ridotta alla riproduzione mimetica dell’oggetto che si vuole raccontare altrimenti l’operazione creativa sarebbe declassata a semplice descrizione dell’esistente mortificando l’aspetto più originale – in termini linguistici o d’invenzione di situazioni narrative – ma alla luce di un’analisi piuttosto accurata del vasto corpus di opere letterarie sull’argomento ci si rende facilmente conto che la capacità trasfigurativa e inventiva cede spesso il posto a un approccio narrativo più realistico e che concentra il potenziale creativo – laddove presente8 – su aspetti linguistici, nell’accuratezza delle descrizioni psicologiche o ancora nell’acuta decodifica dei processi umani e relazionali che si mettono all’opera nei vari universi lavorativi esplorati.
L’alta e bassa intensità di una labour narrative non indicano quindi la qualità della rappresentazione né una forma di legittimità all’interno di quello che potrebbe parere (ma non è) un genere letterario a sé stante9, ma unicamente la concentrazione di elementi tipici di questa tipologia di rappresentazioni culturali. Distinguere tra rappresentazioni ad alta e bassa intensità permette di utilizzare un criterio alternativo a quello degli elementi tematici (industriale, postindustriale, ecc.) per ordinare un corpus potenzialmente sterminato e far emergere una serie di testi – ma potrebbero essere film, serie tv, canzoni, ecc. – in cui il lavoro è l’oggetto principale della narrazione, una necessità resa ancora più urgente dalla vastità del campo di studio.
Dopo aver tratteggiato una rapida panoramica (integrata dalla bibliografia finale) dei vari studi che sono stati realizzati sulle produzioni letterarie che tematizzano il lavoro e aver giustificato la necessità della creazione di una categoria più ampia e in grado di accogliere rappresentazioni transmediali sul lavoro d’intensità diverse ci concentreremo adesso sull’analisi dei vari elementi mostrando attraverso delle analisi close reading, il loro funzionamento.
1 Abbiamo proposto questa suddivisione e categorizzazione in alcune conferenze, ma anche in Carlo Baghetti, Contemporary Returns to Questions of Industry and Labor, in Italian Industrial Literature and Films. Perspectives on the Representation of Postwar Labor, a cura di Carlo Baghetti et alii,Oxford, Peter Lang, 2021, pp. 207-218.
2 Intervista rilasciata da Giorgio Falco a Matilde Quarti, «Uso il lavoro per scrivere dell’Italia»: Giorgio Falco si racconta, in «Il Libraio» (15 novembre 2017), online://www.illibraio.it/giorgio-falco-intervista-685704/ (23/04/2024).
3 Luciano Vandelli, Tra carte e scartoffie. Apologia letteraria del pubblico impiegato, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 75: «L’importanza del ruolo burocratico è, in realtà, determinante. Al punto che spesso, per definire un personaggio, l’autore […] si affretta a precisarne il rango nella scala gerarchica. Quella scala rigidamente definita sin dai tempi di Pietro il Grande: dal consigliere di Stato effettivo, ai consiglieri onorari, poi giù ai consiglieri di collegio e di corte, sino ai segretari provinciali. Evidentemente, comunicare subito al lettore che Kovalëv, protagonista del grottesco Il naso, è un assessore collegiale, o che Akakij Akakevič, vittima nel surreale Il cappotto, è un consigliere titolare, consente a Gogol’ di risparmiare la descrizione di troppi elementi: la collocazione gerarchica già marca l’identità».
4 Antonio A. Casilli, En attendent les robots. Enquête sur le travail du clic, cit.
5 Sull’argomento ci permettiamo di rinviare a Représentations artistiques du travail des femmes, a cura di Manuela Spinelli, Carlo Baghetti, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2023.
6 Un riferimento imprescindibile è Alessandro Leogrande, Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Milano, Mondadori, 2008.
7 Sull’argomento è stata prodotta una buona quantità di studi. Un riferimento la produzione cinematografica del secondo Dopoguerra italiano è la sezione intitolata “Italian Industrial Film” contenuto in C. Baghetti, J. Carter, L. Marmo, Italian Industrial Literature and Film, cit., pp. 359-490. Un altro saggio utile per una prima ricostruzione del corpus filmico, stavolta su scala mondiale, è E. Di Nicola, La dissolvenza del lavoro. Crisi e disoccupazione attraverso il cinema, Ediesse, Roma, 2019. Per uno studio del cinema e, in particolare, del cinema documentario, si rimanda a P. Chirumbolo, Il gioco delle sedie. Saggi sulla narrativa e sul cinema italiano del lavoro nel ventunesimo secolo, Morlacchi, Perugia, 2022, pp. 125-236.
8 Vi è da dire, ed è il classico elefante nella stanza, che molta narrativa sul lavoro è di scarso interesse letterario, qui inteso soprattutto come riflessione sulla lingua e capacità inventiva. Come la critica letteraria citata ha mostrato in più sedi, l’interesse per questo genere di rappresentazioni è molto spesso contenutistico o per il suo valore politico di denuncia sociale, mentre sono pochi (soprattutto nella contemporaneità) quegli scrittori in grado di elaborare, anche su piano formale, una proposta creativa degna d’interesse.
9 Occorre forse precisare che per riconoscere un genere letterario sono necessari una serie di elementi ricorrenti, che possono essere di natura narrativa (il detective dei romanzi gialli, la rievocazione del passato nei romanzi storici, l’intreccio amoroso nei romanzi rosa, ecc.) o extra-narrativa e pensiamo in particolare a istanze di legittimazione quali premi letterari, filiere editoriali dedicate, una comunità distinguibile di lettori, riviste che promuovono analizzano dibattono diffondono opere appartenenti a un tale genere, incontri annuali incentrati sulle opere appartenenti al genere e iniziative simili. Il tentativo di perimetrare e riconoscere come genere letterario le labour narratives è votato al fallimento poiché la categoria include una tale varietà di opere che utilizzano una tale quantità di media e linguaggi differenti che è impossibile ridurre tale pluralità negli angusti limiti di un genere. Al contrario, e per ragioni principalmente commerciali e editoriali, il tentativo può essere compiuto per alcune sottosezioni delle labour narratives (quali la letteratura industriale, letteratura aziendale, la letteratura working class), che, come detto, sono etichette poco funzionali per la strutturazione del discorso critico, ma vedono, in anni recenti, fiorire alcune iniziative che mirano a un riconoscimento in qualità di un genere letterario ad alcune di esse. Si pensi al Festival di letteratura working class organizzato dalla casa editrice Alegre o alla collana “Working class” presente nella stessa casa editrice che promuove o traduce opere a sfondo lavorativo; si pensi ai premi letterari Di Vittorio e Biella entrambi attribuiti a opere di narrativa che raccontano il mondo del lavoro; in ambito cinematografico, si pensi al Working Title Film Festival giunto alla sua settima edizione nel 2024 e l’elenco potrebbe continuare soprattutto prendendo in considerazione realtà culturali non italiane.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
 Appunti sul classico in Eros il dolceamaro di Anne Carson
Appunti sul classico in Eros il dolceamaro di Anne Carson -
 Oltre Ernaux, una questione di determinismo sociale
Oltre Ernaux, una questione di determinismo sociale -
 Canone del Novecento e manuali scolastici
Canone del Novecento e manuali scolastici -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
 Inchiesta sulla letteratura Working class /7 – Emiliano Pagani
Inchiesta sulla letteratura Working class /7 – Emiliano Pagani -
 Casalinghitudine. Un libro di Clara Sereni
Casalinghitudine. Un libro di Clara Sereni -
-
La scuola e noi
-
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
 Sparare a zero dalla torre d’avorio: La fabbrica dei voti di Corsini
Sparare a zero dalla torre d’avorio: La fabbrica dei voti di Corsini -
 Per una didattica dell’utopia
Per una didattica dell’utopia -
 Scuola e Gnac
Scuola e Gnac -
-
Il presente e noi
-
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
 Ancora sull’egemonia
Ancora sull’egemonia -
 Un intervento alla radio e l’Educazione civica a scuola
Un intervento alla radio e l’Educazione civica a scuola -
Commenti recenti
- Enrica Maria Pavanello su Perché leggere “I giorni veri. Diario della Resistenza” di Giovanna ZangrandiCome Sezione Cai di Cesena stiamo organizzando in occasione dell’8 marzo una serata in cui…
- Orsetta Innocenti su Perché leggere Apeirogon di Colum McCannHo trovato le domande sollevate dal commento molto interessanti. Anche io non ho risposte (e…
- Gabriele Cingolani su Perché leggere Apeirogon di Colum McCannGrazie Stefano, per questo commento. Le domande che ti fai me le sono fatte anche…
- Stefano Casulli su Perché leggere Apeirogon di Colum McCannArticolo davvero molto bello, che si unisce alle parole che ho già ascoltato di Gabriele…
- Eros Barone su Ancora sull’egemoniaI politologi borghesi, cercando di spiegare la lunga durata del governo Meloni, sono ricorsi al…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento