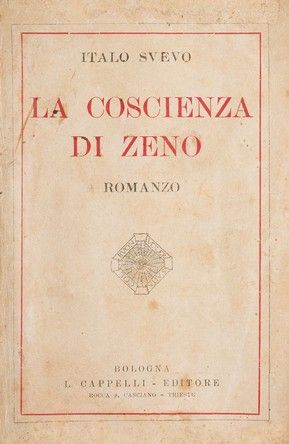
Perché Zeno si chiama Zeno? Svevo e un romanzo dimenticato
Dal 1 agosto verranno ripubblicati alcuni interventi usciti nel corso del 2015. La pubblicazione di inediti riprenderà il 1 settembre. Questo articolo è apparso il 9 settembre 2015.
Cosa significa il nome Zeno? Perché Svevo ha deciso di chiamare così il protagonista del suo romanzo più famoso? La domanda può sembrare oziosa, ma forse lo è meno di quanto sembri, se pensiamo – ad esempio – all’esplicito gioco di contrasti fra la Z di Zeno e le A delle donne di casa Malfenti, Ada, Augusta, Alberta e Anna: «Quell’iniziale mi colpì molto più di quanto meritasse. Sognai di quelle quattro fanciulle legate tanto bene insieme dal loro nome. […] Io mi chiamo Zeno ed avevo perciò il sentimento che stessi per prendere moglie lontano dal mio paese» (La coscienza di Zeno, in Romanzi e «continuazioni» [d’ora in poi RC], a cura di N. Palmieri e F. Vittorini, Milano, Mondadori, 2004, p. 693). Ad ogni modo, la scelta onomastica compiuta da Svevo non si spiega solo con il potere evocativo dell’iniziale, né – come pure è stato ragionevolmente proposto – con la vicinanza al greco xenos ‘straniero’; un ruolo ancora più decisivo va attribuito, con ogni probabilità, all’influenza di un romanzo oggi dimenticato, e mai accostato in modo sistematico alla narrativa sveviana.i
Per uno scrittore della generazione di Svevo, era di fatto impossibile non imbattersi nelle opere di Ugo Ojetti (1871-1946) – romanziere, critico d’arte, giornalista (nonché per un breve tratto direttore) del «Corriere della Sera», e soprattutto figura onnipresente nella vita culturale italiana tra fine Otto e inizio Novecento (tanto che Piero Gobetti, dando voce a un’insofferenza diffusa, lo definì «insuperabile nella magra arte di arrivare»). Nel 1898, lo stesso anno di Senilità, Ojetti pubblicò un romanzo intitolato Il vecchio: la trama verte sulla vita familiare di Alessandro Zeno, un anziano senatore assillato dall’idea della morte, e impegnato a costruire un’immagine di sé che risulti tollerabile alla propria coscienza.
Il lavoro fu ricevuto con una certa curiosità, come dimostrato dalle recensioni di Pirandello («Ariel», 27 febbraio) e Capuana («Roma Letteraria», 25 aprile), ma – come anticipato – fu presto dimenticata; anche per questo motivo, la sua influenza su Svevo non è mai stata debitamente riconosciuta. Eppure le somiglianze non si limitano certo al nome del protagonista; sono anzi molto più numerose, e riscontrabili ad apertura di volume. Ad esempio, il monologo di Emilio Assueti (un amico di Alessandro Zeno) sui danni causati dal progresso tecnologico ricorda da vicino le riflessioni di Zeno nel finale della Coscienza:
Ma la scienza è l’occupazione più brutale, più bassa, più dannosa tra tutte le occupazioni dell’uomo. […] L’uomo è un animale sensuale come tutti gli animali; la scienza sviluppa il cervello, organo inutile, a danno degli organi utili che noi abbiamo in comune con le bestie. (Ugo Ojetti, Il vecchio, Milano, Galli, 1898, p. 179)
[La salute] non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. […] Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. (RC 1084)
Fra le tante altre corrispondenze con il terzo romanzo di Svevo, mi limito qui a segnalarne due. La prima, microscopica, riguarda l’uso enfatico da parte di Ojetti di un termine chiave come «coscienza»: «Per un attimo fuori di questa misera persona egli si liberò vivendo orgoglioso nell’altra. Fu un attimo di coscienza» (Il vecchio, 346, corsivo dell’autore). La seconda riguarda l’egoismo patologico del protagonista, che anche di fronte a un amico malato sente il bisogno di affermare la propria superiorità: «Alessandro Zeno si rammentò che il ministro aveva cinque anni più di lui e soffriva di un cardiopalma prima o poi mortale, e lì per lì avrebbe voluto rammentarglielo per affermare una sua certa superiorità» (Il vecchio, 51). Il lettore di Svevo ricorderà, a questo punto, l’atteggiamento meschino tenuto da Zeno Cosini nei confronti del Copler, affetto da nefrite cronica: «La sua parola sembrava quella di un sano ed io – voglio essere sincero – ne soffersi. […] [Augusta] non era neppur convinta ch’io credessi d’esser ammalato, perché altrimenti non avrei avuto tanta gioia di vivere. Così il Copler ritornò allo stato d’inferiorità cui era condannato» (Coscienza, RC 802).
Anche tenendoci al materiale raccolto finora, sembra lecito pensare a una parentela diretta tra Alessandro Zeno e Zeno Cosini. A rafforzare questa ipotesi contribuiscono, poi, le abbondanti analogie tra Il vecchio e altre opere sveviane: la lista sarebbe lunga, ma riporterò qui solo alcuni esempi, che riguardano due testi fondamentali dell’ultimo Svevo – le cosiddette «Continuazioni» (vale a dire il quarto e ultimo progetto romanzesco, redatto tra 1927 e 1928), e il racconto Vino generoso (la cui versione definitiva risale al 1926-’27).
Le convergenze con il primo dei due testi sono in effetti numerose, a partire dalla composizione della famiglia del protagonista: proprio come quello di Svevo, lo Zeno di Ojetti ha un figlio pittore (Andrea, che corrisponde all’Alfio sveviano), una figlia (Luisa/Antonia), un genero (Giorgio/Valentino), un nipotino (Gino/Umbertino); specialmente il rapporto con Andrea, e con il suo mestiere di artista, verrà ripreso fedelmente da Svevo. Al pari di Zeno Cosini, ad esempio, Alessandro Zeno «non aveva mai approvato la professione del figlio, che non dava guadagni stabili»: «molte volte lo aveva esortato a tentare un concorso per qualche cattedra d’arte, così da poter fidare sopra un salario certo; ma Andrea si era sempre ribellato, perché in ogni occupazione fissata dalla volontà altrui vedeva una mortificazione del proprio ingegno» (Il vecchio, 97-98). Nelle «Continuazioni», la situazione è identica:
[Alfio] abbandonò il Ginnasio subito dopo la riforma Gentile che poco gli si confaceva ed io non protestai con una sola parola. Gli dissi solamente che così egli perdeva la possibilità di acquistare un rango accademico, con tono un po’ commosso; perdevo anch’io una speranza. Gli parve un’intromissione inammissibile e disse che fra me e lui c’era non solo una differenza d’età ma molto di più. (RC 1122)
[Alfio] non aveva nessuno che gl’insegnasse, per paura che un maestro riuscisse a falcidiare la sua personalità. (RC 1127)
La natura ribelle del figlio, d’altra parte, suscita pensieri simili in entrambi i padri: «Quel che di nobile, di libero, di umano era in Andrea non dal bruto atto generativo gli era venuto, ma dal suo indipendente sviluppo […]. Come poteva esser derivato da lui, tutto da lui quel giovane ribelle, irriverente, così dissimile?» (Il vecchio, 167-68); «Dove era andato a fornirsi di quella sua pittura, e di quella sua solitudine? La personalità? Io che avevo invano tentato di somigliare agli altri non ci avevo mai pensato. La ribellione? Quando ne sentii il desiderio me ne pentii subito» (RC 1127-28).
Più circoscritto, ma sempre degno di nota, è il legame con Vino generoso. L’episodio cruciale del racconto di Svevo è il sogno dell’anziano protagonista, descritto nelle pagine conclusive: «[mi trovai] in una grotta vastissima, rozza, […], oscura, nella quale io sedevo su un treppiedi di legno accanto ad una cassa di vetro, debolmente illuminata di una luce che io ritenni fosse una sua qualità» (RSA 142). La cassa si rivela presto un «ordigno» al servizio di un rito sacrificale: la terza persona che vi si sdraierà sarà la vittima. In preda al terrore, il vecchio invoca il nome della figlia, perché prenda il suo posto nell’ordigno: si sveglia quindi urlando «Emma, Emma», atto erroneamente interpretato dalla moglie (con un malinteso simile ad alcune scene del romanzo di Ojetti) come un segnale di affetto paterno.ii
È molto probabile che le pagine di Vino generoso si ispirino a una lunga sequenza onirica del Vecchio, che precede di poco il suicidio finale del protagonista. Viaggiando «a piedi nudi per un paese montano», Alessandro Zeno scorge «gruppi di uomini giovani e di amabili donne che giacevano e cantavano e ridevano e si baciavano»; poco dopo si trova però da solo, di fronte a una «grotta oscura e paurosa»:
Finalmente sentì la meta. Si slargava la gola in un pianoro recinto da abeti, e di tra gli abeti si intravvedeva una grotta oscura e paurosa come una fauce. Là dentro egli sentì il Nemico, e vi corse in un ultimo slancio, non curando il lancinar delle piaghe più e più squarciate dalle pietre aguzze. […] Quanto tempo camminò nelle grotte? Sul terreno umido e sabbioso le pene dei piedi lacerati si addolcivano. […] Egli provò più curiosità che odio per colui che nel fondo ventre della montagna lo attirava. Vide un chiaror giallo fuor da una largura ed entrò. Steso sopra un letto di roccia era un corpo sotto una coltre lilla, e in fondo sopra un’eminenza ardevano due candele che gocciavano e fumigavano […]. Dopo un attimo di sorpresa egli si avanzò con brevi gesti recisi, quasi un’altra volontà lo movesse meccanicamente, e alzò la coltre. Allora il vecchio vide il suo stesso cadavere. Egli era a se stesso il nemico più acre! (Il vecchio, 373-74; corsivo dell’autore)
La grotta buia, il «chiarore» proveniente dal letto di roccia, l’immagine funerea sono indubbi punti di contatto con il testo sveviano. Pochi capitoli prima, del resto, una riflessione del protagonista evocava l’idea del banchetto e della vittima sacrificale, in stretta relazione con il rapporto fra giovani e vecchi: «Io morrò per segnare il trionfo e la festa dei sopravvenenti. C’è gaudio di alcuno senza dolore d’altri? C’è banchetto senza ecatombe di selvaggina e di erbe e di grani? […] C’è giovinezza se non sopra i cadaveri?» (Il vecchio, 304).
La lista delle somiglianze potrebbe continuare, in riferimento anche ad altre prove sveviane (come La novella del buon vecchio e della bella fanciulla); ma già a partire dai pochi appunti presentati qui sopra, è evidente che il romanzo di Ojetti sia stato un modello fondamentale per Svevo, dalla Coscienza in poi. Il che ci porta a riflettere, una volta di più, su una risaputa questione di metodo: a cosa serve conoscere la «fonte» di un testo? davvero una simile consapevolezza può aiutarci a comprendere e valutare meglio un’opera letteraria?
Nel nostro caso, l’analisi intertestuale riesce utile per almeno due motivi, tra loro collegati. In primo luogo, essa ci rivela un nuovo aspetto del contesto culturale in cui ebbe origine la grande stagione dei «vecchioni» o «vegliardi» sveviani (dalla Coscienza alle «Continuazioni», passando appunto per racconti come Vino generoso o La novella del buon vecchio): in altre parole, il confronto con Il vecchio ci dà un’idea più precisa di quanto ci sia di assolutamente innovativo nella figura di Zeno Cosini, e quanto invece entri in dialogo con un codice già esistente. In secondo luogo, l’originalità della narrativa sveviana è tutt’altro che sminuita da un simile confronto: al contrario, quest’ultimo non fa che evidenziare la distanza tra un’opera modesta, qual è in fondo quella di Ojetti, e un classico come la Coscienza.
Nel Vecchio, infatti, tutto è fin troppo esplicito e univoco: i conflitti interiori del personaggio – che soffre per il suo stesso incurabile egoismo, reso ancora più grave e scabroso dalla senilità – sono resi attraverso monologhi enfatici e melodrammatici, e conducono a un esito artificioso ed eccessivo rispetto alle premesse (il suicidio del protagonista). Inoltre, il giudizio dell’autore sul personaggio è chiaro fin dall’inizio, e si attiene a rigidi criteri morali. A ragione Capuana, nella sua recensione al romanzo, criticava Ojetti per l’«inopportuna serietà» e la «voluta gravità nella scelta del soggetto e dei mezzi per svolgerlo» (Cronache letterarie, Catania, Giannotta, 1899, p. 268).
In Svevo, al contrario, il pathos è disinnescato anzitutto dall’atteggiamento del personaggio, che aggira ogni possibile crisi di coscienza grazie agli strumenti dell’ironia e della flessibilità morale – strumenti ambigui, perché da una parte si rivelano utili (se non necessari) alla sopravvivenza, mentre dall’altra si avvicinano all’ipocrisia e alla malafede. L’ambiguità non viene certo risolta dal giudizio dell’autore, che anzi è contraddistinto, a sua volta, da quella che Wayne Booth ha definito unstable irony: «nessuna ricostruzione stabile può nascere dalle rovine svelate da questo tipo di ironia; l’autore – per quanto lo possiamo conoscere, che è spesso molto poco – si rifiuta di prendere posizione, non importa quanto sottilmente».iii In ultima analisi, la distanza tra Alessandro Zeno e Zeno Cosini illustra in modo emblematico una metamorfosi epocale nella storia del romanzo europeo: dalle convenzioni del realismo ottocentesco (che Ojetti ripropone in forma stereotipata) al nuovo paradigma della narrativa modernista, in cui la verità tende a darsi solo in termini turbati e instabili.
i Un breve riferimento al Vecchio si trova in John Gatt-Rutter, Italo Svevo: A Double Life, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 159. L’unica altra occorrenza nella critica sveviana si deve a Clotilde Bertoni, che riconosce un’allusione al romanzo di Ojetti in un passo della Novella del buon vecchio, pur limitandone l’importanza: «Di tono patetico abbastanza convenzionale, il romanzo non può essere considerato modello di questo racconto (fra l’altro, il motivo dell’avventura amorosa vi compare appena, e solo come tentazione impossibile); va notato comunque che il protagonista è designato spessissimo come “il vecchio”; che, come il personaggio di Svevo, si ammala di angina; e che, particolare non privo di interesse, si chiama Alessandro Zeno» (C. Bertoni, Apparato genetico e commento, in Svevo, Racconti e scritti autobiografici [d’ora in poi RSA], a cura di C. Bertoni, Milano, Mondadori, 2004, p. 1183). Per un resoconto più dettagliato cfr. ora A. Godioli, Laughter from Realism to Modernism: Misfits and Humorists in Pirandello, Svevo, Palazzeschi, and Gadda, Oxford, Legenda, 2015, pp. 67-72.
ii «Mi domandò: “Hai sognato?”. E poi, commossa: “Invocavi tua figlia. Vedi come l’ami?”» (RSA 146). Cfr., ad esempio, il modo in cui i figli fraintendono l’insonnia di Alessandro Zeno, dopo la morte della moglie: «Egli si accorse della verità ridicola. “Essi si illudono che tutta la notte io abbia sofferto per la morte di Nannetta; non sanno da quale egoismo io sia stato contorto e abbattuto”» (Il vecchio, 79).
iii Wayne Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago, Chicago University Press, 1974, pp. 240-41 (traduzione mia).
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
- Che cosa resta da fare a noi insegnanti di letteratura
- Il Modernismo. Seminari di aggiornamento
- Il «buffo» deriso: variazioni su un tema tra realismo e modernismo
- Il Novecento modernista (risposta pubblica a una domanda privata di un insegnante)
- Intervista di Filippo La Porta a Romano Luperini. Che cos’e’ la letteratura oggi?
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento