
Figure della Storia. Menzogna e reticenza nella prosa di W.G. Sebald
Una domenica di novembre di qualche anno fa, nel giorno consacrato ai morti, preso da un’inquietudine inspiegabile, decisi di fare una deviazione, proseguendo verso Ponte Pietra e abbandonando momentaneamente l’idea di visitare il cimitero monumentale, relegato al suo silenzio nella parte orientale della città.
Un colto viaggiatore ha visitato questi luoghi all’inizio degli anni Ottanta, soffermandosi ad ammirare la delicata favola di San Giorgio e la principessa, l’affresco che orna l’arco della cappella Pellegrini. Il tempo sembra essersi fermato: i volti e corpi umani sono come incantati da un sortilegio che li rende immobili, incomunicabili; le figure animali – rese con perfetta cura anatomica – contrastano con la malinconica visione della città tardogotica, addormentata nell’oscurità dello sfondo.
L’anonimo protagonista di una delle quattro prose di Vertigini è uno studioso d’arte in viaggio All’estero per delle vaghe «ricerche sul Pisanello».
Ciò che mi affascina in lui non è solo la sua arte realistica, […] ma anche il modo in cui gli riesce di far germogliare quest’arte su una superficie di fatto inconciliabile con il realismo pittorico e nella quale viene accordato a ogni cosa – ai protagonisti e alle comparse, agli uccelli in cielo, all’inquieto bosco verdeggiante e a ciascuna singola foglia – il medesimo diritto all’esistenza, da nulla sminuito.

In un frammento dell’affresco due impiccati sono ritratti nel momento in cui i loro corpi, più simili a fantocci che a figure umane, pendono dalla forca: hanno perso qualsiasi tragicità, relegati nell’oblio della loro morte.
Sembra accorgersi di loro soltanto uno dei cavalieri in partenza, il cui volto è deformato in un’espressione angosciante di sofferenza, una di quelle «formule di pathos» attraverso le quali, secondo Aby Warburg, si esprimono le polarità opposte dell’emozione umana: estasi e malinconia, vicinanza e distanza dagli oggetti. Queste formule hanno una vita postuma, sopravvivono alla loro epoca ripresentandosi come costanti dell’espressione in altre epoche storiche, migrando tra i continenti. Dal gruppo scultoreo del Laocoonte all’incisione in rame realizzata attorno al 1465 da un anonimo maestro ferrarese, dalle guerre marine della bottega del Mantegna alla Morte di Orfeo di Albrecht Dürer, l’uomo ha sempre tentato di fissare in un’espressione patetica il sentimento della distruzione, della sofferenza di fronte alla caducità.
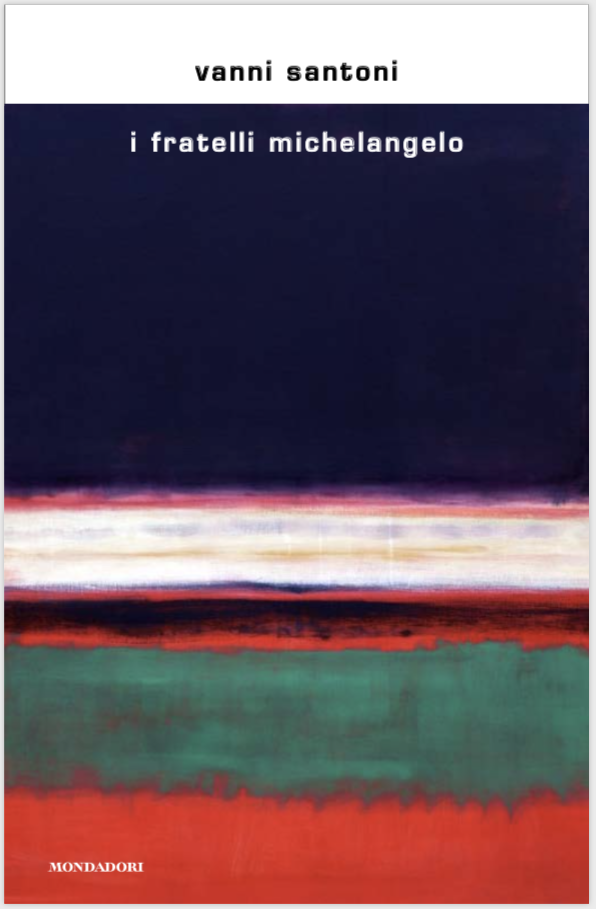
L’attenzione al frammento e al dettaglio è una delle caratteristiche peculiari della prosa di W.G. Sebald: emigrato in Inghilterra alla metà degli anni Sessanta, Sebald è il più rilevante scrittore europeo tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Nel programmatico rifiuto dei confini tra generi e arti, la prosa iconografica dell’autore tedesco fonde saggio e romanzo, biografia e racconto di viaggio, in una rilettura del tutto singolare della civiltà letteraria europea. Tra le pagine di Sebald prendono vita le biografie di scrittori, filosofi, personaggi storici e uomini qualunque: se Vertigini accoglie soprattutto vite di uomini illustri (Stendhal, Walser, Kafka), in Gli emigrati i protagonisti sono figure come il medico Henry Selwyn o l’insegnante Paul Bereyter. Nel pellegrinaggio in East Anglia, il narratore di Gli anelli di Saturno incontra e dialoga con uomini come William Hazel, il giardiniere della tenuta Sommerleyton, una di quelle figure popolari – prese sul serio al punto da attribuirgli una stilizzazione linguistica – che dialogando con il narratore attivano la memoria dei luoghi, il ricordo dei bombardamenti tedeschi sull’East Anglia durante la seconda guerra mondiale. Al passato che attraversa le voci dei testimoni si intreccia il presente dell’enunciazione, dove la voce del narratore intreccia i fili della storia, proiettandola verso il futuro del lettore.
Ai dialoghi e agli incontri si alternano digressioni saggistiche, riflessioni sulla natura e sull’arte, fotografie e immagini-commento che interrompono la progressione lineare del racconto, divagazioni erudite che spaziano dai dipinti di Rembrandt alle architetture monumentali. Nell’affabulazione del discorso, nel costante rinvio di un motivo all’altro, si rifrangono i pensieri, le impressioni, le note di viaggio del pellegrino. Il narratore comincia a raccontare a partire da un’esperienza diretta, un’esperienza storicamente tracciabile che ben presto diventa inspiegabilmente sinistra e angosciante.
A quel tempo – si era nell’ottobre del 1980 – avevo lasciato l’Inghilterra, dove vivevo ormai da quasi venticinque anni in una contea per lo più gravata da una cappa di nuvole grigie, ed ero partito per Vienna, nella speranza che, sotto nuovi cieli, sarei riuscito a superare un periodo piuttosto difficile della mia vita. (All’estero, in Vertigini)
Prima dei ventidue anni non mi ero mai allontanato da casa per più di cinque o sei ore di viaggio in treno e perché, quando nell’autunno del 1966, dopo aver soppesato la cosa, decisi di trasferirmi in Inghilterra, non avevo che una vaga idea di come sarebbe stato lassù e di come, dovendo far conto solo su me stesso, me la sarei cavata in un paese straniero. […] Mentre oggi, in un’epoca in cui si è per lo più pigiati in mezzo a una moltitudine di gente ed esasperati dalle continue premure del personale di bordo, io vengo colto spesso da una paura del volo quasi incoercibile, quella volta l’attraversamento regolare dello spazio aereo immerso nella notte suscitò in me un senso di profonda fiducia che, ormai lo so, era ingiustificata. (Max Ferber, in Gli Emigrati)
Nell’agosto del 1992, quando la canicola cominciò ad allentarsi, intrapresi un viaggio a piedi attraverso la contea di Suffolk in East Anglia con la speranza di sfuggire al vuoto che si stava diffondendo in me dopo la conclusione di un lavoro piuttosto impegnativo. (Gli anelli di Saturno)
Nel settembre dello scorso anno, durante una vacanza di due settimane in Corsica, mi spinsi una volta, a bordo di un autobus di linea azzurro, giù per la costa occidentale fino ad Ajaccio, per girovagare in quella città, della quale altro non sapevo se non che aveva dato i natali all’imperatore Napoleone. (Breve escursione ad Ajaccio, in Le alpi nel Mare)
Nella seconda metà degli anni Sessanta mi recavo di frequente, in parte per motivi di studio, in parte per altre ragioni a me stesso non ben chiare, dall’Inghilterra al Belgio, a volte solo per un giorno o due, a volte per parecchie settimane. […] Già all’arrivo, mentre sferragliando il treno avanzava lentamente sotto la volta buia della stazione, dopo aver attraversato un viadotto dalle strane torrette a guglia su entrambi i lati, fui subito colto da un senso di malessere che […] non mi avrebbe più abbandonato. (Austerlitz)
Queste storie sembrano aprirsi sempre nella stessa tonalità: un narratore anonimo, ambiguamente riconducibile all’autore, evoca il ricordo di un viaggio, di un’esperienza vissuta con angoscia, di cui non sappiamo nient’altro al di là delle coordinate spazio-temporali, riferite con millimetrica precisione. La formularità di questi incipit eredita la lunga tradizione del contratto di lettura, uno stilema che dai mémoires sei-settecenteschi migra verso il più moderno patto autobiografico. Se nelle Confessions Rousseau dice di volersi mostrare «in tutta la verità della natura», nel tentativo di convincere il lettore dell’assoluta sincerità del racconto, alla fine del XXI secolo Sebald si serve della menzogna e della reticenza per mettersi sulle tracce di una natura declinata in rovina, nel tentativo di raccontare – attraverso frammenti radianti, connessi tra loro per via analogica – la perversione della ragione umana nella lunga durata della modernità.
La figura pubblica dell’autore (critico letterario e accademico con pubblicazione scientifica) e la fisionomia degli anonimi narratori autorizza il lettore a comparare biografia reale e fittizia, specialmente perché la scelta dell’anonimato mira a un effetto di calcolata ambiguità. Le attestazioni documentarie, che attraversano tutta l’opera di Sebald, sfruttano la forza autenticante delle immagini, come ulteriore prova di verità. All’estero include fogli d’agenda con annotazioni, date e riferimenti a luoghi visitati durante il racconto, biglietti d’ingresso a musei, pagine di giornale, addirittura un foglio con una dichiarazione di denuncia e un passaporto che reca l’immagine dell’autore: entrambi i documenti, in corrispondenza del nome e del volto di Sebald, sono segnati da una lunga striscia nera, una macchia che ne oblitera una parte. Queste intrusioni d’autore inscrivono il testo in uno spazio ambiguo: rompendo l’identità di nome (nell’autobiografia autore, narratore e personaggio tipicamente coincidono) chiedono al lettore di sospendere l’incredulità e di credere alla sincerità del racconto. Menzogna romanzesca o sincerità autobiografica?
Al momento dell’enunciazione, quando ricostruiscono a posteriori esperienze vissute precedentemente in modo delirante e paranoico, i narratori sebaldiani sono geometrici, deduttivi, analitici. Nel racconto invece sono ossessionati da figure perturbanti e immaginarie, spesso la percezione dei fenomeni è esasperata, caricata iperbolicamente al modo di Robert Walser:
Spesso avevo la sensazione – probabilmente perché troppo stanco – di vedere qualcuno di mia conoscenza che camminava davanti a me. In queste allucinazioni – altro infatti non erano – si trattava esclusivamente di persone alle quali non pensavo più da anni, per così dire passate ad altra vita. E anche di quelle che di sicuro in vita non lo erano più, come Mathild Seelos e Fürgut, lo scrivano del paese dal braccio monco. Una volta, nella Gonzagagasse, credetti perfino di ravvisare Dante, il poeta esiliato dalla sua città natale sotto la minaccia d’essere messo al rogo. Alto un po’ più degli altri passanti, che tuttavia lo ignoravano, e con in testa il suo celebre cappuccio, mi precedette per un buon tratto di qualche passo, ma non appena accelerai nel tentativo di raggiungerlo, svoltò nella Heinrichsgasse, e quando fui all’angolo era sparito. Dopo simili crisi cominciò a manifestarsi in me una vaga inquietudine, che si traduceva in sensazioni di nausea e di vertigine.

Il viator gira alla cieca per la città, una Vienna eterea in cui, in modo del tutto illogico, gli risulta impossibile salire su un mezzo pubblico o parlare con qualcuno che non sia un di quelle «tre o quattro persone di cui magari avrei voluto sentire la voce», se solo queste non risultassero irraggiungibili. La peregrinazione diventa delirio e progressivo scollamento dalla civiltà: «Presi a trascinarmi dietro, in una borsa di plastica portata con me dall’Inghilterra, gli oggetti più inutili; oggetti d’ogni genere, da cui – senza che volessi ammetterlo – mi riusciva giorno dopo giorno sempre più difficile separarmi». Da questa condizione di profonda malinconia, di incapacità di accettare la perdita, il narratore si risveglia solo quando, ritornato in albergo, si accorge delle «scarpe scalcagnate», la cui vista gli scatena altri ricordi angosciosi, in una progressiva perdita di coscienza che lo porta ad addormentarsi «in un sonno profondo e senza sogni»; al suo risveglio crede di aver attraversato «un’ampia distesa d’acqua», e decide del tutto irrazionalmente di partire per Venezia.
Durante il secondo soggiorno a Balbec, nel celebre episodio delle intermittences du coeur, il narratore della Recherche si sfila le scarpe prima di addormentarsi, ma non appena compie il gesto quotidiano che molte altre volte prima di allora ha compiuto, il ricordo doloroso della morte della nonna lo investe turbandone il sonno. Quando si addormenta, stremato dal dolore, sogna l’impossibilità di raggiungere la nonna: nel sogno si rifrange soggettivamente la scoperta che ha fatto da sveglio, la percezione sensoriale che attiva il ricordo disvela un senso altrimenti corroso dall’abitudine: «ho ritrovato in un ricordo involontario e completo la realtà vivente».
Niente di tutto questo in Sebald, dove la memoria individuale vacilla e i sogni non rivelano nessuna verità; prima del viaggio a Venezia, il protagonista del racconto sebaldiano visita il poeta Ernst Herbeck, affetto da schizofrenia: le allucinazioni costringono il narratore al viaggio e al dialogo con l’Altro, con il diverso, con il folle, nel tentativo di restituire il senso attraverso il confronto con una memoria intersoggettiva e non più individualizzata alla maniera modernista. Il nostro è il tempo della colonizzazione dell’inconscio e del dominio dell’immaginario: nessuna autenticità proviene dalla memoria involontaria, nessuna estasi nella fugacità dell’attimo, nessuna verità esperienziale si cela nel ricordo d’infanzia. Queste realtà non hanno più niente di auratico e singolare, sono riproducibili e costantemente riprodotte nella pubblicità e nei prodotti d’intrattenimento di massa: un velo di oblio, la delicata illusione di credersi irripetibili.

Jacques Austerlitz è l’uomo dell’oblio, l’ebreo praghese, il professore di architettura che crede di essere Daffyd Elias, figlio di un pastore protestante che lo ha adottato durante la seconda guerra mondiale, quando la vera madre – deportata nel campo di concentramento di Theresienstadt – lo ha messo in salvo su un Kindertransport, uno dei mezzi di fortuna usati per mandare i bambini in Europa. La scoperta del nome avviene in modo piuttosto insolito: prima degli esami di maturità il giovane Elias viene convocato dal direttore della scuola, che gli comunica piuttosto freddamente di firmare i documenti d’esame come Jacques Austerlitz. «A disorientarmi più di tutto, sulle prime, fu che alla parola Austerlitz non associavo assolutamente nulla. […] Austerlitz non lo avevo mai sentito prima e perciò, fin dall’inizio, maturai la convinzione che, tranne me, nessuno si chiamasse così». Quando prova a connettere il proprio nome a qualcosa di noto, una prima connessione è suggerita fortuitamente dalla radio: «sentii lo speaker dire proprio in quel momento che il vero nome di Fred Astaire, a me fino allora assolutamente ignoto, era appunto Austerlitz». Il seguito del frammento racconta la biografia del padre dell’attore di Broadway, si descrive il suono dei vagoni merci che vanno e vengono dalla stazione di smistamento della città, invadendo con il loro fragore l’ambiente domestico: «Quel rumore di convogli in manovra, che non smetteva mai, neanche di notte, e l’idea a esso sottesa di partire in treno per lontane destinazioni erano l’unico ricordo della sua prima infanzia, pare abbia detto una volta Astaire».
Al narratore della Recherche basta pronunciare i nomi delle città sognate per farle diventare realtà della coscienza: «Per farli rinascere, ora, mi bastava pronunciare quei nomi: Balbec, Venezia, Firenze, dentro i quali aveva finito con l’accumularsi il desiderio ispiratomi dai luoghi ch’essi designavano.». Il potere evocativo dei nomi, la natura puntiforme e individuale della memoria involontaria, trasforma l’immagine mentale delle città, apre ad altre temporalità storiche, come al sogno di una Balbec medievale e gotica, la cui immagine mitica è destinata a crollare solo dopo che il narratore avrà fatto esperienza della fatuità dei rituali aristocratici.
Austerlitz invece non riesce a riconnettere il suono dei vagoni merci e il souvenir d’enfance di Fred Astaire alla propria memoria soggettiva, al trauma della separazione dai genitori, al viaggio in treno che lo ha condotto in Inghilterra. I ricordi hanno perso il loro carattere di singolarità irriducibile: un personaggio della cultura pop americana e Laura Austerlitz, una sconosciuta testimone dei crimini perpetrati nella risiera di San Sabba, occupano la stessa pagina, la stessa porzione di ricordo risvegliato meccanicamente dalla riproduzione radiofonica, un motivo ricorrente e sempre associato al ricordo. Farsa e tragedia, consumo e violenza, cultura e barbarie sono tessere che compongono uno stesso mosaico. Queste disfonie portano Austerlitz ad un progressivo isolamento e al rifiuto di affrontare il suo passato:
Così, anche se oggi mi appare inconcepibile, non sapevo niente della conquista dell’Europa da parte dei Tedeschi, dello Stato schiavistico che avevano instaurato, e niente della persecuzione alla quale ero sfuggito […]. Per me il mondo si era concluso con la fine del XIX secolo. Oltre non osavo avventurarmi, benché, in fondo, l’intera storia dell’architettura e della civiltà nell’epoca borghese, cui dedicavo i miei studi, corresse verso quella catastrofe che già allora andava profilandosi.
Quando il giovane Jacques chiede ulteriori delucidazioni al direttore Penrith-Smith, questi lo rimanda alla località della Moravia in cui è avvenuta la celebre vittoria della Grande Armée napoleonica: nella singolarità del frammento, nella particolarità di una vita individuale, si cristallizza la storia universale. Seguono intere pagine dedicate al racconto degli scontri, filtrato attraverso le parole del prof. André Hilary:
Quanto più Hilary pronunciava di fronte alla classe la parola Austerlitz, tanto più la sentivo diventare il mio nome, e tanto più mi pareva di capire che tale nome, inizialmente percepito come un marchio d’infamia, si trasformava ora in un punto luminoso librantesi davanti ai miei occhi e carico di promesse, come quel sole di Austerlitz nell’atto di levarsi al di sopra delle nebbie dicembrine.
Il programmatico rifiuto del realismo (non è forse iperbolica la modalità con cui Austerlitz e il narratore si incontrano, sempre casualmente e in diverse parti d’Europa, per quasi quarant’anni?) e l’esibizione della finzione, l’ambiguità delle attestazioni documentarie e l’inaffidabilità dei narratori, costruiscono il senso di un’operazione metonimica, di uno «spostamento» (Verschiebung) del punto di vista, dall’individuo alla Storia. Nella dinamica del sogno, dice Freud nella Traumdeutung, un tratto emotivamente carico viene sostituito da un altro meno legato al desiderio inconscio. Nella prosa di Sebald i motivi che compongono una storia si rinviano tra loro analogicamente, interpolandosi con le immagini, creando catene metonimiche in cui ogni elemento sembra rinviare al centro vuoto e irrappresentabile della Storia, alla Shoah come momento massimamente regressivo nella storia della civiltà.

Ricordo di aver appreso, durante una delle noiose lezioni di geografia astronomica del professor Tibbuli, trascorse – piuttosto che ad ascoltarlo – ad osservare gli insoliti tratti che ne definivano il volto, del tutto somigliante (ad accezione delle orecchie, che ricordavano piuttosto quelle di un asino) a un esemplare di Myrmecophaga tridactyla, uno di quegli esseri con la testa allungata e il muso stretto, con la coda grossa e pelosa, che i nostri nonni chiamavano “formichieri”; ad ogni modo, ricordo che durante quella lezione il blaterìo monocorde di Tibbuli subì una scossa particolarmente violenta quando ritenne di doverci spiegare che se la Terra ha un solo satellite «e tutti sapete qual è – ci disse stringendo la lingua al palato con una punta di eccitazione – di Saturno invece si conoscono più di 50 satelliti». Ci parlò anche dei caratteristici anelli che orbitano attorno al pianeta, anelli che osservazioni successive a quelle galileiane – Galilei, che con il suo cannocchiale aveva osservato per la prima volta il pianeta nel 1610, li paragona a grosse orecchie – li avevano interpretati come parti di un sistema più articolato, la cui complessità era stata solo intuita da Giovanni Domenico Cassini, lo scienziato genovese che distinse i primi due anelli, accorgendosi che uno spazio vuoto li separava; fu solo nel 1837, oltre 150 anni più tardi, che Johann Franz Encke rilevò la presenza di un altro vuoto all’interno del primo degli anelli analizzati da Cassini. La scoperta della loro struttura prosegue ininterrottamente fino agli anni settanta del secolo scorso, quando l’utilizzo delle moderne apparecchiature radar ha consentito una mappatura dettagliata. Le sonde Voyager hanno confermato la complessità di queste strutture, che sono molto più intricate di come appaiono dalla Terra: gli anelli più estesi si risolvono in migliaia di sottili anellini, costituiti da una miriade di pezzi di ghiaccio, polvere e rocce provenienti dalla distruzione di uno o più satelliti, con cui devono essere entrati in collisione in ere remote.
«Fra un anello e l’altro – concluse Tibbuli – ci stanno dei raggi molto scuri, fatti di una polvere nera molto molto sottile, una polvere che sta allineata per l’azione del campo magnetico del pianeta». Molti anni dopo, sfogliando l’articolo di una rivista scientifica, abbandonata sul tavolino dello studio di un dentista, ho appreso della scoperta di una formazione materica mai prima osservata, un gigantesco anello che si estende fino a 13 milioni di chilometri dal pianeta, circa cinquanta volte più lontano dell’ultimo anello conosciuto.
Il nostro rapporto con la storia – questa era la tesi di Hillary – è un rapporto con immagini già predefinite e impresse nella nostra mente, immagini che noi continuiamo a fissare mentre la verità è altrove, in un luogo remoto che nessun uomo ha ancora scoperto.
Questa stessa immagine si ritrova nei Mémoires d’outre-tombe di Chateaubriand, scritti tra il 1807 e il 1848: gli eventi cancellano gli eventi, come inscrizioni impresse su altre iscrizioni, trasformano le pagine della storia in palinsesti. Dai ricordi di un’infanzia Ancién Regime, passata nel castello paterno, a un’esistenza da esiliato durante il regime Napoleonico, fino agli anni della Restaurazione e della monarchia borghese di Luigi Filippo; la concezione della Storia intesa come necessaria concatenazione tra vite individuali e destini generali esorbita dall’autobiografia di Chateaubriand fino a Sebald. Contro il Rousseau delle Confessions, Chateaubriand rivendica il diritto alla reticenza, e nel rifiuto di qualsiasi intimismo psicologistico oblitera dalla narrazione quelle «confidences privées» che non hanno un interesse generale. Egli sente di poter parlare della sfera privata e al tempo stesso della storia degli uomini in nome della coincidenza delle età della sua vita con le diverse fasi degli sconvolgimenti sociali e politici che hanno segnato la modernità: secoli interi – scrive Chateaubriand – separano la sua infanzia dalla vita adulta, vissuta al centro della scena pubblica nel mondo nato dalla Rivoluzione.
Anche Austerlitz è vissuto prima e dopo un momento storico – la Shoah – che Sebald percepisce come rottura temporale: per puro caso, per una coincidenza storica, la sua vita individuale illumina il movimento tragico della storia, la distruzione insita nella dimensione del Tempo, il cui passaggio è costantemente messo in evidenza da Sebald attraverso cortocircuiti della temporalità, sovrapposizioni dei tempi dell’enunciazione e del racconto – in modo non dissimile dai Mémoires d’outre-tombe. In Gli anelli di Saturno, il presente delle speculazioni distruttive dell’era Thatcher e il ritorno del conflitto in Europa con le guerre balcaniche investono e sovrascrivono il tempo perduto delle comunità balneari dell’East Anglia, si connettono alle angherie e alle stragi naziste, in un tentativo estremo di restituire connessioni storiche tra fatti ed eventi neutralizzati dall’informazione, per sua natura immediata, caricata dello stesso effimero valore delle merci. «Un tentativo di restituzione» è il titolo dell’ultimo intervento pubblico dello scrittore tedesco, pronunciato alla fine del novembre 2001. Emerge un’idea di letteratura come forma in cui si legano tra loro «strani nessi, insondabili per qualsiasi logica di causa ed effetto». Strani nessi che attraversano le immagini, figure mute che accompagnano il racconto, interrompendo la linearità del testo e suggerendo la presenza di un’altra storia, altrimenti indicibile. Il senso delle immagini non è interpretabile se non per riduzione in tratti proposizionali, particelle elementari, formule di pathos che si richiamano a distanza.
In Gli anelli di Saturno la prima immagine è una finestra dietro la quale un lembo di cielo incolore trasmette un senso di pace e serenità, interrotto dai fili della zanzariera e dall’oscurità dello sfondo, la camera di ospedale in cui il Narratore è stato ricoverato dopo essere stato «più volte assalito» da «un orrore paralizzante»; il Narratore si paragona a Gregor Samsa, che «aggrappandosi con le zampette tremanti allo schienale della poltrona, guarda fuori dalla sua stanzina nel vago ricordo […] della sensazione di libertà che provava un tempo per il solo fatto di potersi affacciare alla finestra» (luce/oscurità). Le «tracce della distruzione», i segni della violenza, riattivate dalla memoria dei luoghi, hanno costretto il narratore a una lunga malattia. Poche pagine dopo un teschio su una pila di libri, di cui si riconoscono due volumi della Religio medici del medico e mistico inglese Thomas Browne (distruzione/ragione); ancora oltre La lezione di anatomia di Rembrandt occupa due pagine intere (cultura/violenza); alla fine della prima parte la pagina di un manoscritto di Il giardino di Ciro con la figura del quinconce in primo piano, uno schema regolare che secondo Browne sarebbe la base di molti elementi naturali, oltre che degli artefatti umani. La figura del quinconce è accompagnata nell’immagine da una frase in cui Quintiliano osserva la particolarità di una figura che da qualsiasi parte la si guardi restituisce alla vista una linea retta (ragione/ignoto). L’ultima immagine della prima parte è tratta dal manoscritto di un’edizione tedesca del Simplicissimus di Grimmelshausen; l’unica parte a me comprensibile del testo recita «Io sono l’inizio e la fine, e sono valido ovunque». È un iscrizione del Balanders, un mostro leggendario che Simplicius Simplicissimus incontra durante il suo percorso, un’allegoria del tempo: «in incognito è sempre stato, giorno dopo giorno, al fianco di Simplicius, e lo lascerà quando Simplicius, per parte sua, tornerà a essere ciò da cui ha tratto origine».
Come in Mnemosyne, l’atlante di immagini progettato da Aby Warburg, le immagini collocate su una tavola possono richiamare immagini provenienti da altre epoche, collocate in altre tavole; il loro senso è spesso di difficile interpretazione, enigmatiche didascalie accompagnano le centinaia di fotografie di reperti greco-romani, dipinti, affreschi, cartelloni pubblicitari. Nelle immagini si cela il senso dell’emozione umana, espressioni gestuali che attraversano le epoche e pure recano il segno storico della civiltà che le ha prodotte, un indice storico che le rende comprensibili in un tempo che non necessariamente gli è proprio, e che può essere anche molto distante dal momento della loro produzione. L’immagine della finestra nella camera d’ospedale rinvia alla prigionia della quaglia cinese, rinchiusa dietro le sbarre della voliera di Somerleyton Hall; la sensazione di claustrofobia si trasforma in orrore di fronte ai corpi nudi abbandonati all’aperto di una selva cupa e senza luce, fuori dal lager di Bergen-Belsen. La fotografia è priva di commento.
Ma gradatamente le felci si diradarono liberando la vista su un campo che si estendeva sino alla chiesa di Covehithe. Dietro una bassa recinzione elettrificata un branco di maiali d’un centinaio di capi era disteso a riposare sulla terra bruna, dove ciuffi di camomilla crescevano radi e sparuti. Scavalcai i fili metallici e mi avvicinai a uno di quei pesanti animali, immobili nel sonno. Lentamente, mentre mi chinavo, il maiale aprì quel suo piccolo occhio orlato di ciglia chiare e mi rivolse uno sguardo interrogativo. Gli passai la mano sul dorso polveroso, che ebbe un brivido a quel contatto inusuale, lo accarezzai sul grugno e sul muso, e gli grattai l’incavo dietro l’orecchio, finché non avvertii un profondo sospiro, come di un essere umano tormentato da un dolore infinito.
Fotografia: G. Biscardi, Vienna 2016, porta
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento