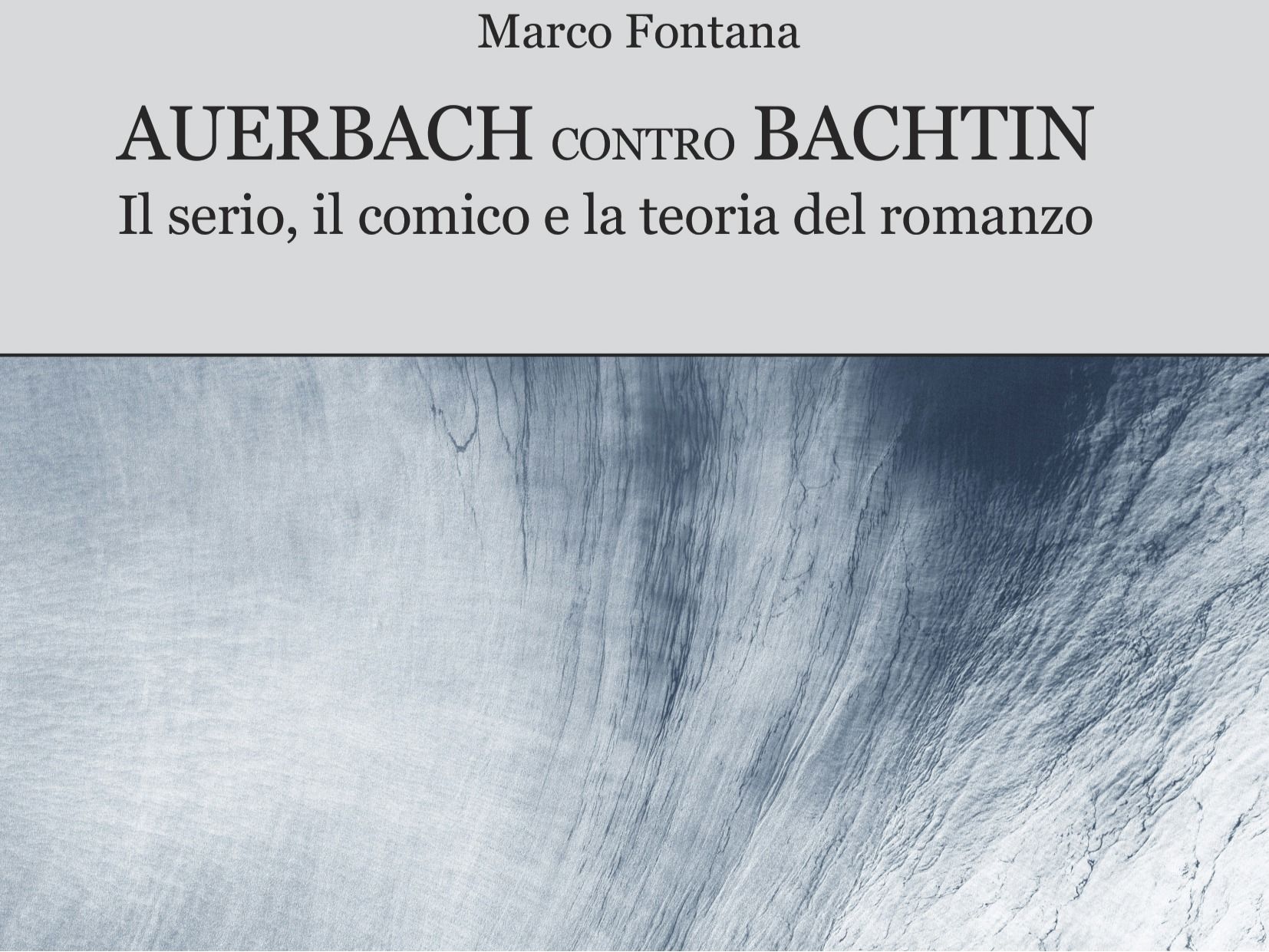
Auerbach contro Bachtin
Pubblichiamo l’introduzione del volume di Marco Fontana Auerbach contro Bachtin. Il serio, il comico e la teoria del romanzo (EditPress, 2025), ringraziando autore ed editore.
Nei primi anni Quaranta del secolo scorso, Erich Auerbach stava scrivendo Mimesis da esule a Istanbul, saggio in cui tentava di offrire un’idea sulla rappresentazione della realtà nel mondo occidentale partendo da una prospettiva di lunga durata. Il critico cercava di collocare le forme nel loro contesto e le interrogava nel loro divenire storico, dalla Bibbia a Gita al faro. Nello stesso momento ma in un altro luogo, nella Repubblica Socialista Sovietica Kazaka, il confinato Michail Bachtin accantonava la filosofia per dedicarsi a una serie di studi letterari che avrebbero costituito di lì a poco il nucleo della sua opera critica. Anche lui, come Auerbach, puntava a cogliere l’evoluzione delle forme letterarie dalla Grecia antica al romanzo moderno.
Questo libro intende riflettere sulle loro teorie del romanzo guardando nello specifico al contrasto che si gioca tra serio e comico: il teorico della serietà del quotidiano e il teorico del carnevalesco hanno elaborato due teorie letterarie affini negli intenti ma opposte sotto molti punti di vista, e il disaccordo maggiore risiede nella diversa concezione dell’ingresso della letteratura nella modernità1. Per Auerbach, la secolarizzazione e l’emancipazione moderna trovano un riflesso nella rappresentazione seria della vita quotidiana degli individui comuni; per Bachtin, invece, l’evoluzione delle forme passa dalla distruzione comica della distanza epica e dallo smarcamento da ogni discorso di potere costituito. Questo contrasto implicito merita di essere indagato nella sua logica guardando alla genealogia dei due autori e alla dimensione politica che sottostà ai loro giudizi di valore, perché lo scontro tra serio e comico non riguarda solo due modi diversi di concepire la letteratura, ma sottintende due visioni del mondo inconciliabili e costituisce un crocevia attorno al quale si addensano questioni critiche da verificare.
Mimesis di Erich Auerbach è forse il testo di critica letteraria del secolo scorso che ha resistito meglio al passare dei decenni e al susseguirsi di nuove proposte teoriche. I suoi concetti e il suo schema di fondo continuano a essere utilizzati e discussi ancora oggi. Il saggio di Auerbach è a tutti gli effetti «l’unica storia letteraria di lunga durata che abbia resistito allo scetticismo della nostra epoca», e certe «idee su cui si regge […] sono moneta critica corrente»2. In un tempo in cui è tramontata l’egemonia dei modelli esplicativi totalizzanti, Mimesis si dimostra inattuale perché propone un affresco plurisecolare della storia della letteratura occidentale senza avere pretese di esaustività: unisce la dinamicità delle intuizioni a basi teoriche forti (la filologia, la filosofia, lo storicismo) e si attiene alla forma del saggio per la sua compresenza di libertà metodologica e di rigore analitico. Appartenente ancora a quella famiglia di scritti che rifiutano «datità originarie»3, Mimesis, in un certo modo,poté permettersi di contrapporsi «ai piccoli sistemi della precisione scientifica»4. La parzialità del suo disegno concorda infatti con un tipo «senso storico» che «sa di essere prospettiva, e [che] non rifiuta il sistema della propria ingiustizia»5. Questo implica, però, che i problemi e i nodi rimasti da sciogliere siano ancora molti.
Uno dei principali problemi di Mimesis riguarda la questione dello spazio del comico nella narrativa occidentale, tema che invece Bachtin pone al centro di tutta la sua opera e che affronta guardando a questioni di stile, di genere e di forma. Il comico costituisce le fondamenta del suo disegno teorico ed è l’innesco dialettico necessario ad ogni trasformazione delle forme estetiche. Di contro, Auerbach non definisce mai il comico con chiarezza e imposta il suo saggio attorno a due elementi che gli sono antitetici: il tragico e il serio, categorie investite di valore che fanno percepire il residuo di hegelismo presente nella sua filosofia della storia. La fede di Auerbach è quella di un umanista liberale che crede profondamente nella tradizione e nella conservazione di una serie di valori incarnati da una borghesia retta da un ethos serio. Viceversa, l’orientamento politico di Bachtin si avvicina a una forma anarchica di anticapitalismo romantico che vuole disarticolare ogni dogma imposto dall’alto e che diffida di ogni discorso monologico.
Interrogare questo dissidio permette di confrontare le loro teorie, ed esaminare alcuni testi canonici del romanzo moderno utilizzando i loro strumenti aiuta a chiarire certe loro intuizioni. L’obiettivo è quello di intrecciare costantemente le proposte teoriche dei due autori per ragionare sull’ibridazione tra serietà e comicità che concerne soprattutto la rappresentazione di personaggi appartenenti alla classe borghese – figure che nei secoli precedenti al XIX appartenevano di norma alla commedia e che nel novel, pur conquistando una nuova dignità narrativa, continuano ad incorrere in situazioni di serietà mancata6. L’Ottocento, oltre ad essere il «secolo serio»7, è anche pervaso da un’ampia riflessione sul comico che si estende per decenni coinvolgendo diversi campi del sapere, e la letteratura – prodotto storico organizzato secondo criteri retorici8 – registra pienamente l’emersione di queste dinamiche. Molti romanzi di quell’epoca, pur mantenendo una struttura coesa, offrono spesso una mimesi ibrida in cui la tragicità del quotidiano convive con il ribaltamento carnevalesco. Il novel dimostra così di poter contenere al suo interno delle spinte antitetiche che, in un regime in cui la serietà resta egemonica, manifestano delle «ferite formali»9 che diventano il segno e il sintomo di un contesto in cui si affrontano contraddittoriamente desideri individuali e necessità storiche. Ma questo conflitto tra “poesia del cuore” e “mondo della prosa”, tra “anima” e “mondo”, prima ancora di Auerbach e di Bachtin, costituiva già il fulcro della Teoria del romanzo di Lukács, figura che in questo studio funge da segnavia nel continuo andirivieni tra due fuochi. La “funzione” Lukács agisce qui sottotraccia per la sua posizione mediana – hegeliano come Auerbach e anti-liberale come Bachtin – e fa da anello di congiunzione tra due visioni opposte. Come i due critici, anche lui ragiona sulla lunga durata, punta su un’interrogazione dialettica di testo e contesto e crede che il romanzo sia la forma che meglio registra le contraddizioni nate in seno alla modernità.
Questa canonica triade permette di orientarsi ancora in mezzo ad alcune questioni teoriche del romanzo moderno e costituisce l’architrave di questo libro. Più in particolare, senza la pretesa di cogliere l’intera posta in gioco di un conflitto critico tra due autori di rilievo come Auerbach e Bachtin, la volontà è quella di interrogare le loro opere concentrandosi solo su un rivelatorio fattore di contrasto. Il punto di partenza risiede nella convinzione che in Auerbach e Bachtin l’investimento sul serio e sul comico obbedisca implicitamente allo stesso bisogno, ossia quello di introdurre entro la cornice della propria proposta teorica un’idea che faccia da asse portante per la lettura del dato testuale e delle sue verità.
1 Ogni teoria del romanzo, come sostiene Franco Moretti, è al contempo una teoria della modernità. Cfr. F. Moretti, Distant Reading, Verso, London 2013, p. 176: «the great theories of the novel have been theories of modernity».
2 G. Mazzoni, Il paradosso di Auerbach, in E. Auerbach, Letteratura mondiale e metodo, Nottetempo, Milano 2022, p. 9.
3 T.W. Adorno, Il saggio come forma, in Noten zur Literatur (1974), trad. it. Note per la letteratura, Einaudi, Torino 2012, p. 13.
4 G. Lukács, Essenza e forma del saggio: una lettera a Leo Popper, in Die Seele un die Formen. Essays (1910), trad. it. L’anima e le forme, SE, Milano 2002, p. 35.
5 M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Einaudi, Torino 1977, p. 46.
6 È una questione trattata da Paolo Tortonese in un importante contributo su Auerbach e che verrà ampiamente ripresa in seguito. Cfr. P. Tortonese, Alla ricerca della completezza: il borghese tra comico e serio, in «Status Quaestionis», 12, 2017, pp. 45-55.
7 F. Moretti, Il secolo serio, in Il romanzo, Einaudi, Torino 2001, vol. I, pp. 689-725.
8 Cfr. Id., Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms (1983), trad. it. Segni e stili del moderno, Einaudi, Torino 1987, p. 11.
9 Riprendo la formula da F. Jameson, The Ancients and the Postmoderns: On the Historicity of Forms, London-New York, Verso, 2015, p. 67.
Articoli correlati
Commento
Lascia un commento Annulla risposta
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Molto interessante. Comprerò il libro, anche dislocare Lukacs come medio tra Auerbach e Bachtin mi sembra arbitrario
Sono tre interpretazioni alternative del modello narrativa, quello lukacsciano d’ambito neomarxista bolscevico, espressione di una visione totalizzante nel senso harendthiano, mentre tanto A che B elaborano sistemi interpretativi aperti.
ho scoperto per caso il Vostro lavoro, molto bello grazie