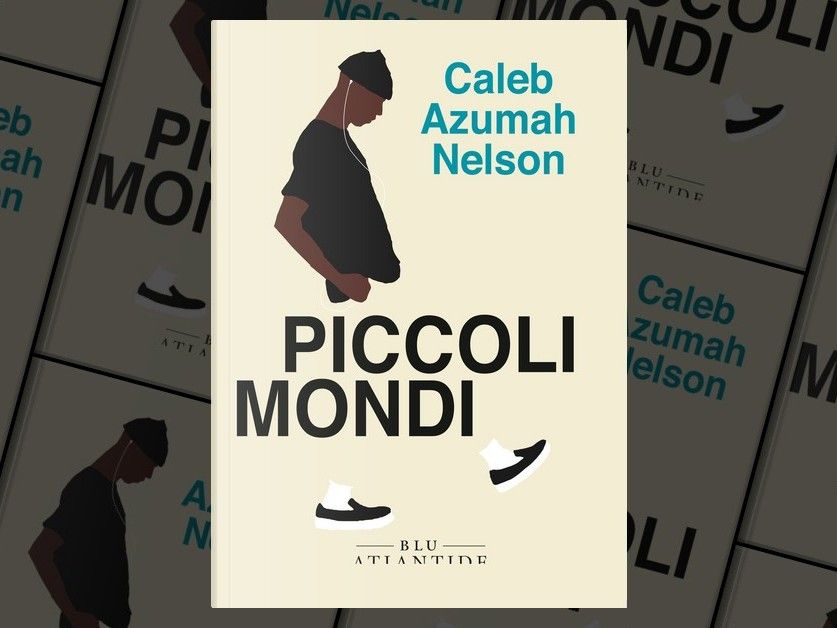
Proposte per giovani lettori. “Piccoli Mondi” di Cale Azumah Nelson
Assaggio di lettura
Dopo un po’ lei mi chiede: “Perché il jazz?”.
Ci rifletto prima di appoggiarmi sullo schienale, mi sorprendo a essere rilassato, mi sorprendo a non avere bisogno di nascondermi. Dico: ho sempre sentito qualcosa che premeva appena sotto la superficie, un istinto di esprimere quello che sono, come mi sento. Di dire: io sono qui. Sono cresciuto parlando inglese ma mi parlavano in Ga, la lingua di mia madre. Mentre lo dico Annie annuisce e sorride comprensiva; così mi faccio forza e continuo. Sono arrivato a entrambe le lingue per mezzo della violenza: il Ga che parlo è stato distorto e silenziato, molti anni fa, dopo le invasioni britanniche, quelle stesse invasioni per via delle quali parlo inglese. E quindi la lingua mi è sempre sembrata qualcosa che era più un fardello che uno strumento. È sempre impigliata tra un punto e un altro, è un qualcosa che è sempre perso tra l’espressione e l’emozione. Questo è il motivo per cui mi sono sempre rivolto alla musica: un canto accorato più significare il cuore spezzato, oppure un grido può comunicare con la nostra esultanza, o un gemito può esprimere il nostro dolore. La musica, il ritmo, innegabili. Il suono ci aiuta ad avvicinarci a quello che sentiamo. E poi la lingua deve sempre essere molto precisa, e io non so mai come mi sento precisamente. Il suono, nello specifico il jazz e il suo spirito di improvvisazione, lascia spazio agli errori, e per di più permette all’errore di essere qualcosa di bello. (pp. 133-134)
La storia, le storie
Stephen è un ragazzo che dice di conoscersi solo in musica, tra le note che suona con la sua tromba o ballando. Vive nel sobborgo di Peckham a Londra, tra le cui strade si snodano le relazioni famigliari, amicali e con tutta la comunità ghanese che lì ha costruito nel tempo il suo piccolo mondo. Entrambi i genitori custodiscono il racconto della loro emigrazione con gelosia e mistero e con esso il peso delle radici mai del tutto recise. Il conflitto che anima il protagonista si snoda a più livelli e si innesta su più temi, cosa che garantisce al romanzo una lettura multilivello e non circoscrivibile a una limitante etichetta di “romanzo di formazione”: l’amore, l’amicizia, il bisogno di indipendenza e, contemporaneamente, l’esigenza di porsi in continuità con il passato e con le radici, la lotta come forma necessaria di autoaffermazione si intrecciano senza discontinuità.
Diviso in tre pannelli corrispondenti a tre estati, la storia, a partire dal 2010, segue indubbiamente le vicende amorose e le scelte di vita universitaria e lavorativa di Stephen che cresce come crescono tutti gli adolescenti per traiettorie di improvvisazione e sbagli, come melodie di musiche non convenzionalmente riproducibili con uno spartito predisposto. Se inizialmente parte del conflitto e dell’irrequietezza del protagonista sembra risolvibile con il lasciare la musica e assecondare la scelta del padre per la scelta universitaria, ben presto Stephen si renderà conto che, se “siamo tutti come strumenti”, occorre creare un ritmo proprio, e per farlo riparte dal Ghana e dal quartiere di Peckham.
L’estate del 2011 è però anche l’agosto in cui Mark Duggan, un uomo nero di ventinove anni, viene ucciso dalla polizia di Tottenham pur essendo disarmato; cominciano i “Riots di Londra” in cui migliaia di giovani devastano le strade, appiccando il fuoco ad automobili e abitazioni, distruggendo vetrine. Stephen ne viene inevitabilmente coinvolto, sebbene senza ferite, a differenza di alcuni suoi compagni.
Come potremmo fare a costruire un piccolo mondo, dove potremmo sentirci belli, potremmo sentirci liberi. Temiamo tutti le telefonate o i messaggi che ci ricordano che, al di fuori di questi spazi, di rado siamo al sicuro […] Ci ricordano che il mondo non è stato costruito avendo in mente noi, e che qualcuno, in qualsiasi momento, potrebbe fare irruzione nelle nostre case, sgretolare i nostri muri, ridurre in polvere le nostre fondamenta. Sono giornate come questa che ci ricordano di non avere uno spazio, e sembra che la città si stia chiudendo, cercando di farci svanire come per magia. (p.176)
La storia di Stephen diventa perciò la storia di tutti i ragazzi impegnati non solo a trovare se stessi, ma anche obbligati a difendere i confini e i diritti di ciò che chiamiamo casa, famiglia, libertà. Quanto accadrà dopo quell’estate, segnata anche dal lutto della mamma, sarà una musica che conduce dove molte delle sue storie iniziano e, insieme, finiscono: in Africa, al castello di Cape Coast, alla “Porta del non ritorno”, dove i neri, resi schiavi, venivano imbarcati per essere portati a lavorare nelle piantagioni brasiliane: “Penso al fuoco, alla rabbia e alla violenza. Penso a Tottenham, a Brixton e a Peckham. Penso a tutti i luoghi in cui noi, come persone Nere, siamo costretti a sparire”. (p. 212)
Tornare a Londra, dopo aver visto questo, significa per Stephen fare pace con i mondi che si porta dentro, con le lotte che lo hanno preceduto, con la rabbia che segue a volte alla sconfitta e, malgrado tutto, con l’amore verso ciò che è autenticamente proprio.
Perché proporne la lettura
Il romanzo, sicuramente adatto a lettori allenati sia alla lunghezza sia al formato dei capitoli densi, offre, come si è cercato di far emergere nella presentazione della trama, svariate prospettive di lettura. La crescita del personaggio da un punto di vista amoroso, amicale, famigliare, va di pari passo con il grande tema di Londra e del quartiere di Peckham con tutta la vitalità che consegue alle sue contraddizioni (riti di forte aggregazione come il ballo, la religione, il cibo, si affiancano a grandi problematiche come la disoccupazione dei giovani, la disperazione dei genitori non sempre in grado di comunicare con i figli il trauma dell’emigrazione).
Lo stile è sicuramente un punto di forza e di novità: le sequenze descrittive e riflessive sono spesso caratterizzate da un lirismo non frequentemente riscontrabile nei libri Young adult e il ricorso a capitoli con costruzione ad anello o a frasi quasi formulari contribuiscono a impreziosire la lettura con accorgimenti retorici assai d’effetto.
Non da ultimo, il romanzo risponde a un’urgente necessità di decentralizzare le nostre antologie/letture con storie che tentino di aprire “piccoli mondi”su narrazioni meno note, ma non per questo trascurabili, di minoranze di cui sentiamo arrivare l’eco nella cronaca del Black Lives Matter o nelle proteste del “Stop the Far Right”.
I temi: Padri e figli
All’interno della fitta rete di immagini e temi proposti dal romanzo, mi preme metterne a fuoco uno, a mio parere, sicuramente ad alta ricorsività nei romanzi adatti ai giovani lettori, e che tuttavia in questo testo è dotato di un’alta risonanza corale: il rapporto figli – genitori.
Le dinamiche tra Stephen e i suoi vengono descritte inizialmente attraverso la chiave (piuttosto prevedibile) del conflitto, soprattutto per quanto riguarda suo padre. Ricostruiamo la storia di quest’ultimo in sequenze sparse nel romanzo e spesso attraverso dei flashback del protagonista: le sue reazioni violente e istintive, l’uso eccessivo di alcool, i non detti, il rapporto quasi esclusivo con il fratello Raymond nella misura in cui condivide con lui delle serate di bevute all’insegna del calcio; tutto sembra progressivamente aumentare la distanza e l’incompatibilità tra i due fino alla rottura fatale dell’equilibrio con la cacciata di casa di Stephen a seguito del suo fallimento universitario. La lettura profonda del romanzo impone tuttavia una messa a sistema di tali elementi per scavare a fondo nella personalità del personaggio padre: Qual è la sua storia? Perché non piange mai? (domanda, quest’ultima, che ossessiona Stephen).
Dall’altro lato, la mamma viene invece rappresentata come detentrice di una ritualità positiva, quella delle serate esclusive con Stephen al cinema, del tempo passato in cucina come altissima forma di accudimento e amore e, insieme, di continuità di trasmissione delle tradizioni, colei che pertinacemente resiste agli urti coniugali e alle difficoltà economiche, e che lascia aperte le porte del dialogo con il protagonista anche laddove i conflitti potrebbero far degenerare i rapporti. La ricostruzione del suo personaggio nasconde in ogni caso delle ombre: ci sono argomenti di cui i genitori sono gelosi? Chi decide cosa si può raccontare ai propri figli e cosa è meglio nascondere?
Gli interrogativi lanciati dai profili di entrambi i personaggi restano, per le prime due sezioni del romanzo, pressoché irrisolti, ma diventano tessuto indispensabile per la narrazione in prima persona di Stephen che procede nell’indagine dei suoi genitori attraverso osservazioni sempre delicate e mai banali, e che l’autore riproduce con punte stilistiche e liriche pregevoli. Si noti, ad esempio, il parallelismo e la formularità con cui, in capitoli diversi, si descrive la madre prima, il padre dopo, colti nello stesso atteggiamento di malinconia e silenzio autoimposto in merito al loro passato di migrazione.
Oggi le chiedo cosa significa aspettare. Le chiedo dei vuoti in cui le parole ci vengono meno. Voglio saperlo perché sono quelle le storie che mi hanno formato. Le chiedo di più e il volto di mia madre, un cielo sereno, si rabbuia. Di solito, l’acqua è una minaccia gentile, le crea negli occhi uno splendore come un luccichio, un riflesso di tristezza. (pp. 42-43)
Non ho mai visto piangere mio padre, ma sembra che sia lì lì per farlo. L’acqua è una minaccia gentile, gli crea negli occhi uno splendore come un luccichio, un riflesso di tristezza. Mi chiedo quale frammento si sia infiltrato nella sua giornata, mi chiedo quale sia la sua ferita che non riesco a vedere. Cosa potrebbe perseguitarlo. Magari glielo potessi domandare. Magari riuscissimo a essere così aperti. (pp. 54-55)
Il terzo pannello del romanzo si apre sulla spinta dell’ultimo atto della sezione precedente e cioè a partire dall’improvvisa perdita della mamma, poco prima del viaggio programmato per il Ghana insieme a Stephen che decide di partire in solitudine ed esplorare non solo i luoghi della sua storia famigliare, della sua origine, ma anche e soprattutto i labili confini del concetto stesso di casa. Comincia da qui l’opportunità di confronto con il padre, rimasto solo e ancora più chiuso in un silenzio carico di dolore e rabbia inespressa; cominciano i racconti e le parole verso un figlio che non si è mai arreso all’analisi dei legami che tengono insieme due persone. La voce di Stephen diventa la voce del padre, la voce di chi, a causa della povertà e delle aspettative della famiglia, arriva a Londra carico di sogni e di amore, costruisce giorno dopo giorno un futuro che finisce dove iniziano i confini dei mondi intorno a lui: sono gli anni Ottanta dei primi contrasti contro la popolazione nera, cui seguono i disordini di Brixton del 1995, sono gli anni in cui inizia a bere perché non ha niente, non ha lavoro, non ha la forza per ricominciare, né per chiedere aiuto.
Essere migliore significa essere aperto. […] significa radunarsi la domenica con altri che, come te, sono venuti a Londra dal Ghana e dalla Nigeria, dal Senegal e dalla Giamaica, per costruirsi una nuova vita. […] Significa che, anni dopo, quando tuo figlio minore ti chiederà chi sei, chi eri, cosa sogni, dove trovi la libertà, quando ti chiederà di raccontargli del trasferimento, dell’emigrazione, del fardello, di dover scegliere quali parti della tua vita conservare e quali abbandonare, gli dirai che conosci questa sensazione che a volte lo perseguita, questa tristezza che ha sulle spalle. […] Gli dirai che questo è il modo in cui sei emigrato. Questo è quello che ti sei portato dietro. Questa è la colpa che è sopravvissuta. Questo è il tuo fardello. È per questo che fai fatica ad amare liberamente, perché senti di perdere tutto quello che fai. (pp.273-274)
La vicenda che Caleb Azumah Nelson ci propone mette in luce il tema padre–figlio e, in generale, il tema del conflitto con i genitori, da una prospettiva non scontata: in prima battuta per la forza stilistica della voce narrante che analizza i comportamenti degli adulti con una maturità sorprendente; non da meno per la lente di ingrandimento sul grande aspetto del retaggio patriarcale dell’uomo (in questo caso il padre) cui non sono consentite debolezza e fragilità; in ultimo, ma non per importanza, per lo specchio che questa storia crea per il racconto collettivo dell’esperienza di migrazione che amplifica e addensa allo stesso tempo il conflitto adolescenziale della ricerca di identità attraverso inevitabili intersezioni. La spinta centrifuga verso un orizzonte che sia proprio si allinea, deve allinearsi, con la schiacciante necessità di fare i conti con l’eredità posta altrove nel mondo, nei piccoli mondi di chi ci è accanto.
Informazioni editoriali
Cale Azumah Nelson, Piccoli Mondi, traduzione di Anna Mioni, Blu Atlantide, 2023, pp. 282, euro 18,50.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento