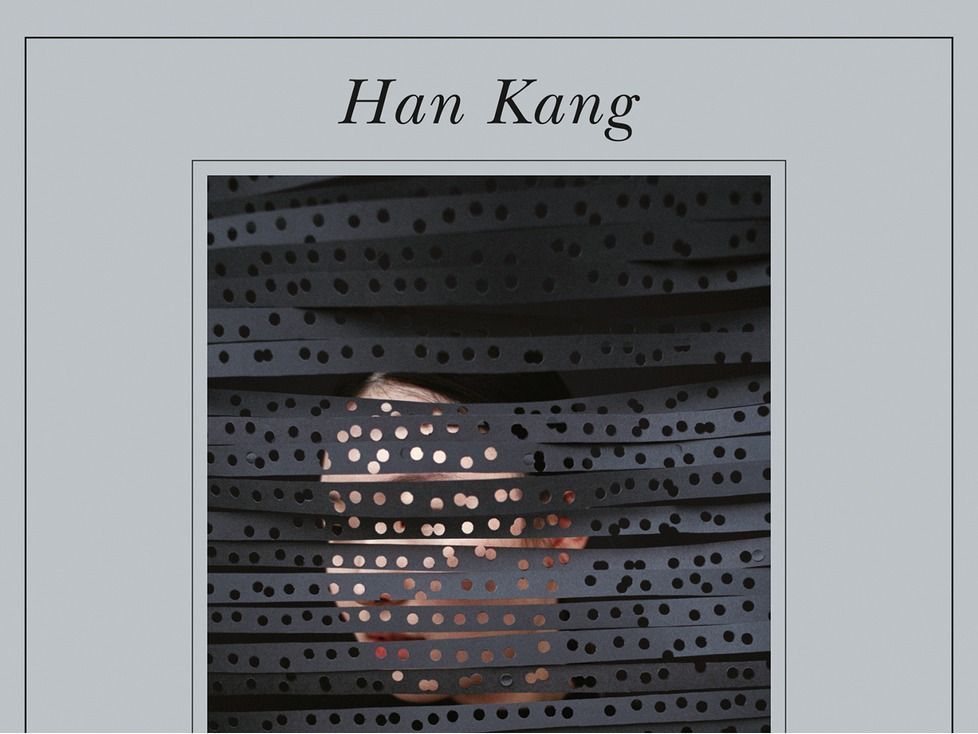
Su Atti umani di Han Kang
Polifonia di un trauma
«Per favore, scriva il suo libro in modo tale che più nessuno possa oltraggiare ancora la memoria di mio fratello» (p. 201).
E lei, la scrittrice, lo fa «come si deve», come le viene chiesto dal fratello di Dong-ho, salvando in questo modo la memoria del ragazzo, e quella delle tante vittime del massacro avvenuto nella Corea del Sud il 18 maggio 1980 a Gwangju. Un capitolo drammatico della storia coreana troppo a lungo ignorato, soprattutto nel mondo occidentale, e al quale Han Kang dà voce nel suo libro Atti Umani, uscito in Italia nel 2017 per Adelphi nella traduzione di Milena Zemira Ciccimarra.
Han Kang, sudcoreana, premio Nobel 2024 per la letteratura, e nota ai lettori italiani soprattutto per il precedente romanzo La vegetariana (2007), scrive questa volta un intenso libro di denuncia utilizzando una prosa delicata e densa allo stesso tempo, una letteratura della resistenza, come ci tiene a ricordare Benedetta Tobagi, dal registro «profondamente poetico, rarefatto», che «ci fa entrare nella carne della storia, però lo fa con una delicatezza e seguendo delle strade imprevedibili, però alla fine è tagliente come una lama».
Attraverso sette capitoli, ciascuno dedicato alla storia di un personaggio coinvolto nella rivolta compiuta a Gwangju, Atti umani denuncia la brutalità e la ferocia con cui viene sedata e soffocata nel sangue una manifestazione democratica, principalmente di studenti e professori universitari, contro l’oppressiva dittatura del presidente Chun Doo-hwan. Per dieci giorni i manifestanti resistono alla violenta repressione delle milizie, nella quale perdono la vita oltre mille civili e molti altri vengono arrestati e torturati.
Scrivere per denunciare
Han Kang scrive per denunciare e restituire giustizia a questa ferita ancora aperta nella memoria del popolo sudcoreano, proprio come viene chiesto alla se stessa scrittrice, e protagonista dell’ultimo capitolo, dal fratello di Dong-ho, il ragazzo morto al quale viene dedicato il primo capitolo. Tra questi due capitoli, che aprono e chiudono il libro, si snodano le restanti cinque storie, di cui sono protagonisti altrettanti personaggi (l’amico del ragazzo, la redattrice, il prigioniero, l’operaia, la madre del ragazzo) che, in diversi piani temporali, e intrecciando le loro esistenze, raccontano quello che hanno visto e quello che hanno vissuto prima, durante, e dopo il massacro.
I capitoli si susseguono, infatti, secondo una progressione temporale che ha inizio nel 1980 del primo racconto (Il ragazzo.1980) e giunge fino al 2013 dell’Epilogo (La scrittrice. 2013). Perché è necessario ricordare quanto accaduto attraverso la forza viva del vissuto e dell’immediatezza, ma anche attraverso le conseguenze di quel tragico momento storico. Anzi, forse è proprio indagando nelle ripercussioni che si sono generate, e nel trauma prodotto, che è possibile fare meglio i conti con la storia. Man mano che la narrazione si avvicina al nostro presente alcuni toni sono smorzati, perdono un po’ della violenza cruda legata all’immediatezza dei fatti, quando in una palestra comunale decine di cadaveri raggruppati soffocano l’aria provocando un’«ondata di nausea che ti investe insieme al tanfo». Quando, sempre tra questi corpi, è possibile individuare «diverse gradazioni di orrore. Il peggiore è il cadavere nell’angolo più lontano. La prima volta che l’hai visto, si riconosceva ancora una ragazza piccoletta, tardoadolescente o poco più che ventenne; adesso il suo corpo in decomposizione si è talmente gonfiato da sembrare quello di un uomo adulto» (p. 15).
Ma con la distanza temporale i fatti assumono la forma di una sorta di ossessione dalla quale sembra impossibile prendere definitivamente le distanze: «Gwangju era diventato un modo per definire tutto ciò che è isolato con la forza, oppresso e brutalizzato, tutto ciò che è stato irreparabilmente mutilato» (p. 197). Ognuno dei personaggi porta infatti con sé i segni di quel 1980. Così la giovane Eun-Sook, che durante l’insurrezione si era presa cura dei corpi uccisi, qualche anno dopo, come redattrice, deve fare i conti con la censura del governo rispetto a quei momenti drammatici. L’operaia e il prigioniero sono invece, a distanza di anni, incapaci di dimenticare le torture e le violenze subite che continuano a condizionare le loro esistenze («Yoon ti ha chiesto di ricordare. Di «affrontare quei ricordi», di «testimoniare». Ma come è possibile fare una cosa del genere? È possibile testimoniare che mi ficcarono ripetutamente nella vagina un righello di legno di trenta centimetri, spingendolo dentro fino alla parete posteriore dell’utero? Che mi lacerarono la cervice uterina con il calcio di un fucile? Che, quando l’emorragia non voleva arrestarsi e collassai, dovettero portarmi all’ospedale per una trasfusione? […] È possibile testimoniare che sviluppai un’avversione patologica al contatto fisico, soprattutto con gli uomini? […] Che ho deliberatamente distrutto ogni calore umano, ogni affetto troppo intenso per poterlo sopportare, e sono scappata? Verso un posto più gelido, un posto più sicuro. Solamente per sopravvivere.», p. 158)
Anche la scrittrice, la stessa Han Kang, protagonista e voce narrante dell’ultimo capitolo, confessa di non aver mai dimenticato ciò che è accaduto in quel maggio del 1980, anche se all’epoca dei fatti era solo una bambina: «avevo nove anni quando scoppiò l’insurrezione di Gwangju» (p. 185). È questa impossibilità a dimenticare ciò che la spinge a scrivere. Ma non è facile farsi testimone di quei fatti senza lasciarsi sopraffare dagli incubi e dalle immagini che si annidano nella mente: «Dopo due mesi, verso la fine di gennaio, sentii che non ero più in grado di continuare. A causa dei sogni. […] Perché per me le stagioni continuavano a succedersi, mentre per lui il tempo si era fermato per sempre a quel maggio?» (p. 193, p.198). Lui è Dong-ho, la cui storia è raccontata attraverso personaggi e punti di vista diversi in ognuno dei sette capitoli, e con il quale la scrittrice stabilisce un dialogo diretto utilizzando la seconda persona. Un “tu” che sembra rivolgersi anche al lettore, costringendolo ad essere più partecipe, ad entrare in contatto con la necessità di agire, anche soltanto quella di uscire da un presente e da una realtà tranquilla e asfittica per comprendere quel 1980 con una coscienza rinnovata.
Il corpo
Dong-ho è un ragazzino di quindici anni che, cercando l’amico Jeong-dae, si trova davanti alla brutalità della morte e ai tanti corpi delle persone cadute. La sua vicenda costituisce una sorta di filo conduttore e di collante per tutte le restanti storie, e solo alla fine scopriamo che a spingere la scrittrice a raccontare questo orrore sarà proprio una foto di questo ragazzino e il suo nome sussurrato in casa quando lei era bambina. Non essendo stato capace di recupere il corpo dell’amico, e dunque di sottrarlo alla morte, il ragazzo sceglie infatti di restare in mezzo a quella carneficina. Non vuole abbandonare le vittime di quel massacro, vuole prendersi cura di loro, scegliendo di aiutare e organizzare la disposizione dei cadaveri. Onorare i defunti è un modo per impedire che quei corpi vengano ricordati solo come corpi massacrati: ognuno di essi è realmente esistito ed ha compiuto degli “atti umani” che possono continuare a parlarci. Ma anche il suo, quello del ragazzo, diventerà un corpo freddo, un cadavere in mezzo ad altri cadaveri tutti ammucchiati in una pila che si alza verso il cielo, «Eravamo corpi, corpi morti, e in questo senso eravamo tutti uguali. […] Il mio [corpo] schiacciato e deformato sotto una torre di altri corpi, era disgustoso, qualcosa di cui vergognarsi» (p. 55-56). Fino a quando alcuni soldati, dopo avere preso una tanica piena di benzina, essersi messi a distanza di sicurezza e fatto scattare l’accendino su alcuni rami secchi, provocano le fiamme sui corpi ammassati. Soltanto allora «la torre di corpi franò in un indistinguibile ammasso di braci ardenti, un miscuglio di corpi un tempo separati» (p. 64). Fu allora che le anime furono «strappate con violenza ai loro corpi» e «fu allora che moristi, Dong-ho» (p. 65).
Il tema del corpo che subisce violenza, caro a Han Kang già dal precedente romanzo La vegetariana, ritorna con forza qui, nella moltitudine di corpi oltraggiati e violentati dal massacro. Corpi ai quali si rende omaggio anche attraverso il rituale delle candele accese, simbolo di vita che si oppone alla morte. Forse è proprio per la sua attenzione ai corpi morti, alla cura con cui si dedica a restituire loro la dignità che è ancora possibile, che Dong-ho viene scelto dalla scrittrice come motivo che lega ogni racconto.
Se in un contesto di violenza come questo è lecito chiedersi: «Quando il corpo muore, che cosa succede all’anima? Per quanto tempo indugia accanto alla sua vecchia casa?» (pag. 16), per poi concludere che «non ci sono anime qui. Ci sono solo cadaveri ridotti al silenzio, e questo orribile tanfo putrido» (p.16), che significato possiamo attribuire agli atti umani? Forse è proprio quando non si scorge più l’orizzonte dell’esistenza umana, quando il trauma ha invaso ogni pensiero, corpo, e voce, che assumono ancora più importanza gli “atti umani”, e il giovane Dong-ho è qui per ricordarcelo.
La celebrazione di un trauma
Leggendo Atti umani non possiamo sfuggire a quanto accaduto, né attutire il dolore, però possiamo celebrare la memoria di chi in mezzo a tanto sofferenza ha trovato la forza di resistere. Perché è di fronte a una violenza così efferata che l’umanità matura una capacità di resistenza storica.
Nell’ultimo capitolo la scrittrice si chiede perché tutti quegli uomini erano rimasti, perché la milizia civile, pur sapendo che la sconfitta era inevitabile, era rimasta e si diceva «pronta a imbracciare le armi» (anche se al momento di usarle non era riuscita a sparare davvero). Dove avevano trovato la forza? Quando fu chiesto loro, «i sopravvissuti diedero tutti la stessa risposta. Non lo so di preciso, sembrava semplicemente la cosa giusta da fare.» (p. 202). E In questo risiede l’errore di Han Kang: «Avevo sbagliato a considerarli delle vittime. Erano rimasti proprio per evitare quel destino […] Ma ora se solo riusciamo a tenere gli occhi aperti, se riusciamo tutti a mantenere gli sguardi fermi, fino all’amara fine…» (p. 202)
Atti umani non è un semplice libro-inchiesta, è una narrazione corale attraverso sette punti di vista diversi, tutti legati, in qualche modo, dalla morte e dal trauma. Un trauma che nel suo non-senso acquista un significato soltanto grazie a chi non vuole essere vittima e sceglie di agire e di combattere contro il nemico attraverso un’azione collettiva. Siamo dunque di fronte a una narrazione polifonica di un evento traumatico, ma senza il carattere della scrittura dell’estremo – come la definisce Daniele Giglioli in Senza trauma – che indaga nei traumi immaginari dimentica della realtà. L’estremo di cui si fa portavoce Han Kang è rappresentato senza compiacimenti attraverso una prosa cruda, di chi ha conosciuto i fatti e vuole raccontarli nella loro nudità, nella speranza di cogliere ancora qualche residuo umano in mezzo a tanta sofferenza. In quest’opera c’è il dolore di chi l’ha vissuto sulla propria pelle, ci sono corpi smembrati, in decomposizione, pagine che descrivono atti di una ferocia inaudita nelle quali aleggia costantemente l’immagine della morte. Una crudeltà espressiva resa ancora più violenta perché raccontata con punte di delicatezza e di lirismo poetico.
La letteratura non è capace di cancellare i traumi, ma può aiutare a comprenderli, può smuovere le coscienze. Si può ricordare, persino celebrare un trauma, senza che diventi una figura dell’immaginazione e dell’individualità, un feticcio, insomma, di una società come quella attuale in cui, tornando al saggio di Giglioli, la parola “trauma” viene continuamente evocata e desiderata nonostante non si faccia più esperienza di traumi effettivi. E nel nostro presente, in un momento storico in cui assistiamo alla totale assenza di una dimensione politica dell’esistenza, in cui non sembra possibile affermare niente al di là della propria individuale esistenza, il trauma rischia costantemente di essere rivendicato, reale o immaginario che sia: “un trauma senza trauma”, appunto.
Ma il trauma di cui ci parla Han Kang non ha niente di immaginario e la sua scrittura può semmai diventare “esperienza” per il lettore, e aiutarlo a chiedersi come agire sul presente e come guardare al futuro. La letteratura non risolve le questioni, ma può aiutare ad aprire le questioni.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento