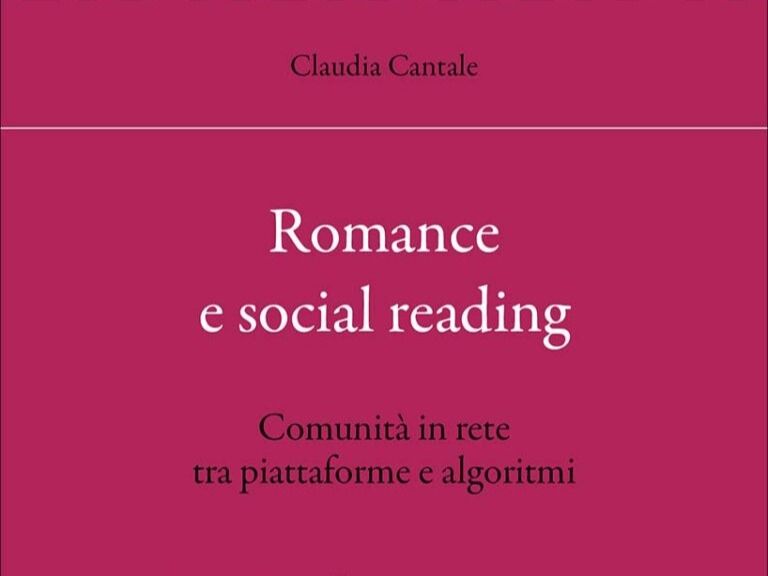
Romance e social reading. Comunità in rete tra piattaforme e algoritmi
Pubblichiamo l’Introduzione a Romance e social reading. Comunità in rete tra piattaforme e algoritmi (Carocci, 2024) di Claudia Cantale. Ringraziamo l’autrice e l’editore per la gentile concessione
Introduzione
Capitava che da bambine io e mia sorella, dopo una impegnativa sessione di gioco sul balcone o nel corridoio di casa, sedessimo ai piedi del divano e insistentemente cercassimo l’attenzione di nostra madre. Ma nulla di quello che di più buffo riuscissimo a creare poteva distogliere la sua attenzione e il suo sguardo dal libro che stava leggendo. Nelle copertine c’erano baci e abbracci appassionati e, nello sfondo, paesaggi mozzafiato che annunciava- no viaggi in località favolose. Insomma erano “sogni a occhi aperti”. L’autrice che mia madre preferiva era sempre la stessa e, almeno questa era l’idea che m’ero fatta io, si chiamava Harmony. Nella “casa vecchia” avevamo uno sgabuzzino che stava in fondo al corridoio (tutti gli sgabuzzini sono sempre in fondo al corridoio) dove mia madre aveva ricavato uno spazio per questi libri dalle copertine sospirose: uno scaffale di ferro che io ricordo ricolmo di pathos. Questi libri non erano come quelli del salotto, che stazionavano immobili da una vita sulla libreria: loro si muovevano da una casa all’altra, passando dalla nostra stanza delle necessità a quella di zia D., dell’amica G., della cugina N. e così via.
Io e mia sorella per la maggior parte del tempo non capivamo a che servissero questi libri, che non erano favole e non erano libri di scuola. Sapevamo solo che nostra madre sprofondava in quelle pagine come presa da una sorta di ipnosi da cui sembrava difficile riemergere. Credo di essere diventata una lettrice, con gli anni sempre meno assidua e sistematica, per emulazione. Per sprofondare anche io in quel sonno profondo, e fuggire attraverso le vite degli altri dalla monotonia della mia di vita. Moltissimi anni dopo tra le mie mani è finita, non per caso, una copia di Reading the Romance di Janice Radway, pubblicato nel 1984. Quel libro ha dato un senso a quale fosse l’uso che mia madre faceva degli “Harmony”, che nel frattempo avevo scoperto essere una collana editoriale e non una scrittrice.
Questo libro è prima di tutto una risposta a un’esigenza personale: capire cosa e chi fa la letteratura rosa. Capirlo in funzione dei mutamenti che sono avvenuti nei quarant’anni dalla prima edizione di Reading the Romance. Ciò che è cambiato, da quando mia madre scompariva dietro la porta dello sgabuzzino per scegliere in quale avventura amorosa sprofondare, è che oggi la nostra vita è digitale, e lo è in tutti gli aspetti del nostro vivere quotidiano. Questo ha conseguenze sul nostro modo di relazionarci, di rappresentarci, di consumare, ha a che fare con il potere, con il nostro corpo e quello degli altri, produce diseguaglianze. Quindi questo libro è stato un modo, per me, per cercare di mettere in ordine le idee sul rapporto tra i libri e il digitale, e in maniera più specifica tra la lettura di consumo e il potere delle piattaforme (Lupton, 2018; Marres, 2017).
Basta entrare in una libreria, e non necessariamente appartenente a una catena editoriale, ma anche in una libreria indipendente, per trovarsi davanti a una sezione in cui Jane Austen è finita accanto ad autrici come Jennifer L. Armentrout, Sarah J. Maas o Erin Doom. È la categoria i libri del #bookok, riconoscibile per la nota musicale in glitch, logo di TikTok. Si tratta solitamente di una decina di titoli esposti a rotazione che fanno bella mostra di copertine glitterate, poste a formare uno scintillante mosaico di tormenti amorosi, avventure fantastiche, drammi giovanili, storie, insomma, che sono state amate o odiate dalla comunità dei booktokers. Nello scaffale dei libri del #booktok troviamo dei veri e propri bestseller, i cosiddetti fenomeni editoriali. Eccola qui, quindi, la dimensione online che sconfina in quella offline.
A chi ha in mano questo libro, non sarà sfuggito il recente dibattito che vede nel fenomeno del BookTok un rapporto causa-effetto con l’aumento delle vendite di libri e in modo particolare del romance di nuova generazione. Qualche anno fa era toccato a BookTube e poi al BookStagram; stavolta tocca al BookTok. Lo storytelling dei media mainstream vede il romance e i booktokers quali forze salvifiche e rigeneranti, in un contesto perennemente in crisi come quello in cui versa l’editoria italiana, che ha un sistema viziato in cui non vi è una vera corrispondenza tra la domanda di consumo e le grande quantità di libri prodotti. Si tratta di una produzione ragguardevole, pari in media a 282 titoli pubblicati ogni giorno dell’anno, cioè circa 12 l’ora, con un rapporto di 1,7 titoli pubblicati ogni 1.000 abitanti (Istat, 2023). Di fatto abbiamo più romanzi e romanzieri che lettori e lettrici disposti a leggerli. A guardare i dati si capisce che la piramide è rovesciata: sono pochi lettori, anzi lettrici, che leggono un numero limitato di titoli. I mezzi di informazione e i dati suggeriscono, infatti, che si tratti di una monocultura del libro, e più precisamente della monocultura della fiction, meglio se romance.
In Italia solo nel 2022 le vendite di romanzi con “trame sentimentali” hanno segnato volumi elevatissimi, tanto che ancora una volta il discorso sui media ha evidenziato l’effetto benefico che essi hanno prodotto per tutta l’editoria. In generale, la letteratura rosa è un genere che non ha conosciuto mai crisi, anzi negli ultimi anni gode di un rinnovato benessere. Il romance ha dimostrato di avere capacità di accogliere le innovazioni e di rinnovare i linguaggi mediali. Ciò è avvenuto al pari del fotoromanzo, che ha risposto all’esigenza degli anni Cinquanta di saziare il desiderio di storie amorose per pochi spicci, facendo convergere in un unico medium i linguaggi del cinema, della fotografia, del fumetto e del romanzo di appendice. Criticato per la scarsa qualità dei suoi contenuti, in Italia ha avuto comunque grandissima diffusione, tanto da diventare oggetto di appropriazione di avanguardie artistiche (Turzio, 2019) e battaglie politiche, non ultima quella condotta nel 1974 da “Grand Hotel” a sostegno del divorzio. Di fatto è para-letteratura militante (Stuppia, 2015). E ancora: le case editrici che pubblicano romance sono state tra le prime ad adottare il formato e-reader, per consentire ai propri lettori e alle proprie lettrici di poter accedere a un’offerta ricca ma ancora più economica. Gli e le amanti del romance infatti sono voraci, leggono intensivamente ed estensivamente, e spesso ricorrono a biblioteche e cataloghi economici.
L’avvento poi delle piattaforme di self-publishing ha ancora una volta contribuito a rinnovare il genere: bestseller come Cinquanta sfumature di grigio di E. L. James, After di Anna Todd e il più recente successo di Fabbricante di lacrime di Erin Doom, nascono su piattaforme di autopubblicazione come Wattpad o efp Fanfiction. Autrici affermate come Colleen Hoover, nonostante possano contare sull’editoria tradizionale, continuano ancora a praticare l’autopubblicazione anche per creare o mantenere un rapporto in- timo ed emotivo con le persone che le leggono, le proprie e i propri fan. Per fare ordine, quindi, nel cap. 1 si tenta di mettere insieme i pezzi dell’evoluzione della galassia rosa (Del Grosso Destrieri et al., 2009) come piattaforma di racconto della condizione femminile, ma anche come terreno di conflitto.
Eppure ancora oggi le lettrici di romance sono stigmatizzate. Questo libro è un percorso di ricerca dentro le comunità di lettrici che tenta di illustrare quali significati e quali effetti sono attribuiti al consumo di romance nel contesto della social reading. Si tratta di una panoramica sulle esperienze di lettura all’interno delle piattaforme social e di intrattenimento quali Wattpad, GoodReads, Telegram e BookTok. Lo sguardo è necessariamente femminista, e deve esserlo perché il romance è un genere fortemente “genderizzato” e perché il potere delle piattaforme consiste anche nel creare
asimmetrie di genere. Nel cap. 2 si dà quindi spazio alla proposta di usare la social reading come strumento interpretativo per cogliere gli aspetti relativi ai cambiamenti delle pratiche di lettura e all’uso sociale del romance.
«L’architettura è politica» (Kapor, 2006, in Bennato, 2011): l’espressione di Kapor sintetizza efficacemente come gli artefatti tecnologici incorporino dinamiche e relazioni di potere che vengono cristallizzate all’interno delle comunità. Per questo ho ritenuto necessaria una descrizione delle esperienze di social reading sulle principali piattaforme quali Wattpad, GoodReads, Telegram e TikTok. Nel cap. 3 vengono quindi descritti i risultati dei meccanismi dei sistemi di raccomandazione, come funzionano algoritmi e affordances e come queste agiscono nella direzione del consolidamento di gusti e tendenze di lettura e di scrittura.
L’esigenza principale delle lettrici di romance è vivere esperienze vicarie o immaginarie. Nella costruzione della fiction rosa, la strategia dell’autore/autrice di romance opera per soddisfare una fantasia romantica che sappiamo non realizzabile, ma di cui alcuni aspetti possono sembrarci realisti- ci. Chi scrive, mascherando il mito di verosimiglianza, produce quello che Radway definisce rassicurazione narrativa, che induce il lettore/ la lettrice ad attuare riti di speranza. Leggere ripetutamente permette loro di reiterare la storia delle eroine per rivivere lo “stato di grazia” (Csíkszentmihályi, 1990). Immergermi nella community dei booktokers italiani mi ha aiutato a comprendere quali sono i repertori di simboli, pratiche e saperi (Swidler, 1986) in relazione agli “ambienti” digitali di socializzazione. Il cap. 4 restituisce, dunque, parte della complessità per illuminare materialmente le pratiche di lettura situate dentro le piattaforme mediante metodi che sono necessariamente “netnografici” (Kozinets, 1998; Marcus, 1995; Hine, 2000; Caliandro, Gandini, 2019).
Il volume si conclude con un’Appendice che riporta l’intervista ad Anto- nio Prudenzano, responsabile editoriale del “Libraio.it”, realizzata da Vanessa Tropea, booktoker, bookgrammer, ma anche lavoratrice dell’industria della lettura. Un modo per raccontare concretamente come funziona il “campo letterario” nel campo del potere (Bourdieu, 2005).
Sono trascorsi quarant’anni dagli studi di Radway e le donne che leggo- no romance sono ancora soggette allo stigma, ma su quello stigma le donne, le ragazze del romance, hanno costruito il proprio orgoglio bookish, fondato sull’opportunità che la social reading ha fornito loro. Trascorrere il tempo della mia ricerca ad osservarle mi è sembrato un po’ come ritornare a quella immagine di me e mia sorella bambine ai piedi del divano mentre guardavamo incuriosite nostra madre viaggiare dietro i suoi grandi occhiali a forma di gatto.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento