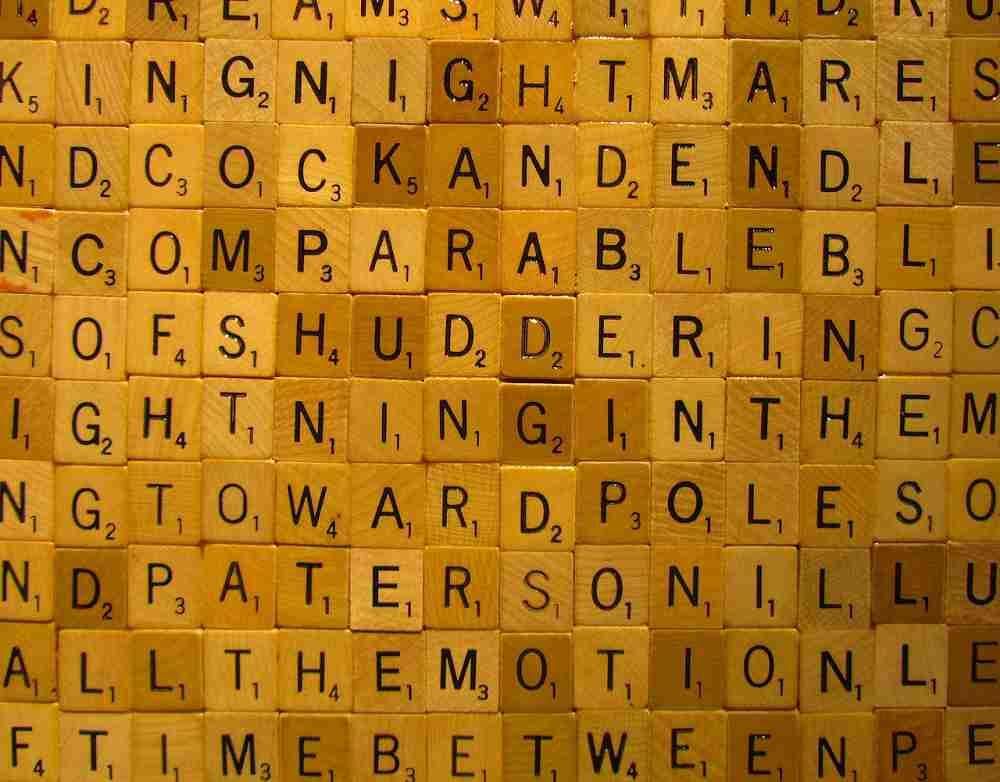
Inchiesta sulle scuole di scrittura /4 – Nadia Terranova
A cura di Morena Marsilio e Emanuele Zinato
Il blog “Laletteraturaenoi”, dopo inchieste sugli editor, sui traduttori, sulle copertine, sulla scrittura per giovani-adulti e sui narratori d’oggi, continua il suo sondaggio sulle forme del lavoro culturale odierno con un questionario rivolto a chi insegna nelle scuole di scrittura: l’appuntamento ha cadenza quindicinale.
Nella sua Introduzione al volume Convergenze del 2010, Remo Ceserani rilevava il persistere di una “straordinaria vitalità della narrazione in tutte le sue forme”: da una parte il genere romanzo, “un gatto sornione dalle sette vite”, dall’altra il diffondersi di un “vero e proprio bisogno di narrazione (…) in pratiche conoscitive che programmaticamente si distinguono dai romanzi”, lo storytelling.
A oltre dieci anni da quel saggio si assiste alla continua espansione delle scuole di scrittura, alcune delle quali includono la pratica dello storytelling nei loro intenti programmatici. Il blog “Laletteraturaenoi”, dopo le precedenti inchieste (editor, traduttori, copertine, librerie indipendenti, scrittura per giovani-adulti e narratori d’oggi) continua il suo sondaggio sulle forme del lavoro culturale odierno con un questionario rivolto a chi insegna nelle scuole di scrittura.
1. Come è approdato/a alla docenza in una scuola di scrittura? Da quanto tempo insegna? Ha frequentato a sua volta una scuola di scrittura?
Ho frequentato una scuola di lettura, quella di Domenico Starnone. Insegno da 10 anni.
2. In base alla sua esperienza quali sono le aspettative di chi si iscrive a un corso di scrittura e quali gli obiettivi a cui un docente può ragionevolmente mirare? Insomma quanta possibilità di incontro esiste tra la molla che muove la “domanda” e le possibilità oggettive con cui l’”offerta” risponde?
Le persone che decidono di iscriversi a un corso di scrittura sono molto motivate, hanno fame e voglia di scrivere. A volte sono timide e hanno bisogno di essere spronate. Il mio ruolo è quello di far venire fuori tutto quello che vorrebbero dire e che spesso tengono dentro. Nel momento in cui un corsista riesce a liberare il proprio estro creativo ha raggiunto già un ottimo risultato.
3. Come i suoi studenti si approcciano al desiderio di esordire e, più in generale, come guardano al mondo editoriale?
I corsisti hanno ambizioni molto grandi. A volte un corso serve anche a misurare le proprie capacità e a rendersi conto di cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Questo dipende anche dal grado di maturità e consapevolezza.
4. Quale peso ha, nell’attività didattica, il momento della lettura? Quali opere si leggono?
Non si può scrivere senza voler leggere. La lettura è pane quotidiano, è concime, è la spinta e la motivazione a scrivere. Probabilmente attraverso la lettura si acquisisce anche la sicurezza per scrivere.
5. Le parole-chiave della critica e i metodi della teoria letteraria vengono percepiti da chi insegna come strumenti di mediazione e di accesso al testo o come astrazioni non pertinenti a questa forma di insegnamento-apprendimento?
I metodi della teoria letteraria sono la chiave d’accesso all’insegnamento. Per avvicinare un corsista alla scrittura e motivarlo c’è bisogno di una certa conoscenza della materia e una forte sicurezza che poi si trasmette facilmente.
6. La nuova, diffusa confidenza con la scrittura acquisita sui social ha contribuito a “desacralizzare” una pratica tradizionalmente riservata a fasce più ristrette. Quanto la “graforrea” (Antonelli) dei media alimenta l’espansione recente delle scuole di scrittura? Fra i bisogni intercettati, quanto è dovuto alla “cultura del narcisismo”?
I social ci hanno avvicinato. Hanno eliminato le barriere di ogni tipo, hanno accorciato le distanze fisiche e ci hanno permesso di soddisfare le nostre curiosità relative alle culture. Ogni avvenimento è come se fosse vissuto in prima persona, ecco perché è importante farne un utilizzo appropriato: per non creare un distacco netto con la realtà e un allontanamento dal desiderio di conquista.
7. Chi scrive oggi spesso si attiene al livello standard dell’“italiano digitato”. In una scuola di scrittura quanto si lavora sulla lingua e sullo stile? Nei corsi che tiene lavora sui testi dei suoi studenti e come? Come cambia la cognizione di chi frequenta i corsi rispetto al fatto che la scrittura “non può insomma avere nulla di ingenuo o spontaneo ma deve essere il frutto di una consapevole ricerca stilistica” (Luigi Matt)?
Io cerco prima di individuare lo stile del mio corsista. Oppure mi adopero per farlo venire fuori. Dopodiché ho la necessità di avvicinarlo a un determinato genere, ma prima devo metterlo alla prova. La costruzione di un’identità letteraria è un procedimento lungo, a volte eterno ma è fondamentale. È la destinazione di uno scrittore.
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento