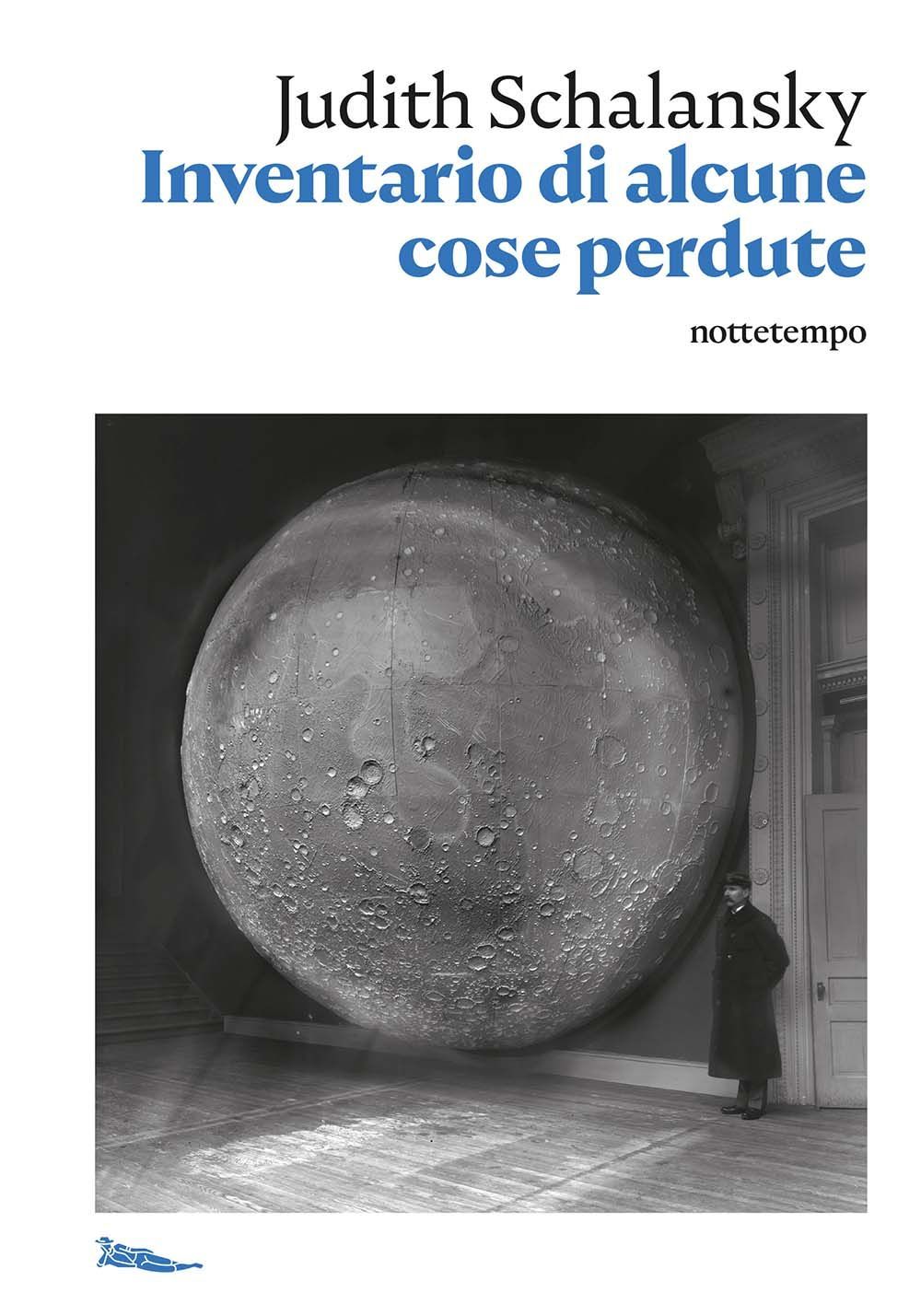
L’esperienza della perdita come origine della cultura in Inventario di alcune cose perdute di Judith Schalansky
«Vivere significa lasciar andare»
Come tutti i libri, anche questo è mosso dal desiderio di far sopravvivere qualcosa, di far rivivere il passato, rievocare le cose dimenticate, dare la parola a quelle ammutolite e rimpiangere quelle che abbiamo mancato di fare. Nulla può essere riportato indietro con la scrittura, ma tutto si può rendere esperibile. Così questo volume parla in egual misura di ricerche e ritrovamenti, perdite e conquiste, e lascia intuire che la distinzione tra presenza e assenza può essere marginale finché esiste la memoria.
Inventario di alcune cose perdute, è questo il titolo dell’opera che è stata tradotta in Italia per Nottetempo da Flavia Pantanella e che nel 2020 ha permesso a Judith Schalanskydi aggiudicarsi il Premio Strega Europeo. È dunque un libro che parla di cose perdute e smarrite, della mancanza e di ciò che non esiste più, perché l’esperienza della perdita, ci suggerisce l’autrice, è all’origine della cultura e della vita: «Vivere significa fare esperienza della perdita».
Se al centro della narrazione c’è dunque l’assenza, Schalansky ci ricorda tuttavia che l’unico alleato che abbiamo, quando si tratta di fare i conti con la perdita, è la memoria. Ma non è conservando ostinatamente tutto che teniamo in vita le cose, in quanto «una memoria che tutto conserva in fondo non conserva nulla». Dimenticare tutto e tentare di fare tabula rasa del passato è grave, ma secondo Schalansky è ancora più grave non dimenticare nulla, perché è solo grazie all’oblio che possiamo produrre conoscenza. In questo senso la cultura ha il compito di aiutare a fare i conti con l’esperienza della perdita, spingendoci cioè a capire cosa desideriamo conservare e cosa deve restare perché possa offrire un senso: «se tutto viene indiscriminatamente salvato, tutto perde infatti di significato e diventa un ammasso disordinato di informazioni inutilizzabili». E proprio la consapevolezza che l’uomo è un essere mortale è sicuramente una delle acquisizioni che dobbiamo conservare, cosa che invece spesso tendiamo a dimenticare. Non è forse con facilità che ci lasciamo affascinare dalla magia apotropaica che ci spinge a voler allontanare il dolore, o le influenze negative che possono condizionare la nostra esistenza, anticipandole nel pensiero? E questo dolersi anzitempo non è, in fondo, un modo per consolarsi, credendosi così immuni da pericoli che possono sopraggiungere inaspettatamente? Ma immaginare il terribile anticipandolo nella nostra mente non serve a scongiurarlo, non è allenandoci alla separazione che il dolore per una perdita diventa più sopportabile, in quanto vivere implica passare attraverso questa esperienza, «vivere significa lasciar andare».
La scrittura come unica possibilità di memoria
Nelle prime pagine del libro la narrazione inizia raccontando la storia di un viaggio che la scrittrice ha fatto in un piccolo villaggio di pescatori in Danimarca, in un villaggio dove il cimitero si trova al centro del paese, proprio dove dovrebbe trovarsi la piazza principale: il cimitero, insomma, è il cuore del paese nel quale si svolge la vita. Questa dislocazione può apparire strana, del resto noi siamo abituati a mettere la vita al centro, e cerchiamo con ogni mezzo di tenere lontana l’idea della morte, vogliamo insomma dimenticarci di essere mortali, ma la morte stessa, e con essa il concetto della perdita, fa parte della vita, e, per quanto questo concetto possa essere doloroso da accettare, occorre accettarlo e prenderne coscienza.
La questione di fondo è quindi chiara, niente può essere ricostituito o riportato indietro, in quanto tutto sembra ineluttabilmente destinato a scomparire; del resto, «il declino di tutte le cose viventi e create è la conditio sine qua non della loro esistenza». Tutto ciò che ancora esiste è soltanto ciò che è rimasto e si è momentaneamente sottratto all’inevitabile fine. In fondo è solo una questione di tempo, poi ogni cosa scompare e si disintegra.
È possibile, tuttavia, ridurre la distanza tra presenza e assenza lasciando spazio alla memoria e cercando di ritrovare quelle cose che lasciano una eco, e che ci aiutano, pertanto, a comprendere l’importanza di ciò che è andato perso. La realtà per prima offre la possibilità di ritrovare ciò che non vediamo e non sentiamo più, e soprattutto di coglierne il valore, in quanto «il mondo in sé è, per così dire, l’immenso archivio di se stesso – e tutta la materia animata e inanimata sulla Terra è il documento di un immane e oltremodo laborioso sistema di scrittura, pieno di tentativi di trarre insegnamenti e conclusioni dalle esperienze passate». Ma è soprattutto grazie alla scrittura che possiamo tramandare le informazioni, scegliendo la linea dei ricordi e delle esperienze che riteniamo più significative e dunque che desideriamo salvare dalla perdita. Ecco allora che in questa prospettiva il libro si configura ancora oggi come il migliore di tutti i mezzi di comunicazione, perché, proprio come una rovina, diventa uno spazio utopico dove il passato può rivivere, un luogo dove passato e futuro diventano una cosa sola.
Inventario di alcune cose perdute non si limita, tuttavia, a raccogliere i ricordi della scrittrice e diventa un vero e proprio archivio, un catalogo di piccoli dettagli capace di registrare le tracce del passato e insieme di mostrare l’irreversibile transitorietà delle cose. Dopo una lunga e dettagliata prefazione dell’autrice, nella quale viene illustrata la tesi che fa da sfondo al volume e dalla quale nasce l’esigenza di questa narrazione, il libro si sviluppa attraverso dodici racconti, ciascuno dei quali è dedicato ad una cosa smarrita, distrutta o soltanto dimenticata dalla storia del mondo. Si tratta di dodici racconti di uguale lunghezza, tutti di sedici pagine, nei quali lo stile varia di volta in volta, ma che trovano coerenza e compattezza nel tono complessivo del discorso, e anche nei collegamenti intrinsechi che stabiliscono tra loro. Alla base di questo lavoro c’è dunque un progetto complessivo che la scrittrice e designer Judit Schalansky cerca di arricchire anche dal punto di vista grafico. Ogni oggetto perduto e protagonista di un racconto è infatti anticipato da una pagina stampata in nero sulla quale è riprodotta con tratto raffinato ed elegante l’immagine della cosa di cui si sta per parlare. Ma decifrare l’immagine non è un’operazione facile e richiede uno sforzo visivo; forse è questo un ulteriore messaggio di Schalansky, che ci invita a riflettere sul potere della scrittura, sull’importanza di stabilire il nero sul bianco, della scrittura che rende visibile l’oggetto e non l’immagine. Insomma, è attraverso il racconto che possiamo ancora ammirare e cercare di rivivere anche ciò che sembra perduto. E Schalansky lo fa realizzando una sorta di Wunderkammer, una camera delle meraviglie che raccoglie oggetti rari e anche bizzarri, tra elementi naturali e opere dell’uomo. Sono cose apparentemente insignificanti che il tempo ha disperso, ma che possono ancora servire a rivelare la storia del mondo, che, secondo la scrittrice, è possibile raccontare proprio partendo dai suoi margini, siano esse isole remote e scomparse, scheletri di unicorni, o anche soltanto gli spazi bianchi in un libro.
Sulle isole perdute
Proprio di isole la scrittrice si era occupata nel libro precedente Atlante delle isole remote, pubblicato da Bompiani e nel quale si parlava di isole che non esistono o che sono lontane geograficamente da tutto e da tutti, e come tali escluse dalla memoria collettiva, isole perdute anch’esse, proprio come quella del primo racconto che apre il nuovo volume e che sembra voler riprendere il filo con la narrazione precedente. Si tratta questa volta dell’isola di Tuanaki, un piccolo atollo una volta abitato e visitato da vari esploratori e poi inghiottito dall’oceano, probabilmente a causa di un maremoto.
Seguono racconti che ci parlano della tigre del Caspio, il cui ultimo esemplare impagliato è andato distrutto in un incendio, o della barocca Villa Sacchetti a Roma, edificata a metà del Seicento e distrutta prima che il secolo terminasse, quando era scoppiata la peste. Anche i versi perduti di Saffo occupano uno dei dodici racconti, e proprio gli spazi bianchi delle poesie consentono alla scrittrice di parlare di valori morali e della sessualità femminile, a lungo considerati uno spazio innaturale e dunque vuoto. Nell’inventario si trova anche il palazzo della Repubblica che ospitava il parlamento della DDR a Berlino est, abbattuto per ricostruire il precedente castello degli Hohenzollern, a sua volta abbattuto come simbolo detestato di ciò che la nuova repubblica voleva cancellare per costruire un mondo nuovo. All’immagine di questo palazzo si intreccia anche la vicenda personale della scrittrice, in quanto proprio in esso finisce il matrimonio tra suo padre e sua madre. Un palazzo che diventa simbolo di una mutilazione, della perdita di un mondo, di affetti, e di relazioni anche personali. E l’esperienza biografica affiora anche quando si parla della tela di Caspar Friedrich Il porto di Greifswald, città natale della scrittrice.
Inventario di alcune cose perdute è un’opera organizzata con molta cura e attenzione per i dettagli, un percorso attraverso ciò che resta della civiltà condotto con originalità e con uno stile colto e raffinato. Se non possiamo recuperare tutto, se il mondo e la civiltà sono inevitabilmente destinati a fare i conti con l’esperienza della perdita, possiamo però affidarci alla speranza che la scrittura possa offrirci ancora qualche “inventario di alcune cose perdute”.
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento