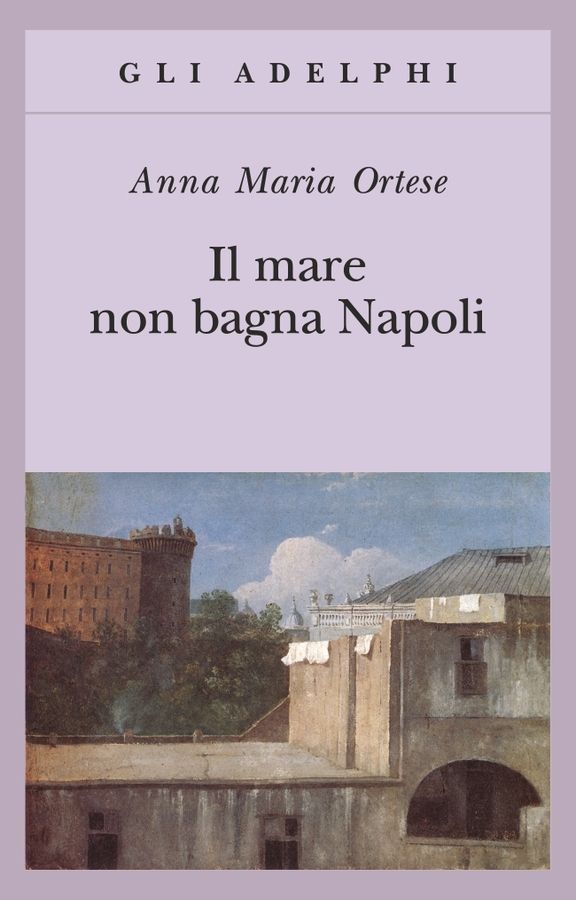
Perché leggere Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese
Il mare non bagna Napoli apparve la prima volta nei Gettoni della Einaudi, con una presentazione di Elio Vittorini. Era il ’53. L’Italia usciva piena di speranze dalla guerra, e discuteva su tutto. A causa dell’argomento, anche il mio libro si prestava alle discussioni: fu giudicato, purtroppo, un libro «contro Napoli». Questa «condanna» mi costò un addio, che si fece del tutto definitivo negli anni che seguirono, alla mia città. E in circa quarant’anni – tanti ne sono passati da allora – io non tornai più, se non una volta, per qualche ora, e fuggevolmente, a Napoli. A distanza, appunto, di quattro decenni, e in occasione di una sua nuova edizione, mi domando se il Mare è stato davvero un libro «contro» Napoli, e dove ho sbagliato, se ho sbagliato, nello scriverlo, e in che modo, oggi, andrebbe letto. La prima considerazione che mi si presenta è sulla scrittura del libro. Pochi riescono a comprendere come nella scrittura si trovi la sola chiave di lettura di un testo, e la traccia di una sua eventuale verità. Ebbene, la scrittura del Mare ha un che di esaltato, di febbrile, tende ai toni alti, dà nell’allucinato: e quasi in ogni punto della pagina presenta, pur nel suo rigore, un che di «troppo»: sono palesi in essa tutti i segni di una autentica «nevrosi». Quella «nevrosi» era la mia. (Il «Mare» come spaesamento, pp.9-10)
Così Anna Maria Ortese ripubblicando per Adelphi nel 1994 la raccolta di cinque racconti (Un paio di occhiali, Interno familiare, Oro a Forcella, La città involontaria e l’articolato e lunghissimo Silenzio della ragione) che le costò ben più che un addio alla sua Napoli: madre adottiva (in verità Ortese era nata a Roma ed era cresciuta, a causa della guerra e delle vicende familiari, un po’ disordinatamente tra la Puglia, la Basilicata e la Libia, girovagando, al rientro dalla Libia, per varie regioni d’Italia, sino a stabilirsi a Napoli solo nel 1945), la città reagì con indignazione all’affresco squallido e dolorante che ne aveva fatto la scrittrice, ritraendola, nell’immediato, poverissimo, disperato dopoguerra, fuori dal suo ridente, folcloristico clichè; neppure lambita dal mare. E non meno si indignarono le Giacchette Grigie di Monte di Dio, ovvero gli intellettuali (Pasquale Prunas, Luigi Compagnone, Raffaele La Capria, Domenico Rea, Tommaso Giglio…), che, ancora giovanissimi, si erano riuniti intorno alla rivista Sud, il periodico nato «contro ogni classificazione, numerazione, sezionamento, contro ogni politica suddivisione del sentimento, contro ogni barriera doganale» (come si legge nell’editoriale del suo direttore Prunas). Di quella redazione Ortese aveva fatto parte finché non le era sembrato che «le discussioni lasciavano il posto alle conversazioni; la politica diventava un motivo per ritornare sul problema di un impiego; le preoccupazioni di una carriera o solo una modesta sistemazione personale si alternavano in una proporzione sempre più forte ai problemi e all’avvenire del giornale e l’indipendenza della cultura (…) cadeva in una piazza sempre meno popolata e sicura» (Il silenzio della ragione, p.115). Eppure, nonostante l’embargo, di quel «comunismo (che) a Napoli, in quegli anni, era un liberalismo di emergenza» (Ivi, p.113) le restò sempre molto più che un ricordo vivissimo, se ancora nel Novantaquattro (sarebbe morta quattro anni più tardi), in occasione di una grande mostra sul Gruppo Sud (Torino, maggio 1994), Ortese poteva scrivere: «Ma la bandiera dell’Utopia, se sventola ancora, almeno nel mio cuore, la devo alle Giacchette grigie di Monte di Dio» (Le Giacchette Grigie di Monte di Dio, p.173).
Dunque perché leggere un libro che suscita nella sua stessa autrice sentimenti ambivalenti, laceranti, contraddittori?
Perché mette a fuoco la intollerabilità del reale
Ortese procede nella rappresentazione della realtà con la precisione di un documentarista. Lo fa dichiaratamente nella città involontaria, percorrendo i Granili (il mastodontico edificio borbonico, originariamente destinato a contenere grano e adibito, al termine delle seconda guerra mondiale, a ricovero per gli sfollati), convinta, com’è, che andrebbero visitati «da gruppi di economisti, di giuristi, di medici» per comprenderne «tutte le sue deformità e gli assurdi orrori» (p.75); la sua descrizione è meticolosa, di una precisione quasi scientifica: lo sguardo della narratrice avanza da lontano, a cogliere prima l’insieme e poi il dettaglio, dall’esterno all’interno dell’edificio, telecamera in spalla:
È un edificio della lunghezza di circa trecento metri, largo da quindici a venti, alto molto di più (…). Anticamente, le mura erano di un rosso cupo (…). Ho potuto contare centosettantaquattro aperture sulla sola facciata, di ampiezza e altezza inaudite per un gusto moderno, e la più parte sbarrate, alcuni terrazzini, e, sul dietro dell’edificio, otto tubi di fognatura (…). I piani sono tre, più un terraneo, nascosto per metà nel suolo e difeso da un fossato, e comprendono trecentoquarantotto stanze tutte ugualmente alte e grandi, distribuite con una regolarità perfetta a destra e a sinistra di quattro corridoi, uno per piano, la cui misura complessiva è di un chilometro e duecento metri. Ogni corridoio è illuminato da non oltre ventotto lampade, della forza di cinque candele ciascuna. La larghezza di ogni corridoio va da sette a otto metri (…) Sui due lati di ciascun corridoio si aprono ottantasei porte di abitazioni private, quarantatré a destra, quarantatré a sinistra, più quella di un gabinetto (…). In ognuno di questi locali sono raccolte da una a cinque famiglie, con una media di tre famiglie per vano. Il numero complessivo degli abitanti della Casa è di tremila persone, divise in cinquecentosettanta famiglie, con una media di sei persone per famiglia. (…) (pp.73-74)
Ma quell’intento è chiaro anche quando non è dichiarato, anche quando lo sguardo della narratrice è filtrato attraverso lo sguardo di un personaggio. È il caso della piccola Eugenia, che, poverissima e miope fino quasi alla cecità, riceve in dono dalla zia zitella (tra riconoscenza e sensi di colpa) Un paio di occhiali: quando li inforca e si guarda intorno per conoscere il luogo dove vive, vede
Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi; gli archi dei terranei, neri, coi lumi brillanti a cerchio intorno all’Addolorata; il selciato bianco di acqua saponata, le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente. (p.33)
È così, avvicinandosi all’oggetto, guardandolo senza riserve e senza concessioni, che Ortese supera quella «irritazione contro il reale», l’avversione epidermica «alla cosiddetta realtà: il meccanismo delle cose che sorgono nel tempo, e dal tempo sono distrutte» (Il «Mare» come spaesamento, p.10), fino a coglierne la «intollerabilità», quella «oscura sostanza», quel «nero seme del vivere» (ibidem), che resiste al tempo in una sorta di eterna putrescenza. È – questo male – inguaribile «cecità»: essa impedisce a quelle «larve» umane (p. 65; p.75, Oro a Forcella; La città involontaria) che abitano i Granili, Forcella, San Biagio dei librai – «razza svuotata di ogni logica e raziocinio» (p.67, Oro a Forcella) – perfino di ricordare «una vita in cui esistettero il vento e il sole» (p.75, La città involontaria); ma quella cecità impedisce anche agli intellettuali di sottrarsi al «ministero nascosto per la difesa della natura dalla ragione» (p.117, Il silenzio della ragione) e di demolire «quei miti, quelle sovrastrutture, quelle gassose aureole che, con l’andar del tempo, si accumulano intorno a una società sformandola, (…) mantenendo nel terrore, nei lamenti, in un vizio informe, occulto, gli strati meno responsabili della popolazione» (Ivi, p.114).
Al contrario degli uni e degli altri, Ortese inforca gli occhiali della piccola Eugenia e guarda. È così che, nel sorriso di un ragazzetto orfano e straccione, «non già più di bambino, ma di uomo, e di uomo avvezzo a trattare solo con prostitute», scorge qualcosa di «misteriosamente maturo», «un giudizio, una valutazione atroce della mia stessa persona» oppure una nota dolce e incoraggiante «in fondo al rantolo del catarro» nella voce di quella «donnetta tutta gonfia, come un uccello moribondo» che la accompagna per i Granili (La città involontaria, pp. 79 e 77). È così che avverte sotto «quel rumore fitto di chiacchierii, di richiami, di risate», sotto quel parlare e vociare «come si favoleggia del popolo di Napoli», «latente e orribile il silenzio, l’irrigidirsi della memoria, l’andirivieni impazzito della speranza» (Il silenzio della ragione, p.134). È così che scorge dietro «i momenti perfettamente banali» di Anastasia Finizio (la zitellona spigolosa che è protagonista di Interno familiare) «una sonnolenza, come l’effetto di uno sforzo sostenuto molti secoli addietro» (p.40).
Conoscere i padrini che tennero a battesimo Anna Maria Ortese (Massimo Bontempelli ed Elio Vittorini) non basta a spiegare questa sua relazione difficile e contraddittoria col reale: autodidatta e fino alla fine povera (dovette ricorrere alla legge Bacchelli), Ortese si colloca fuori dai percorsi riconoscibili delle scuole, siano esse quelle del realismo magico come del neorealismo, e rispetto alle cose, agli esseri umani, agli eventi assume una postura peculiare, esclusivamente sua.
Perché è scritto passeggiando
Un libro scritto passeggiando: così Valeria Parrella ha definito Il mare, nell’appassionato ritratto di Ortese realizzato per la Rai. Ed è vero: la voce narrante, sia essa in prima come in terza persona, racconta mentre si muove o cogliendo il suo personaggio in movimento. Così seguiamo Eugenia nel suo tragitto dal misero cortile dove vive all’elegante negozio dell’ottico che le farà gli occhiali e anche in giro per il suo quartiere; seguiamo Anastasia Finizio mentre, dalla messa, torna a casa dalla madre dispotica, per il pranzo domenicale del quale è sacerdotessa e vittima, e la seguiamo anche per le stanze della casa, senza che si fermi a lungo in nessuna; seguiamo la scrittrice in giro per i luoghi delle giacchette grigie, e ancora per Forcella, e Mergellina, e Chiaia, nel suo attraversamento incessante e inquieto di quella Napoli che il mare non bagna.
In questo movimento risiede sicuramente uno degli elementi di fascino di questi racconti; ma non solo. Lo spostamento è declinato in tutte le accezioni possibili: passeggiata, corsa, viaggio, corteo, fuga, esilio; e chi si sposta non è senza meta, chi si mette in via, è – come scrive Ezio Raimondi a proposito di Renzo – «vittima e cercatore nei confronti di quella realtà complessa, ma insieme così terribilmente semplice, che è la giustizia» (Il romanzo senza idillio, p.175). Di segno assai diverso da quella manzoniana (nutrita della grande riflessione illuminista, passata al setaccio delle Osservazioni), la giustizia di Ortese ha conosciuto la «fede marxista» di quanti si erano battuti (o avevano detto di battersi) «per un ritorno della coscienza» (Il silenzio della ragione, p.114), per una «cultura intesa come conoscenza e quindi coscienza» (ivi, p. 112). Anche lei vittima e cercatrice, si muove partendo da un «nulla di conoscenza del reale» (Le Giacchette Grigie di Monte di Dio, p.174), di cui Napoli sembra essere simbolo, per attingere i «documenti», animata da quella «religione della conoscenza, dei libri, della informazione» (ivi, p.175) che era il credo di Sud. Ma di fronte ai documenti rifiuta di comportarsi come un cronista, come un archivista, come un catalogatore: dovendo scegliere «fra misura e visione» (ibidem), sceglie la visione e, lungi dal compilarne un catalogo, prende quei documenti e li rimette in via, nel movimento narrativo del racconto, recuperando tuttavia – per questa strada – anche quella misura che dolorosamente pensava di avere scartata.
Perché è un punto di riferimento della narrazione breve
Jhumpa Lahiri inserisce senza esitazione Un paio di occhiali nella antologia di Racconti italiani da lei curata: Ortese – scrive Lahiri – «è un punto di riferimento della narrazione breve». Notoriamente più stringente, compatto, finalizzato del romanzo, il racconto breve impone un equilibrio tra le parti – inizio, centro fine – che vieta indulgenza, digressione, diluizione. In questo Ortese è davvero maestra: narratrice in via, non smarrisce mai la sua meta, non risolve mai il suo racconto in un generico vagabondare, ma procede per tappe, a volte registrazioni di avanzamento, a volte stazioni di una laicissima via crucis; un percorso scandito che non permette mai alcun nostalgico ritorno all’indietro. In alcuni casi la scansione è resa esplicita dal ricorso a brevi sottotitoli interni al racconto (Il silenzio della ragione) oppure da una progressione dichiarata dall’esterno verso l’interno (La città involontaria) o lungo un itinerario urbano delineato con la precisione di una mappa (Oro a Forcella); in altri è ancora più raffinata perché, riducendosi le distanze dello spostamento (dalla chiesa a casa o da una stanza all’altra per Anastasia di Interno familiare e da un vicolo all’altro o dal vicolo al negozio di ottica per Eugenia di Un paio di occhiali), nessun forte cambiamento nel paesaggio esterno interviene a segnare i passaggi intermedi, sicché, per misurare l’abisso tra il luogo di partenza e quello di arrivo, la voce narrante ricorre alla descrizione minuziosa del mutamento del paesaggio interno:
Per andare in cucina, Anastasia dovette uscire in un corridoio largo e spoglio, sul quale davano tutte le quattro stanze della casa, illuminato in fondo, dove finiva, da una finestra su un giardino. Adesso, quella finestra era spalancata (…) C’era una bellezza enorme nell’aria, quella mattina, e al confronto le case e la vita degli uomini si rivelavano stranamente misere, logore. Un vero mostriciattolo, poi, sembrò agli occhi turbati di Anastasia la zia… (Interno familiare, p.44)
«Vammi a comprare due caramelle da tre lire l’una, da don Vincenzo il tabaccaio. Torna subito!» (…) (Eugenia) prese i soldi nel pugno (…) e uscì lesta nel cortile. Per un vero miracolo scansò un carro di verdura alto come una torre e tirato da due cavalli, che le stava venendo addosso all’uscita dal portone. (…) Quando il carro fu alle sue spalle, lei, alzando in alto i suoi occhi sporgenti, scorse quel bagliore caldo, azzurro, ch’era il cielo, e sentì, senza però vederla chiaramente, la gran festa che c’era intorno. (…) E pur così piccola e scialba, legata come un topo al fango del suo cortile, Eugenia cominciava a respirare con una certa fretta, come se quell’aria, quella festa e tutto quell’azzurro ch’erano sospesi sul quartiere dei poveri, fossero anche cosa sua. (Un paio di occhiali, pp.23-24)
Ma non è solo una questione di tecnica e di abilità compositiva. La misura del racconto è, come s’è visto, misura etica, quasi metafisica (l’aggettivo è caro a Ortese, che così definisce l’origine di quella sua nevrosi): è strumento di contenimento, argine che impedisce alla visione di tracimare e diventare sogno, illusione, fantasmagoria e la vincola a una sorta di tu devi che le ricorda (se non sempre le impone) la fedeltà ai documenti dei quali è andata in cerca.
Perché è scritto da una donna
Non è un problema di quote rosa. Ce lo ha ricordato recentemente Romano Luperini: «non si tratta di mettere più donne nei manuali di storia letteraria, che di necessità corrispondono a esigenze e valori di questa società e di questo predominio, ma di spiegare perché le donne ne sono state escluse per secoli». Unica donna in una redazione di uomini, scrittrice (e vincitrice di premi) in un’epoca in cui il sostantivo si declinava ancora per lo più al maschile, e tuttavia ignorata e sola fino alla fine, Ortese ci offre forse una delle chiavi utili per comprendere il senso mostruoso di questa esclusione. La critica aperta a quei gruppi napoletani legati alla politica culturale del PCI, la vicinanza all’eterodosso Vittorini avrebbero probabilmente procurato a chiunque fastidi e antipatie, soprattutto dopo il 1948, quando, dopo lo scontro tra Vittorini e Togliatti, la linea del PCI si era fatta più dogmatica. E tuttavia ci fu nei confronti di Ortese un accanimento particolare e duraturo, tanto da autorizzare almeno l’ipotesi che non le si perdonasse, accanto alle sue posizioni, proprio di esser donna, di essersi addentrata, da donna, in un terreno ritenuto ancora esclusivo appannaggio degli uomini; o – peccato ancor più grave – di aver mostrato con la propria stessa esclusione che quegli uomini, che pure lavoravano al cambiamento se non addirittura alla rivoluzione, non erano, nel fondo, rivoluzionari un granché. Non troppo diversamente da quel che Ermanno Rea racconterà – mutatis mutandis – di Francesca Spada, la redattrice dell’Unità, protagonista di Mistero napoletano (1995), morta suicida e sola.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento