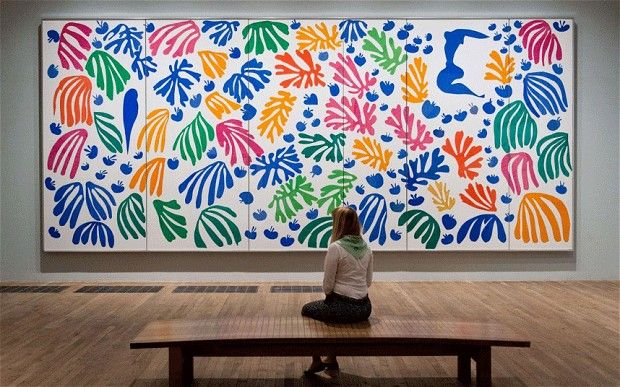
Il critico e il “significato per noi”
Pubblichiamo la risposta di Romano Luperini all’intervento di Demetrio Paolin sul problema dei premi letterari e del giudizio di qualità.
***
Due parole sulla discussione in corso. Diceva Kant che il giudizio del critico è particolare, ma esige di essere considerato universale. In altri termini, il giudizio ha sempre un valore e una implicazione sociale: il critico vuole persuadere tutti che la sua valutazione è l’unica giusta, pur sapendo che altri hanno opinioni diverse dalla sua.
A me interessa questo valore sociale del giudizio, perché solo grazie a tale valore il critico acquista una legittimità nella società. La legittimità non sta nel descrivere i libri, ma nel giudicarli e così collaborare al conflitto delle interpretazioni che si intreccia nella società e magari alla formazione di un canone regionale, nazionale e magari internazionale. Ne deriva una conseguenza ovvia: perché possa mantenere una funzione sociale la critica non può rinunciare al giudizio di valore. È su questo punto che non concordo con l’articolo di Demetrio, che ho trovato molto originale e che comunque contiene molti spunti interessanti e condivisibili. Il critico, svolgendo una mediazione fra testo e tempi attuali, deve enuclearne quei significati che ne possono legittimare la sopravvivenza e tramandarlo al futuro. Compie una operazione allegorica: dimostra che un testo dotato di un significato storico puntuale significa anche altro e che questo altro è attuale e ci riguarda. Il critico cerca il significato per noi di un testo, non scrive per sé, si rivolge a una collettività di cui fa parte. E indicare il significato per noi di un testo significa dirne il valore (il valore è sempre sociale e riguarda sempre una società), esprimere un giudizio.
Rinunciare al giudizio di valore è rinunciare alla critica. Significa obbedire solo alla legge del mercato, per cui l’unico valore è quello di scambio. Tutti sappiamo come il valore di scambio si insinui in ogni nostra operazione e come il tentativo di eluderlo tenda a infrangersi contro la camicia di forza che il capitale ci impone. Demetrio mostra benissimo questo aspetto. Eppure mi ostino a pensare che un valore d’uso in qualche modo comunque resista, sia nella mela che mangiamo sia nel libro che leggiamo. D’altronde una critica che rinunci al giudizio di valore è anche impensabile: il giudizio si insinua in ogni nostra parola, e il fatto stesso di parlare di un libro significa attribuirgli un valore, negativo o positivo, non importa.
Il mondo di oggi destituisce di significato ogni nostra operazione. Lo so bene. Ma, per favore, non collaboriamo con questa distruzione del senso. Se fare critica disinteressata su un blog, è un atto di donazione, che questo atto sia pieno e la mano sinistra non ritiri indietro quello che la destra porge.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento