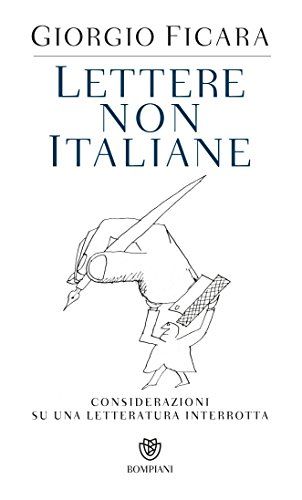
La letteratura come «imminenza». Su Lettere non italiane di Giorgio Ficara
Fine della letteratura
Il torto maggiore – mortale – che si potrebbe fare all’ultimo libro di Giorgio Ficara, Lettere non italiane. Considerazioni su una letteratura interrotta (Bompiani, 2016) sarebbe quello di liquidarne, preventivamente, la tesi di fondo “apocalittica” – la discontinuità tra gli scrittori attuali e quelli del passato; la frattura, netta, con la tradizione – con l’arma impropria del letteralismo: perché Ficara dice e non dice che la letteratura italiana è finita.
Certo, innanzitutto, lo dice, mentre, nei primi due capitoli, passa in rassegna le tesi degli “apocalittici” e dei “continuisti” sull’argomento. Ci troveremmo di fronte a
una discontinuità formale e fondamentale tra contemporanei e moderni, mai registrata nella nostra tradizione. Manzoni e Gadda, ad esempio, sarebbero continui, Gadda ed Eco discontinui. Non si tratta di alto e basso, Literatur e Trivialliteratur, quanto propriamente di valori un tempo equiparabili, oggi non più equiparabili» (p. 5, corsivi originali).
I tempi nei quali esistevano una letteratura “alta” e una letteratura “popolare” o “di consumo”, il margine superiore e quello inferiore di un medesimo sistema, sono finiti. Non saremmo davanti a un rimescolamento all’interno di tale sistema, ma davanti a un vero e proprio cambio di paradigma, se persino Umberto Eco – non Moccia o Volo – appartiene a una postletteratura (perché, secondo Ficara, del tutto privo di fiducia nella forza conoscitiva della letteratura, e perché, secondo Berardinelli citato da Ficara, pur sapendo tutto, «non sa che cosa scrivere»).
Il discrimine tra linguaggio della letteratura e linguaggio dell’informazione si è assottigliato, addirittura non è più tracciabile: la letteratura è ridotta a «b-literature» (calco da b-movie), è una letteratura-informazione di pura diegesi; e se quello di “raccontare storie” è per l’uomo un atavico bisogno, rispettabilissimo, le storie, però, «prive del freno o dell’intoppo della critica, non sono nulla» (p. 80).
Che cos’è questa «critica» di cui parla Ficara? È «balbuzie», «distrazione, capogiro, inciampo sul cammino diritto delle idee», «è quel vuoto perfetto che, in relazione al continuum delle storie stesse, potremmo chiamare pensiero»: è, in sostanza, l’idea che sia ormai impossibile scrivere da “ingenui”, perché l’arte è ormai possibile solo in forme “sentimentali” (la distinzione è ovviamente quella di Schiller, ma ripresa ultimamente da Pamuk in un suo libro: Ficara ne discute). Peraltro, nel corso del Novecento è diventata impossibile una narrazione che proceda fiduciosa in avanti a tempo di marcia, essendo precarie e compromesse le categorie di tempo e spazio. Per questo, se anche ai nostri giorni esistesse un Tolstoj, non potrebbe più scrivere Guerra e Pace: «oggi una diversa “impressione” di labirinto e di ostacoli imbroglia l’affaire della rappresentazione» (p. 151).
Si tratta di un’idea che, se non è la stessa, almeno ha un’aria di famiglia con un’altra, cara al critico, che l’ha messa al centro del suo Casanova e la malinconia. In quel libro la figura del libertino settecentesco, che passa da una donna all’altra, da un paese all’altro, in un moto perenne e spontaneo assolutamente settecentesco e materialista («Tanto moto, tanta gioia»), e che rispecchia questo movimento vitale nella scrittura della Storia della mia vita, viene studiata in quei momenti nei quali il moto perpetuo sembra non bastare più e Casanova si perde, malinconicamente, a riflettere su di sé, sulla sua storia, sul suo senso.
In Italia può esistere una letteratura d’intrattenimento?
Questo assillo o inciampo nella rappresentazione, in Italia, sarebbe più forte che altrove, costitutivo di una specificità della nostra letteratura: «Il romanzo italiano […] fin da principio (da Manzoni) e fino a Gadda, a Fenoglio [in un altro passo Ficara arriva però fino a Tondelli], scelse non la via della progressione narrativa, ma la via linguistica […] in cui la chiarezza dell’informazione globale necessariamente si intorbida» (p. 28), così che è possibile dire che «in Italia non sia mai stato il tempo del romanzo se non in quanto romanzo-saggio, cioè in definitiva critica» (p. 32). Il romanzo italiano, diversamente da quello inglese o francese – il novel puro – è, da sempre, «trauma», linguistico e filosofico, rispetto alla felicità narrativa: il padre è infatti quel Manzoni costretto a costruire da sé la propria lingua e profondamente angosciato dalla legittimità stessa della narrazione di fronte alla storia, ma anche quel Manzoni che ignora l’invito dell’“ingenuo” (schillerianamente) Goethe a eliminare quei capitoli dei Promessi sposi nei quali storiografia, erudizione, economia, rendevano faticosa la lettura e impura la trama. «A differenza di altre letterature, la letteratura italiana è tutta “alta” e il “basso” (l’entertainment degli anglosassoni […]) non è che una finzione dell’alto» (pp. 86-87), perciò «la tradizione linguistico-narrativa italiana, dopotutto, è quella che è: è un valore unico nel mercato globale, non negoziabile e forse del tutto fuori corso; una chiave non barattabile con quella del novel classico» (pp. 88-89, corsivi originali).
Ma è possibile rivendicare ancora alle letterature nazionali un genio specifico che le rende, perciò, intraducibili? Non siamo abituati a pensare che, grosso modo, tutto sia intercomprensibile ed esportabile, dai noir scandinavi ai big anglosassoni ai premi Nobel orientali? E non parliamo ogni giorno di globalizzazione e multiculturalismo? Eppure, fino a qualche decennio fa comprendere che la musica sinfonica è tedesca e il melodramma è italiano appariva perfettamente naturale.
Non so fino a quali conseguenze, diciamo materiali, Ficara voglia portare questa sua tesi “forte”. Mi pare, però, che sia del tutto legittimo e utile domandarsi, “malinconicamente”, quali accenti particolari non siamo più in grado di percepire nella letteratura, e perché, in questo nostro mondo nel quale siamo circondati da quella che Heidegger chiamava “chiacchiera”, ovvero quel linguaggio che nomina la cosa scivolandone sulla superficie, senza alcuna necessità di fare presa su di essa.
Un dialogo infinito
La letteratura italiana è perciò finita. No; almeno, non del tutto. Anzi, a giudicare dal numero di scrittori contemporanei che popolano Lettere non italiane, Ficara sembrerebbe voler confutare, con un buon numero di eccezioni, la validità della regola da lui stesso stabilita. La seconda parte del libro, infatti, è interamente dedicata a scrittori italiani del canone (De Sanctis, D’Annunzio, Novaro, Montale, Gadda, Landolfi, Tomasi di Lampedusa, Pasolini, Zanzotto, il maestro Giovanni Getto) e contemporanei. E se, fra questi ultimi, solo La Capria, Biamonti, Arbasino, Rasy, Atzeni, Conte, Berardinelli, Cordelli meritano un capitolo tutto per sé, per il consenso o addirittura l’ammirazione che suscitano, il critico intesse un dialogo partecipe e curioso con diversi altri interlocutori: Piperno, Perrella, Affinati, … Troppi, per chi sembrerebbe aver dichiarato la bancarotta della nostra letteratura.
Ficara è dunque diviso tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà? La sua critica militante, la sua attenzione per il contemporaneo, sono solo atti di fede controfattuali e, in fondo, disperati, in un mondo che ormai è postletterario?
Per rispondere, vale la pena osservare le modalità del suo discorso, anzi, più che le modalità, le movenze, visto che si tratta soprattutto di un movimento di pensiero percepibile in atto nello stile.
Ficara non crede alla critica come atto esterno alla letteratura e a questa come semplice “oggetto di studio” della prima («gli stessi critici del Novecento sono scrittori del Novecento», p. 56; «il conformismo delle scienze esatte (quali?) applicato alle arti», p. 209), né ama quell’esercizio di degustazione che si limita a spiegare se un libro sia ottimo, passabile o pessimo («la simpatia è formalmente analoga all’antipatia. Non è un gesto critico»: p. 91).
Per lui la critica è innanzitutto un dialogo personale e un confronto serrato con gli autori, un incremento linguistico e concettuale della loro opera. Ecco perché crede che la stroncatura a un libro contenga molta più intelligenza di un sobrio e svogliato plauso, o di una garbata e pavida perplessità («l’intransigenza è “instauratrice” al pari dell’ammirazione»: p. 56): anche perché, a far le scintille contro quella stroncatura e a lasciarci ammirati, potremmo sempre aver la fortuna di veder apparire sulla scena un elogio contenente altrettanta intelligenza.
Se Ficara definisce stili e immaginario di un autore o circoscrive analiticamete dettagli, non lo fa mai in forme assolute o definitive, o per giungere a una chiarificazione obiettiva del loro valore o disvalore: ama le ipotesi, i modi ottativi, le tesi-antitesi dialettiche, che permettono di costruire un di più di senso a partire dal testo in esame.
Eccolo perciò indugiare, tra sic et non, tra speranza e mesta constatazione: «Nonostante tutto, non so più che cosa sia un romanzo. […] Ma so che oggi, come ieri, il romanzo è vivo o non è ancora perfettamente morto. I generi letterari, dopotutto, non muoiono improvvisamente, ma lentissimamente» (p. 75); salvo poi rimettersi ulteriormente in discussione: «eppure la mia fede vacilla», la «vita resistente del malato, che io riscontro ottativamente nel romanzo contemporaneo, è una chimera». Ed eccolo, ancora, mescolare “se” e scorcio autobiografico (scorcio che è a sua volta mise en abîme della critica come autobiografia): «In effetti, se il “Giacomino” (Debenedetti) che Getto citava spesso con un sorriso enigmatico, avesse avuto ragione e la critica, quella vera, non fosse che una forma particolarmente sofisticata dell’autobiografia, in tutti i libri di Getto si potrebbe documentare una bruciante – autobiografica – vocazione alla trascendenza» (pp. 317-318).
Questo dialogo infinito e queste oscillazioni eterne tra sì e no, affermazione e negazione, sono la storia stessa della letteratura, con le sue tradizioni e controtradizioni, con l’alternarsi della fortuna critica di un autore, con il dibattito intellettuale e artistico condotto come se ogni affermazione in questo campo fosse dettata da un’urgenza storica e da un’assoluta necessità vitale.
Oggi tutto ciò sembra però essere realmente minacciato e sembra di vivere solo il tempo della cronaca, non più della storia. Innanzitutto perché ormai «è la realtà stessa che, oggi soprattutto, sfugge ai narratori […] o, ancora, è una realtà non così reale da guidare e ispirare i romanzieri nella sua rappresentazione» (p. 122, corsivo originale): la società dello spettacolo ha derealizzato la realtà, l’ha stipata di rappresentazioni, così che essa ci viene nascosta, più che rivelata, dalle molte narrazioni che ci assediano, lucide, ludiche, anestetizzanti («Certi libri sono “brutti” […] perché rispetto all’attuale pena del mondo scelgono un falsetto estetizzante, disumano, pigramente ricorsivo», p. 31).
A questo stato di cose, osserva Ficara, è velleitario se non ormai ridicolo e fuori tempo massimo opporre qualche “no” neosperimentale e resistente al mercato, «estrema caricatura di vecchissimi “antagonismi” anni sessanta e della loro facile e falsa teoresi» (p. 91). La resistenza, se è possibile, non si organizzerà certo con attacchi frontali, ma a partire dai margini, sul filo del rasoio che sta tra facile sì e facile no, in una sovversione non chiassosa e non programmatica. Proprio perché laterale e non programmatica, questa resistenza è attuabile per molte vie, come dimostra la varietà di voci di scrittori italiani contemporanei con cui Ficara ha scelto di confrontarsi negli ultimi capitoli. Un altro torto mortale che si potrebbe fare al libro di Ficara è infatti quello di concentrarsi sulle tesi della prima metà, leggendo distrattamente questa seconda pars construens (e sempre che in una scrittura così avvolgente e spiraliforme si possa davvero riconoscere una partizione strutturale così netta): perché lì è il lievito “progressivo” del libro.
Una letteratura che non finisce di finire
«Debole com’è, l’arte è più reale (cioè razionale) della realtà vera e propria» (p. 169). Questa realtà e razionalità dell’arte, di sapore hegeliano e soprattutto desanctisiano, è però anche una qualità sommamente umana, ciò che rende tollerabile – ma anche, in effetti, civile e dignitoso – il nostro stare al mondo: è quell’arte che finirà soltanto quando finirà la pena dell’umanità, cioè l’umanità stessa, come affermava un Montale “umanistico” nel discorso per il Nobel; ma è anche quell’arte usata come piccolo barlume di ragionevolezza e illuminismo in una realtà storica brutale e caotica nei nostri Manzoni, Leopardi, Gadda.
Ma il sogno desanctisiano di una letteratura che si fa fonte di civilizzazione di una nazione – e in cui sembriamo credere (inerzialmente?) ormai solo noi italiani nelle nostre scuole – non si è realizzato. Eppure, osserva Ficara, quel sogno non si compie nel presente – in nessun presente –, bensì agisce sempre in una dimensione di «imminenza», seguendo un blochiano «principio-speranza» per il quale una letteratura che non cessa di finire, è pur sempre letteratura: è dire l’“ultimissima” parola sull’uomo, dopo che l’ultima sembra ormai essere stata detta. Ma questo sarà possibile solo a patto di preservare l’idea che esistano cose che si possono «dire solo poeticamente», perché la letteratura è, come voleva Montale, «“stregoneria” grazie alla quale delle idee ci vengono trasmesse necessariamente “attraverso parole che tuttavia non le esprimono”» (p. 13).
Anche il discorso sulla fine della letteratura italiana o della letteratura tout court, perciò, è probabilmente una “stregoneria”: parlando della fine, tuttavia, ci trasmette ben altre idee.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento