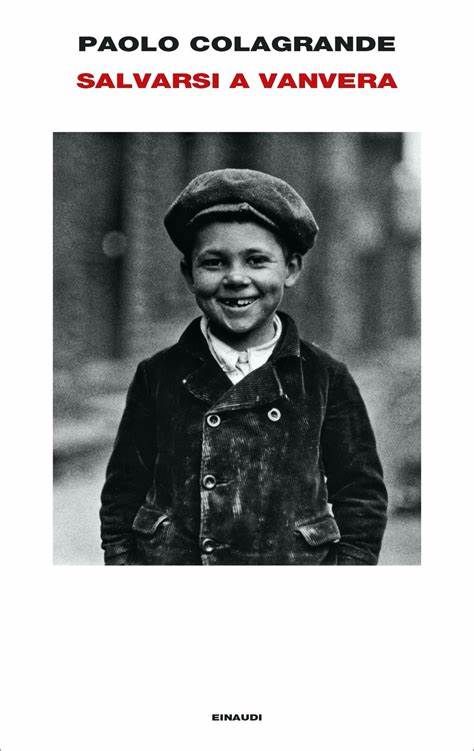
“Salvarsi a vanvera”: Storia e favola bella nell’ultimo romanzo di Paolo Colagrande
Il gesto di mio babbo Aràd che alza con la mano sinistra la visiera del cappello non rientra nella meccanica del corpo umano: è un passaggio trasfigurativo, se non disturba la parola, un cambio di inclinazione del pensiero che cerca spazio oltre il suo ingombro.
Sto cercando di semplificare un concetto in frasi scorrevoli. Ma non bastano delle frasi per spiegare una figura in movimento: la visiera di un cappello che si alza e la curva di un pensiero che scompare dietro il panorama.
Dietro il panorama mio babbo Aràd cercava le cosiddette soluzioni possibili, che abitano lì, oltre il mondo dei fenomeni e sopra le visiere dei cappelli, dove ci porta il sospetto e dove non arrivano le speranze. Mio babbo Aràd viveva di sospetti, più che di speranze.
(Paolo Colagrande, Salvarsi a vanvera, Einaudi 2022, p. 3)
Se il vero non merita stima
Estate 1943. In un piccolo centro nei pressi del Rio Fogazza vive l’ebreo Mozenic Aràd con la moglie Odolinda Salvata, detta Dina, e le figlie gemelle, la giudiziosa Maddalena (detta Giamina) e la effervescente Maria (detta Cina), che da adulta racconta la storia in prima persona.
Si veniva da grandi prospettive, dove tutto doveva scorrere senza intralci con la forza motrice di una nazione monumentale in rapida espansione, per citare frasi di moda. Questo valeva dappertutto, perfino nel sottomondo della nostra città di piazza. Dentro la città di piazza c’era casa nostra, con mio babbo, mia mamma e noi due gemelle, di fianco all’insegna D’Elisir, generi alimentari e coloniali. (p.7)
Di intralci in verità non ne mancano nemmeno in quella piccola città di piazza: la guerra ha già fatto tanti morti, razionato i beni di consumo, devastato le campagne e indotto chi, come il babbo di Cina, viveva di sospetti, a cambiare aria o almeno a cambiare nome; e infatti Mozenic Aràd è diventato Mestolari Aride. Tuttavia
Dal passaparola stonato fra radio, giornali, leggende e voci del popolo comune, sembrava che le truppe angloamericane guadagnassero terreno, anche se col passo a singhiozzo: liberavano città e paesi, sganciavano bombe a pioggia, battevano moneta, eccetera eccetera. Qui di bombe non ne arrivavano, ci si affidava al presente di adesso e di appena dopo, nel bene e nel male, dove il male era sotto gli occhi e il bene era che non stava capitando il peggio. (p.153)
Il lungo racconto di Cina procede dunque senza fare sconti al bene e al male; e talvolta il male diventa il trampolino inatteso del bene, come capita a chi vive sull’onda della vanvera (ad Aràd come alla stessa Cina):
Diceva mio babbo Aràd che la vanvera è come la ridarola, è un meccanismo autogenerato che riposa in un’area spirituale arcaica, veterotestamentaria del cervello, e rovescia le sue onde sul mondo come un maremoto. Sotto l’effetto della vanvera – diceva sempre mio babbo Aràd, che come tutte le persone taciturne entrava spesso in questo meccanismo – tu parli con lo stesso flusso pedante di una radio o di una turbina.
Ma la cosa prodigiosa della vanvera è che, attingendo a un’area inesplorata della psiche, spesso raggiunge strati di verità pura, che la mente ha archiviato a nostra insaputa, chissà quando e chissà come, e senza un’occasione pratica e contingente. Diciamo che il germe della vanvera riposa nel nostro inconsapevole stadio metafisico. (pp.82-83)
È appunto cavalcando l’onda della vanvera che Aride Mestolari si presenta alla Direzione Generale per la Sicurezza dell’Impero, «che aveva sempre il compito di preservare il corredo genetico collettivo da pericolose contaminazioni mantenendo intatta la pura fratellanza con il tenace Stato germanico» (p.14): uomini «con un elmo a forma di pitale, la divisa color vomito della nazione affittuaria e il Mauser karabiner tenuto a stretta misura» (p.21) gli hanno già portato via il camion da trasporto della Ditta nonché la bicicletta e sistematicamente fanno razzia delle provviste conservate nei magazzini e destinate alla gente del paese. Il comandante Aginolf Dietbrand von Appensteiner non ci vede chiaro, dietro quell’azienda e dietro quel nome che pare spuntato dal nulla:
abbiamo il dovere di controllare le società anonime, come la sua, perché lì può nascondersi il nemico del popolo o dell’impero, diciamo della razza; non è il suo caso,(…) lei non si nasconde (…), ma capirà, per essere colpevoli basta trovarsi sulla riga di un elenco dove si è finiti forse per sbaglio (p.36).
E su quell’elenco non c’è soltanto Aràd. Ci sono una professoressa, tre orchestrali, un poeta, un etologo e molti altri ancora: un coro di personaggi vitali, surreali e autentici, inconfondibili pure nel gruppo foltissimo e variegato – per genere, cultura, età – di cui fanno parte. E poi c’è Cali, un bimbo di quattro anni che Aràd ha raccolto alla stazione: viaggiava da solo, Aràd l’ha preso per mano, l’ha portato a casa e Dina, lavandolo, gli ha trovato «la spia, quella che avevano addosso tutti i maschi di un certo corredo genetico» (p.10). È l’unica notizia certa che hanno di lui – che rifiuta di parlare –, ma è sufficiente a indurre cautela nella ricerca, perseverante e rocambolesca, dei suoi familiari. Le gemelle lo intrattengono leggendogli il Corrierino; e lui ride, e, di tanto in tanto, sparisce. Finché un giorno, di ritorno da una di queste sparizioni sul greto del Rio Fogazza, Cali arriva tutto nero di carbone. Su quella vena nera e inesplorata va a pescare la vanvera di Aràd, traendone quell’idea «che poteva servire a tenere a bada la belva finché l’agonia non fosse arrivata al suo approdo naturale, dove anche la creatura più malefica non ha più la forza della crudeltà» (p.72). Nasce così la Mineraria Rinascita, una impresa estrattiva ufficialmente destinata a fornire carbone allo stato maggiore («che in quel periodo non si sapeva però chi fosse, perché non si sapeva neanche in che nazione ci si trovava, e neanche se questa ipotetica nazione in guerra avesse uno stato maggiore», p.101), nella quale trovano impiego, con le mansioni più ovvie ma anche con quelle più disparate, parecchi dei soggetti presenti nell’elenco di Dietbrand. Chi o cosa tiene dunque lontano il sospettoso comandante? È la salamandra ignifera gigante cinese:
è una creatura immaginaria, frutto di credenze popolari, ma dietro ogni credenza, così come dietro ogni paura, diciamo dietro quello che non riusciamo a spiegare, c’è sempre un segno, un’impronta, un mistero che parla e una ferita che sanguina. (…) La leggenda dice che questa particolare salamandra, considerata creatura spirituale del fuoco, cerca il suo sposo in qualunque cosa vivente o semovente (…) e siccome la salamandra può vivere in mezzo alla fiamma senza dolore, per riconoscerlo gli getta addosso la vampa infuocata. (p.81)
Difficile per questo trovare manodopera al di fuori di quell’elenco lì, che a quel punto diventa serbatoio obbligato di persone da immolare senza troppe remore. Tanto più che la salamandra – o forse il lanciafiamme del mite partigiano Bellico? – sembra colpire davvero i pochi ufficiali incaricati di sorvegliare la miniera. Così, tra drammatici rastrellamenti e serpeggianti azioni sovversive, tra sospette esplosioni di fabbriche e blindati e minacce di rappresaglie, l’attività della miniera procede come quella di Penelope sulla sua tela: esaurita la vena, si scavano nuove gallerie la cui destinazione non è sempre esattamente quella di attingere nuovi giacimenti di carbone: «Del resto non si era trattato di salvare una vita sola ma, grazie alla miniera protetta dalla salamandra ignifera gigante cinese, di salvarne un bel numero» (p.336). Non tutte, perché, per quanto sia bella la favola, con tanto di apparente lieto fine (non è casuale, sulla quarta di copertina, l’accostamento a La vita è bella e Train de vie), «il comando germanico e quello repubblicano organizzavano (…) i programmi di reinsediamento di cui si sapeva solo la prima parte, i raduni alla stazione» (p.308):
E adesso, stando davanti a questa bocca di terra, (…) a riflettere se era giusto o meno che mio babbo Aràd diventasse Aride Mestolari per congiuntura anagrafica, chiudo gli occhi e guardo Ciociana che sale in corriera con la fisarmonica a bottoni stretta fra le braccia, vicina a sua mamma e a suo babbo; e anche se è difficile crederci, la vedo poi scendere dalla corriera e salire di forza su un treno, ma prima che salga c’è qualcuno che gliela strappa di mano. E in questo quadro, che fino a quel momento è nitido e vicino, non riesco più a guardarla in faccia senza pensare che il suo morire comincia proprio lì, dalle sue mani di tredici anni a cui viene strappata la fisarmonica. (…) E in questa galleria riaperta per gioco o per curiosità di chi vuole reinventarsi una storia, non ho avuto neanche per un momento la tentazione di entrarci e far quel giro incrociato, perché mi spaventano i movimenti perpetui. Ma se davvero qualcuno vuol reinventarsi una storia deve partire dall’ultimo respiro di Ciociana rimasta senza fisarmonica a bottoni. E se Ciociana non è stata salvata, cosa vuoi che conti tutto il resto, compresa questa bocca di terra? (p.338)
E mentre «alla fine Aride Mestolari ha mantenuto il suo nome acquisito insieme al suo slittamento dialettale che era l’eco del nome originario» (p.336), Aginolf Dietbrand von Appensteiner è diventato per amore «Piero Servadio di anni cinquantatre, professione manovratore tranviario» (p.299) perché
il vero non merita troppa stima: è una fabbrica di problemi che solo il falso risolve. L’unico problema del falso è di avere in comune col vero una finitezza fisiologica: cioè, fin dove ci porta? E in fondo (…) qui è tutto un susseguirsi di falso che guarisce e depura il vero: i programmi del Supremo Cancelliere, densi di verità e di truffa, le parole urlate dall’ardito, ieratico e inutile condottiero, l’alleanza fra le nazioni, le trecento tonnellate di carbone della miniera, i bollettini di guerra dove si invertono le vittime e i carnefici. (….) Resta sempre da capire dove andiamo. (p.300)
La morale di Serse
Dunque: «fatti veri dove recitano maschere di verità e di menzogna» (p.263). Tra i fatti veri, la professoressa Emilde, «quasi una sacerdotessa dei santuari di Delfi» (p.263) (e personaggio per il quale chi scrive e anche – immaginiamo – chiunque legga non può non provare ammirazione incondizionata), durante una delle notti solitarie e guardinghe trascorse in miniera, racconta al dissidente serbo Borislav la battaglia di Salamina (pp.259-263; tra le migliori del romanzo). L’arrogante re persiano Serse non ha capito di essere stato attirato dall’arconte ateniese Temistocle in un tranello e, certo di avere la vittoria in pugno, ha fatto piazzare un trono d’oro sul punto più panoramico dell’altura dell’Egaleo, «in modo che lui possa godersi lo spettacolo della caduta del mondo ellenico» (p.260). Da quell’altura vede invece consumarsi la disfatta sanguinosa della sua poderosa flotta, incagliata nelle strettoie di Salamina. Emilde ne trae una interessante morale, che prova a estendere ai suoi giorni e dalla quale, con buona onestà intellettuale, potremmo anche noi trarre lezione utile ai giorni nostri:
Però, andava avanti l’Emilde, nell’antichità si provava a ribaltar la visuale, guardando i fatti dalla parte dei vinti, cioè degli uomini e dei comandanti delle navi imbottigliate nello stretto con uno sbarramento armato che non si aspettavano; dallo sguardo di un re che deve rivedere autocriticamente i fatti. Ecco, (…) questa è una morale che i comandi delle divise tedesche e dei loro sguatteri della repubblica non capiscono: lo scacco (…) segna la fine di questo assedio, ma loro non si piegano al volere degli dèi, per due ragioni precise: la prima è che sono tonti, la seconda perché non hanno basi culturali, non sentono i lamenti del coro, il dolore salvifico della tragedia che tocca padri e figli, antenati e discendenti. C’è solo l’insipienza dei muscoli, nient’altro. Dopo questo smacco, diceva sempre l’Emilde, saranno inveleniti, che è la reazione naturale dell’ignorante che non vede oltre la sua boria e la sua collera, e che non mette fiori sull’umiliazione subita. Se lo facesse, gli dèi gli porterebbero benevolenza. Ma figuriamoci, vorranno sterminare paesi interi. Difficile guardare le cose dalla parte dei vinti. (pp. 261-262)
Finalista al premio Manzoni, Salvarsi a vanvera ci induce a ragionare su una nuova declinazione di romanzo storico; e non solo perché la vicenda evoca fatti storici più o meno recenti, e a tratti prova perfino ad accostarli tra di loro, non solo perché quei fatti costruiscono la vicenda, la generano e non si limitano a farle da fondale, ma perché, ponendosi nel solco di una tradizione che ha nelle genti meccaniche e di piccolo affare e nei vinti gli attori principali di un percorso secolare di riappropriazione della Storia, imprime ad esso un orientamento diverso, rinnovandolo dall’interno; e ciò a partire proprio dalla fisionomia del coro, in cui le voci e le azioni delle genti meccaniche si intrecciano con quelle delle “genti intellettuali” (l’insegnante, i musicisti, l’ingegnere, il poeta, l’etologo, il ballerino, il bibliotecario…) e convergono nel luogo-simbolo della miniera e, più in generale, nell’operato silenziosamente solidale della gente comune.
Esemplare, a questo proposito, la catena – postale e umana – che si mette in moto per ritrovare la famiglia del piccolo Cali: degna di una peripezia alessandrina e inclusiva, pertanto, di oggetti di riconoscimento e talismani, passa dal pensionato cavalier Celerino Scovaloturco (incantevole il talento di Colagrande per i nomi), proprietario della tessera ferroviaria scaduta trovata nella giacca di Cali, alla manicure Marie Nicole Amaretto, per approdare, attraverso molti passaggi intermedi, alla elegantissima valigia di Alondra Vivant, nom de plume della zia del bambino, scomparsa mentre tentava di sottrarlo a uno di quei «raduni di reinsedimento che qualcuno ha cominciato a chiamare campi di annientamento, con un salto semantico che chiarisce molti misteri» (p.356), inclusa la sparizione di padre e madre (con finale che lasciamo a lettrici e lettori del romanzo).
Cina ripercorre e ricuce la Storia e le storie; ma, a differenza di quello Che a’ suoi figli narrandole un giorno,/ Dovrà dir sospirando: io non c’era, questa voce narrante percepisce con colpevole sollievo il non esserci stata se non al modo di una ragazzina che traduceva la realtà dolorosa nelle strofe (irresistibili: chi scrive ha riso col sonoro) lievi, surreali e salvifiche imparate da Fortunello; e sente, al contempo, il dovere di esserci ora e di fare memoria ascoltando le voci di chi c’era allora, cercando la lucidità della distanza, guardando senza infingimenti e revisionismi le voragini scavate dalla miniera e dalla Storia nella collina e dentro ognuno di noi:
Insomma le cose non bisognerebbe mai vederle troppo da vicino, come sto vedendo ora questa bocca di terra: preferisco le scene in lontananza, dove vedi già con l’occhio della memoria che ti tiene fuori dall’imbarazzo di te stesso e degli altri. E allora alzo la visiera di questo cappello stupido di paglia che non porterei mai in testa se non fosse per via del sole a perpendicolo, e dico a questi signori sorridenti: non c’è più niente, qui, è solo un buco nella terra, nella pancia della collina (p.361-362).
La lingua del coro
Più volte, soprattutto quando uscì La vita dispari (Einaudi 2019, Selezione Campiello), a proposito dello stile di Colagrande si è fatto riferimento a Celati e Cavazzoni; e anche in questo caso potremmo evocare senza troppa difficoltà i Narratori delle pianure. Tuttavia proprio la fisionomia variegata del coro, che è il vero protagonista del romanzo, imprime alla lingua e alla sintassi di questa narrazione una cifra particolare e nuova; seducente. Improntato sulla oralità, il racconto di Cina non si riduce alla simulazione del parlato popolare, ma mescola con intelligenza (nel senso etimologico della scelta opportuna) le note dei cantastorie e i toni dell’aedo. Costruisce così una sorta di epos, solo apparentemente sgangherato, viceversa aderente e coerente con un ethos non codificato, silenziosamente condiviso, di cui sono espressione epiteti e formule ricorrenti, gesta eroiche e dialoghi memorabili. Più volte la voce narrante, se non ricorre esattamente a un narratore o a una narratrice di secondo grado, si cimenta con impegno a riferirne le parole, al modo più vicino possibile non tanto alla lettera, quanto alla postura di chi sembra avergliele consegnate. La necessità del ricorso alla regressione si direbbe superata dalla consapevolezza dell’essere tutti – uomini e donne, genti meccaniche e genti intellettuali, ricchi e poveri, adulti e bambini – soggetti al «destino militante» che «lancia simulacri a spaglio come semi di erba matta» (p.305) e di fronte al quale tutti – uomini, donne eccetera – avremmo il dovere di stringerci vicini e di compiere scelte utili a resistergli come si può:
Si pensa al destino come la sorte di cui l’uomo è artefice, se corre la frase, cioè come se sapessimo noi in quale punto incastrarlo. Invece il destino è già lì, dove ha deciso lui. Quello che non si capisce è come riesca a esserci, a mettere in movimento le persone, centinaia di miliardi di cose e di posti coi loro perimetri di influenza, su un pianeta che, per ingombro e rilevanza politica, è meno di un granello di sabbia in una spiaggia sterminata. (…) Viene da chiedersi cosa abbia da guadagnarci, il cosiddetto destino, a far tutto questo lavoro a orario continuato ventiquattr’ore al giorno e senza distrarsi, perché, distraendosi, rischierebbe di non compiersi: un’ipotesi solo teorica, visto che nella realtà il destino si compie sempre, per attitudine naturale. (p.206)
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento