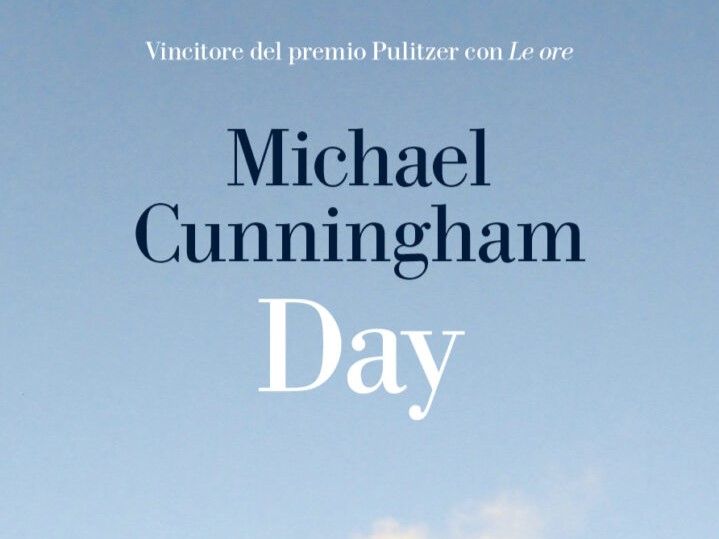
Il Day di Cunningham
Un romanzo sul tempo
Un’unica data, un solo giorno, o Day, riproposto in tre anni diversi e in tre diversi momenti della giornata, per raccontare le vite di Isabel e Dan, una coppia in crisi, e dei loro figli Nathan e Violet, all’interno di un appartamento di Brooklyn. Su queste esistenze aleggia la figura di Robbie, ribelle e affascinante fratello di Isabel che abita nella mansarda sopra l’appartamento della famiglia e capace di catalizzare le attenzioni di tutti i personaggi. Tanto da assumere un ruolo centrale nella vicenda: la sua assenza sarà infatti una delle cause della disgregazione della famiglia. («C’è, inoltre, il fatto che Robbie riesce forse ad amarli meglio di quanto loro riescano ad amarsi a vicenda. C’è il fatto che Isabel e Dan sono destinati al naufragio e al dolore dal momento stesso in cui si sono incontrati», p. 50).
Uscito in Italia per La nave di Teseo nel gennaio 2024, Day è il nuovo libro di Michael Cunningham nel quale tutto accade in un solo giorno: il 5 aprile di anni diversi. Nato e pensato durante lo scoppio della pandemia di COVID-19 (anche se nel libro non compaiono mai le parole “covid” o “pandemia”), la prima parte del romanzo racconta la mattina del 5 aprile del 2019, cioè prima della pandemia, segue il pomeriggio del 2020, quando tutto il mondo si chiude in un interminabile lockdown, e termina la sera del 2021, quando il virus, sebbene non sia cessato del tutto, sembra attenuato.
Una struttura tripartita, dunque, che ricorda l’acclamato Le ore vincitore del Premio Pulitzer nel 1999, e che ci suggerisce ancora una volta l’importanza del tema del tempo per Cunningham. Il tempo dei tre giorni e dei cambiamenti che il trascorrere dei tre anni porta con sé, soprattutto se a segnarne il passaggio è l’esperienza della pandemia, che costringe i personaggi a fare i conti con sé stessi, con il passato e con una realtà amara. La vicenda evolve infatti verso un’atmosfera sempre più cupa e malinconica, non c’è catarsi per i personaggi, e il tempo, scandito dalle loro emozioni, non sembra conoscere un’effettiva evoluzione. Fatta eccezione per qualche evento che imperversa sulle vite di questi personaggi, il tempo è quello ripetitivo della quotidianità, cadenzato dal lento trascorrere dei minuti e da situazioni che restano perlopiù sospese, perché restare, in fondo, non implica scegliere, e garantisce sempre qualche sicurezza in più.
L’importanza di Virginia Woolf
Indagando nell’interiorità dei personaggi, Cunningham mette a nudo i sentimenti, le fragilità e le frustrazioni, ma anche i sogni e il desiderio di fuggire da una quotidianità che non appaga. Pur non riuscendo a modificare le loro esistenze fino in fondo, i protagonisti di Day non offrono soluzioni definitive, eppure è proprio questa insoddisfatta normalità a renderli più reali e più vicini al lettore: come non trovare un pezzo di sé nei tentativi che ciascuno di essi compie per provarci, per scuotere quel ripetersi monotono dei giorni?
Per la sua attenzione ai dettagli del quotidiano e alla rappresentazione realistica della vita, interrogata cercando di coglierne un senso, anche quest’opera si colloca all’interno di quella tradizione modernista capace di svelare il mondo interiore dei personaggi con tutte le sue contraddizioni. D’altra parte se il senso della vita risiede nelle intermittenze dell’interiorità, chiunque può essere il soggetto di un’opera letteraria, e il ruolo dello scrittore, sembra ricordarci Cunningham, è essenzialmente quello di registrare e di documentare la vita di quelle persone che la Storia rischia di dimenticare per fare spazio ai grandi personaggi e alle grandi azioni. Anche per questo l’autore di Day ci rivela un’altra volta il suo debito con la letteratura modernista e soprattutto con l’amata Virginia Woolf.
Come in To the Lighthouse, Day ripropone una partizione del tempo in tre momenti, ma al posto della famiglia Ramsay, qui troviamo Isabel e Dan con i figli, e invece della guerra, che nella scrittura di Woolf porta via con sé vite umane lasciando tanta sofferenza, in Day c’è la pandemia a scombinare le carte e a fare crollare quell’equilibrio precario su cui è basato il rapporto tra marito e moglie. Un rapporto che sembra avere sostituito l’amore con la consuetudine, alla quale si aggiungono le frustrazioni e le incomprensioni che caratterizzano ciascuna esistenza. Per prima quella di Isabel, fotografa perennemente alla ricerca di sé, infelice del suo matrimonio e «paralizzata dal proprio egoismo e dalla propria superficialità, una donna che sa che dovrebbe amare la propria vita più di quanto ha fatto, ma che evidentemente non è mai riuscita ad amarla, la propria vita, al di là di qualche raro, trascurabile, episodio» (p. 39). Una donna che quando non lavora trova pace seduta sulle scale di casa, sul gradino di mezzo, ostinata nel non voler né scendere, né salire, perché «Ti senti né di qua né di là, quando sei seduta sulle scale» (p. 29). Accanto a Isabel scorre l’esistenza di Dan, «il bel fusto che ha sposato la ragazza energica, esteticamente appena passabile che ad altri faceva storcere il naso» (p. 119), l’ex rocker che ritenta la via del successo presso un pubblico che non sembra più riconoscerlo («È il momento, allora, di ricominciare a scrivere musica. È il momento di riappropriarsi di se stesso, anche se non dovesse andare al di là di qualche concerto in locali di secondo ordine. […] A quarant’anni non è troppo tardi. Spera che non sia troppo tardi», p. 121).
La lezione del modernismo
Le relazioni familiari e l’equilibrio precario che spesso si realizza nei nuclei affettivi, sono l’altro grande tema della narrativa di Cunningham. In Day la famiglia non funziona, l’amore tra Dan e Isabel non è sufficiente a salvarli, non riesce a metterli al riparo dalle incomprensioni, e quando Robbie lascerà la mansarda la ferita e la crepa che si è aperta nel loro matrimonio si farà irreparabile («Si arriva mai al troppo tardi? […] La frattura diventa mai irreparabile? Se sì, quando? Come fai, come fa una persona qualsiasi, a sapere quand’è che dal ci stiamo lavorando passi all’è troppo tardi? C’è forse (Isabel sospetta che debba esserci) un intermezzo durante il quale sei talmente annoiata o delusa o assediata dai rimpianti che allora, davvero, è troppo tardi? Oppure, più precisamente, arriviamo all’è troppo tardi in continuazione solo per tornare al ci stiamo lavorando prima che arrivi l’è troppo tardi, per l’ennesima volta?», p. 197). Ma Chess, la stravagante professoressa di letteratura che insieme a Ghart, fratello artista di Dan, gestisce un’insolita genitorialità per Odin, ricorda ai suoi studenti che «stanno arrivando i modernisti. Ecco profilarsi all’orizzonte scrittori che non solo ripenseranno il romanzo senza la vicenda matrimoniale come asse portante, ma rappresenteranno la donna all’interno del matrimonio. Pensate a Mrs Dalloway» (p. 105).
Sono trascorsi quasi cento anni dalle opere di Woolf, eppure si continua a indagare sui meccanismi che regolano una certa idea di famiglia e che ruotano intorno al concetto di matrimonio, «Forse un giorno ti sconvolgerà scoprire quanto sia difficile demolire la narrativa del matrimonio. Non sai, non ancora, quante vite ha quella stronza» (p. 106). La lezione del modernismo è dunque ancora estremamente attuale, e Cunningham, con l’indiscussa eleganza e puntualità della sua prosa, capace di intrecciare abilmente alla storia narrata citazioni letterarie, senza cadere nel mero citazionismo, ci parla del difficile rapporto tra marito e moglie, tra genitori e figli, ma anche della potente forza di questi legami familiari. Scava nei suoi personaggi per sviscerarli dal profondo, ma li osserva anche attraverso lo sguardo degli altri personaggi, perché la realtà, e Cunningham è uno scrittore che insegue il realismo, non può ignorare le relazioni sociali tra diverse psicologie.
Del resto «Robbie sa cosa intende quando Isabel dice di desiderare qualcosa di più grande. Conosce a menadito il suo linguaggio interiore. Qualcosa d’altro. Qualcosa di meno usuale. Qualcosa di commisurato alla propria capacità di desiderare ciò che aleggia al limite estremo del campo visivo. Un caos di affetto e bonarie litigate. Una vita domestica più complice e insieme più scalmanata. Una lampada alla finestra, stelle che il vento sballotta tra gli alberi» (p. 61)
Tra i personaggi più riusciti del romanzo senz’altro c’è la piccola Violet, con il suo vestitino giallo da principessa, scelto per lei dallo zio Robbie, perché «non vuole che lei dubiti di se stessa, si senta sminuita o metta in discussione la crescente consapevolezza di essere leggiadra, talentuosa ed elegante» (p. 207). Violet è una bambina preoccupata «che se dovesse assentarsi troppo a lungo da una stanza qualsiasi, da un avvenimento qualsiasi, il mondo finisca per dimenticarsi di lei» (p. 78), ed è sempre lì ad aspettare: resta fino in fondo «alla finestra finchè l’ombra di Robbie non è passata», e resta «davanti allo specchio a contemplare l’immagine leggermente sfocata che le restituisce, lei col vestitino giallo». Ma Violet sa, conosce, ed è capace di osservare il mondo degli adulti con sguardo critico, al punto che «si dispiace, a volte, del fatto che nessun altro riesca a vedere niente di tutto ciò, che vivano tutti in un mondo più banale e meno interessante» (p. 286). Forse ai fallimenti dei genitori sopravvivono i figli (e nella memoria sopravvive Robbie).
La capacità di restare
Day è un libro che parla della perdita, ma anche della capacità di restare. È il libro di chi resta sulle scale ascoltando il Requiem di Brahms, e «probabilmente il Requiem è per lei ciò che per Violet è l’ossessione di tenere le finestre chiuse, o per Nathan riguardare School of Rock all’infinito» (p. 182), ma è anche il libro che può indicare una possibilità per invertire la rotta.
È un libro sulla vita, che, come ci ricorda Woolf «non è una serie di lampioncini disposti simmetricamente»:
la vita è un alone luminoso, un involucro semitrasparente che ci racchiude dall’alba della coscienza fino alla fine. Non è forse compito del romanziere esprimere questo spirito mutevole, misterioso e indefinito, per quanto possa mostrarsi complesso e aberrante, con una miscela possibilmente priva di elementi esterni ed estranei? Non chiediamo solo più coraggio e sincerità, vogliamo suggerire che la materia del romanzo è un po’ diversa da quella che l’abitudine vorrebbe farci credere».
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
 Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni
Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -
 Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)
Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -
 Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza
Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -
-
La scrittura e noi
-
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
 Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett
Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini
Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -
 Perché leggere Apeirogon di Colum McCann
Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -
-
La scuola e noi
-
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
 «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere
«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -
 Contro la scuola neoliberale
Contro la scuola neoliberale -
 ”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi
”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -
-
Il presente e noi
-
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
 In memoria di Mario Palumbo
In memoria di Mario Palumbo -
 L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo
L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -
 “Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano
“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -
Commenti recenti
- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…
- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…
- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…
- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…
- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento