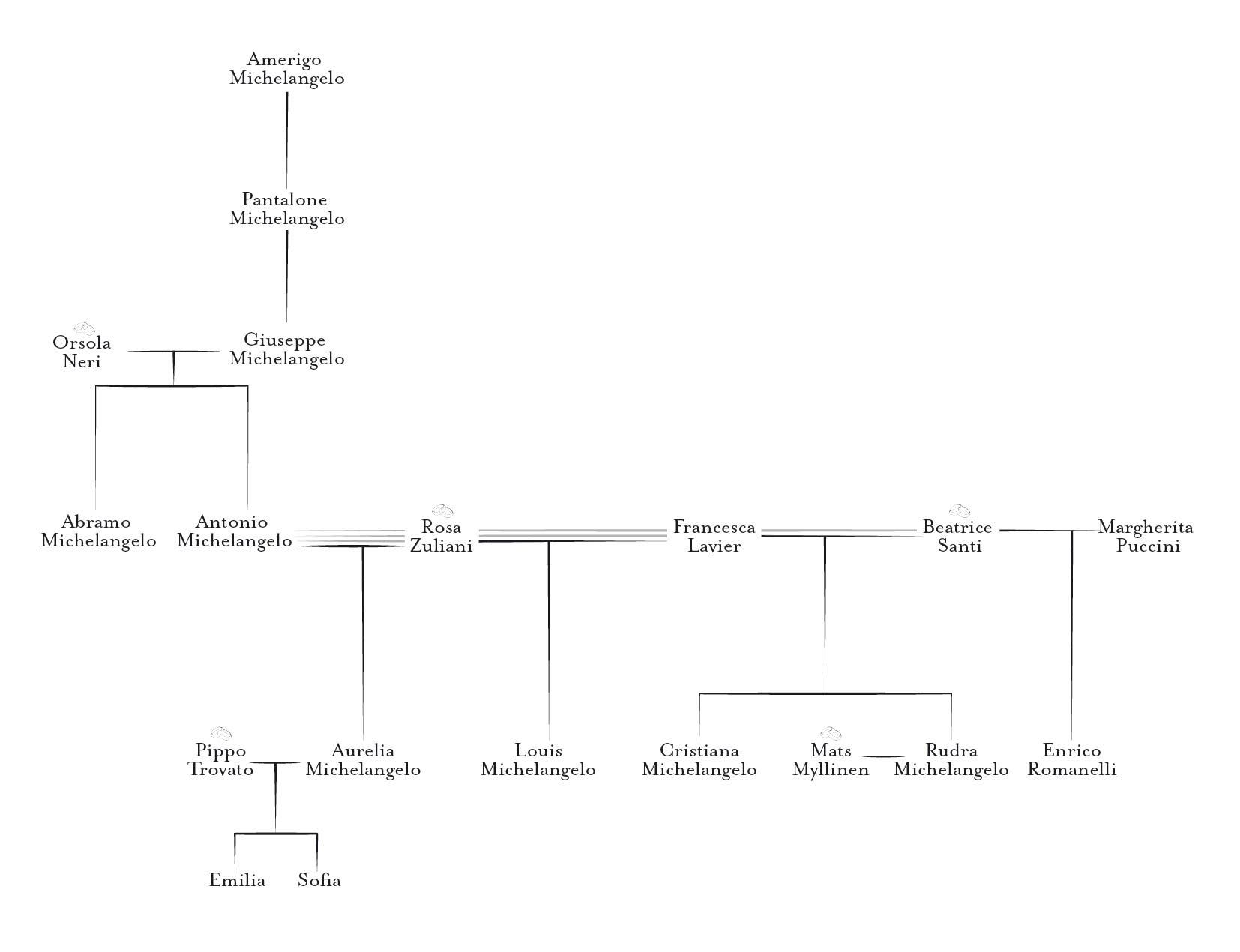
Buone vacanze! I consigli per le letture estive della nostra redazione
Cari lettori e lettrici, la redazione di LN si prende una pausa estiva per tutto il mese di agosto. Vi salutiamo con questi consigli di lettura dei nostri redattori. Durante questo mese, ripubblicheremo alcuni articoli già usciti nel corso dell’anno. Ci rivediamo a settembre.
Valentino Baldi
Col trascorrere degli anni mi accorgo che, più dei miei gusti letterari, sta mutando la mia pazienza nei confronti della letteratura. Fino ai trent’anni era raro che interrompessi un libro, lasciandolo impietosamente a metà. Adesso, sempre più spesso, lascio in sospeso pagine su pagine. La cosa mi mette di cattivo umore, ma sempre meglio della tortura di un libro mal scritto. Uno stile all’altezza e una trama scorrevole sono rarità che cerchiamo tutti, soprattutto in estate quando si fa il pieno di letture rimandate. Con questa premessa, ho pensato di segnalare una sola autrice che mi ha incantato e che vale la pena di conoscere bene. Si chiama Shirley Jackson, è un’americana di San Francisco che ha pubblicato un pugno di racconti e romanzi in una vita breve e piuttosto travagliata (1916-1965). In Italia non è molto nota, nemmeno per il suo racconto di culto del 1949 che si intitola La lotteria. Adelphi ha recentemente ripubblicato questo capolavoro che sfugge a qualsiasi definizione genere. Sono in difficoltà nel tentare di incasellare La lotteria: è un racconto perfetto, scritto in modo semplice ed elegante e scosso da un orrore che si muove sempre nel fondo. La lotteria sembra il racconto realistico di un convegno cittadino, ma è un realismo al servizio di una struttura distopica di cui il lettore si accorge progressivamente. Al centro del racconto c’è una delle costanti della narrativa della Jackson: la descrizione di una folla distruttiva, violenta e sadica. Eppure non c’è mai anarchia, ma la distruzione è al servizio di una organizzazione matematica, aspetto che rende più intollerabile l’atmosfera da incubo collettivo in cui la Jackson ci accompagna gradualmente.
Sempre Adelphi ha pubblicato Abbiamo sempre vissuto nel castello del 1962. È un’opera in cui la Jackson conferma la sua perizia stilistica, dimostrando di essere a proprio agio anche con strutture più ampie. Abbiamo sempre vissuto nel castello è la storia di Mary Catherine e Constance Blackwood, due sorelle che vivono recluse in una grossa casa con giardino ai limiti di un villaggio senza nome, abitato da personaggi evidentemente ostili alle ragazze. Il sottofondo è quello del thriller psicologico, eppure il romanzo è costruito per piccoli tocchi, con uno sguardo sempre laterale sull’evento principale: la narratrice Mary Catherine, diciottene, ci accompagna in un universo delicato e fragilissimo, quasi fiabesco. Eppure, al fondo di queste esistenze ripetitive, c’è l’orrore di un delitto avvenuto sei anni prima: la famiglia Blackwood è stata decimata a causa di un avvelenamento durante una cena, i protagonisti del romanzo sono anche gli unici sopravvissuti. L’autrice si muove dunque tra frammenti di un passato tragico e descrizioni di un presente fatto di cene, letture e piccole ritualità. Come per La lotteria, la Jackson è maestra di una tensione smorzata e martellante, che procede per accumulazione, senza fretta, con ogni pagina che diventa un gradino di una discesa negli inferi. È un romanzo sul rapporto tra individuo e comunità in cui la linea che separa la civiltà dalla violenza è sempre più sottile e frastagliata.
Linda Cavadini
Il motivo per cui ho scelto questi libri è squisitamente personale: sono i miei libri perfetti. Non i più belli, non i più validi in assoluto, ma quelli che sono stati per me perfetti, perché incontrati al momento giusto e perché mi hanno permesso di vedere il reale con altri occhi, che è poi ciò che mi aspetto da un libro. Guus Krujier con Il libro di tutte le cose (2009) realizza un falso libro per bambini: settantadue pagine piene di situazioni surreali, domande acute come lame e parole costruite e cesellate, non una di troppo. Il protagonista è Thomas, un bambino che da grande vuole essere felice, ha un padre che ha paura e per paura si rifugia in una religione opprimente e picchia, picchia forte chiunque si opponga a lui. Poi ci sono e una mamma che sorride, pur col naso gonfio, e una sorella molto meno sciocca di quello che appare. E poi c’è Gesù che appare a Thomas, un Gesù che ce l’ha con suo padre («mi ha costretto a fare cose incredibili, anche mettermi in croce, i padri non sono mai come li immaginiamo») perché è sparito dalla circolazione da troppo tempo, per colpa degli uomini. È un libro estremamente realistico e cinico.
Se la tragedia in questa famiglia è sullo sfondo e trattenuta, essa esplode con tutta la sua porta di vendetta e tragicità nella Trilogia della città di K di Agotha Kristoff (1998). Si tratta di un libro crudele e spietato, suddiviso in tre parti con voci narrati diverse (e tre traduttori diversi) in cui si tratteggia la vita e la formazione di Lucas e Klaus, due gemelli, negli anni della guerra e della ricostruzione. Una storia che non si può spiegare né raccontare, senza rischiare di svelare troppo, ma che farà sprofondare il lettore in angoscia e terrore sebbene un libro, per triste che sia, non può essere triste come una vita, come scrive Lucas nel suo diario. E’ un libro perfetto perché descrive la tragedia senza epos, come se fosse quotidianità e normalità.
La banalità del quotidiano è anche lo sfondo in cui si muove Stoner di John Williams (2012). La vita di Stoner è simile a quella di ciascuno di noi: routine, quotidianità, sliding doors che si sono aperte dalla parte sbagliata. La magia di questo libro è racchiusa tutta qui, nella straordinarietà insospettata che si cela in un’esistenza grigia e senza scosse. Ho amato molto Stoner uomo indefesso (la parola con cui lo definivano i colleghi dell’università per deriderlo e compartirlo al più) e innamorato della letteratura inglese del Due–cinquecento che vede la vita andare e non la arresta, non ci prova nemmeno.
Provano, invece, a fermare lo scorrere ingiusto della vita i due protagonisti del mio ultimo libro perfetto Non stancarti di andare (2017) della coppia Radice-Turconi. Questo non è un romanzo, questa non è una graphic novel, li è entrambi. Nur e Hassan si amano: ma c’è la guerra, la guerra in Siria che è reale e brutale. Nur è in Italia, aspetta, ricorda e ha a che fare con una madre ingombrante che la ama a modo suo (un modo assai difficile da accettare); Hassad compie il “viaggio” per tornare in Italia, terribile e spietato e che lo cambierà per sempre. Mentre attraversa a piedi il deserto, ricorda l’incontro con Padre Dall’Oglio, le sue parole, la sua utopia e la sua pace. E noi lettori, leggiamo e guardiamo con il cuore gonfio di speranza, verso quegli scarti inaspettati che solo la vita riserva.
Roberto Contu
Un classico che vorrei consigliare per quest’estate è Addio alle armi (1929). Riletto qualche mese fa con gli studenti per approfondire lo studio della rotta di Caporetto, questo romanzo, un po’ come Una questione privata o Il sentiero dei nidi di ragno, conferma che le migliori narrazioni sulla guerra avvengono quando questa è laterale alla vicenda, parallela, scansata. Nel caso di Hemingway attraverso il racconto della storia d’amore tra Frederic e Catherine il distanziamento dall’evento bellico è reiterato. Lo è perché l’approssimarsi di Caporetto e poi la fiumana disordinata della ritirata definiscono il fulcro del dispositivo narrativo, al quale si allinea il rifiuto crescente del protagonista dell’universo militare («Sono persuaso che tutta la gente che sorge a profittare della guerra e aiuta a provocarla dovrebbe essere fucilata il giorno stesso che incomincia a farlo»). Lo è per l’essere soldato straniero di Frederic di una guerra non propria, fino a sentirla come estranea, tale da fornire uno sguardo progressivamente distanziante dal conflitto sul fronte italiano che diventa scelta definitiva nella fuga verso la Svizzera. Lo è per il finale tragico e bellissimo, sconvolto dalla constatazione dell’impossibilità di sottrarsi alla vera e unica guerra già persa in partenza: quella della ricerca di una pur fragile possibilità di vita, che si infrange nella violenza di un Novecento già terribile e che avrebbe mutato di lì a a poco in tempesta la pioggia finale che vede allontanarsi il protagonista.
Un libro recente che vorrei consigliare è l’ultimo romanzo di Gianluca Barbera, Magellano (Castelvecchi 2018). Per quanto mi riguarda si tratta del coronamento di un’aspettativa covata per anni. Ogni volta che a scuola mi sono trovato a raccontare quella che mi è sempre parsa l’impresa più straordinaria e avventurosa mai compiuta dall’uomo, quella prima circumnavigazione del globo per me di gran lunga più affascinante anche della stessa conquista della luna, mi sono sempre domandato perché nessun narratore contemporaneo avesse provato a riprendersi quell’epopea. Ora quella storia esiste ed è raccontata in modo magistrale. Attraverso la voce di Juan Sebastián del Cano, «ultimo ufficiale rimasto di tutta quella gran spedizione» è possibile rivivere gli ultimi giorni prima della partenza da Siviglia, l’approssimarsi al mare aperto, le tensioni, i tentativi di ammutinamento fino ai momenti della consapevolezza respinta di un tragico fallimento. E poi le violenze a bordo, il momento epico dell’apparire del passaggio a sud-ovest, la sublime ed emozionante certezza di averlo finalmente trovato, la tragica morte di Magellano divenuto dio a se stesso, il calvario del rientro fino a rivedere il campanile della Giralda a Siviglia. Nel raccontare quella straordinaria impresa Barbera dà corpo e voce a personaggi forti e credibili, Magellano certo, ma soprattutto il protagonista che alla grande storia aggiunge il filtro del proprio conflitto personale, dei conti da regolare con i tradimenti annunciati nell’introduzione al lungo resoconto, di una storia privata portata a galla da un tempo dilatato fino allo spasmo, tra bonacce eterne e indicibili pressioni schiacciate tra i due azzurri assoluti. Grande merito di Barbera è quello di accettare la sfida dell’epica della narrazione, di scommettere su una storia grande, vera, bella, scelte a mio giudizio necessarie e imprescindibili per tentare il recupero delle nuove generazioni all’universo della letteratura, ma anche salutari per tutti coloro che chiedono alla parola la possibilità di farsi accompagnare fuori nel sole alto dei grandi racconti e non solo giù nel buio stantio dei propri e troppi io.
Daniele Lo Vetere
Forse Se una notte d’inverno un viaggiatore non è il libro migliore di Calvino. Però quel libro sull’esperienza della lettura contiene, in apertura, quella fraterna condivisione di impotenza con il lettore davanti alla mole infinita di libri che ci assalgono ogni volta che entriamo in libreria. Calvino suggeriva le sue strategie per evitare l’assedio. Io purtroppo posso solo dichiarare il criterio personale che mi muove nella scelta dei libri, perché non saprei davvero consigliare i “migliori” oggi in circolazione, né dare criteri sistematici come quelli dello scrittore. Il mio criterio è questo: mi avvicino ai libri dove spero di trovare “pensiero”, per sapere che la letteratura ancora è in grado di essere una forma di conoscenza al pari dell’economia, della sociologia, della statistica, della fisica, anzi che essa sa dirci alcune cose che nessun altra forma di sapere umano è in grado di dire. Insomma, diffido dell’eccesso di story-telling che oggi ci invade. È un criterio come un altro, naturalmente: e non applico una cauzione di finta modesta premettendolo.
Il crudo e cinico Walter Siti, in Troppi paradisi (2006), riesce a fare alcune cose straordinarie. In una civiltà in fondo pornografica come la nostra, satura di immagini violente e ipersessualizzate, riesce a imprimere alle proprie rappresentazioni, sessuali e non, un effetto di realtà che fa balzare sulla sedia. Prova ne è il fatto che ne restiamo disturbati. Fedele al suo nume tutelare Pasolini, Siti è riuscito a portare il suo «piacere di scandalizzare e di farsi scandalizzare» fin dentro i nostri anni, in cui la «mutazione antropologica» è ormai cosa fatta. Immagini, corpi, televisione, reality show: questo e altri suoi libri valgono la lettura di qualche centinaio di quegli articoli nei quali ci si interroga moralisticamente e pensosamente sul perché il Grande Fratello, e tutto quel che ne è seguito, ci piaccia così tanto.
Su un versante più saggistico e documentale, anche l’ultimo libro di Roberto Calasso, L’innominabile attuale (2017), è capace di parlare di noi svariando tra filologia, cibernetica, fisica, poesia. L’innominabile attuale è il nostro presente, sintetizzato in due figure che si richiamano paronomasticamente, il «turista»e il «terrorista»: la violenza atavica del secondo minaccia il mondo globalizzato e “pacificato” del secondo. Nella seconda parte Calasso lascia la parola a terzi: vediamo l’avvento del nazismo e il crescere dell’odio per gli ebrei nello sguardo di intellettuali, scrittori, politici di quegli anni, attraverso diari e lettere private. La Grande storia vista rasoterra. L’effetto di voluta deminutio non salva affatto dall’angoscia.
Javier Marias, con la sua Trilogia sentimentale (2010: il titolo si deve all’edizione italiana Einaudi, che comprende tre romanzi, Tutte le anime, Un cuore così bianco, Domani nella battaglia pensa a me) ha davvero il passo del grande romanziere: le storie sono semplici, ma non sono puri pretesti diegetici (un professore universitario, un uomo alla ricerca di un’immagine freudianamente “traumatica” nel proprio passato, …), e la scrittura è quella di chi si muove con perfetta naturalezza nell’andirivieni dell’anima tra passato e presente, tra eventi e loro rifrazione interiore. Come alcuni grandissimi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. (Il secondo Novecento ha, tipicamente, un altro passo. Non inferiore né superiore, naturalmente, ma diverso). Intendiamoci, Marias non è affatto un epigono, un attardato. Ma la sua musica fa sentire a casa i lettori di Tolstoj, Flaubert, Mann.
Morena Marsilio
La mia è una rosa di libri accomunati dal genere – la finzione romanzesca – e dal tema – l’infanzia e l’adolescenza, entrambe vissute come momenti della vita cruciali, spesso dolorosi e, nonostante tutto, indimenticabili nella loro specificità.
Negli undici, densi racconti di Tu, sanguinosa mia infanzia (1997, Einaudi), Michele Mari ripercorre – tra sprazzi emozionali e recuperi oggettuali (gli Urania, gli album di Cocco Bill) – gli abissi di un’età solitaria e tenebrosa. Sono pagine dall’atmosfera talvolta gotica e che preludono alla recente – e spietata – autobiografia, Leggenda privata (2017, Einaudi). Su tutti spicca “Otto scrittori” dove l’immaginario marinaresco si fonde con una serie di modelli letterari convocati a realizzare uno struggente inno ai maggiori autori di storie da “lupi di mare”.
Chi dice io in Se consideri le colpe (2007, Einaudi) di Andrea Bajani rivisita il suo passato sull’urgenza di comprendere il rapporto con la madre, morta in Romania dopo anni di lontananza. L’infanzia riaffiora durante il viaggio per le esequie e viene riguardata come il periodo delle aspettative deluse: la donna è giovane e ambiziosa e anche a distanza di anni l’io-narrante risente la gelosia e il senso di abbandono provati in passato. Eppure il ricordo dei momenti di intimità permettono al protagonista di recuperare quanto di profondo ha condiviso con la madre, rimuovendo quella presunzione di colpa cui il titolo allude.
L’adolescenza è invece l’età che viene rappresentata da due tra i più interessanti autori dell’estremo contemporaneo francese: Laurent Mauvigner e Maylis de Kerangal.
In Continuare (2018, Feltrinelli) Mauvigner affronta il tema del rapporto madre-figlio in un contesto di dissoluzione del nucleo familiare: la madre cerca di riprendere le redini del suo rapporto con un figlio diciassettenne problematico, privo di un modello maschile affidabile, pronto a seguire le sfide e le trasgressioni del branco. In risposta al fallimento della sua vita, sceglie così di portare Samuel nel Kirghizistan: sarà un viaggio da affrontare a cavallo nel cuore di una natura incontaminata; ma sarà prima di tutto un percorso nei meandri più reconditi dei protagonisti, per conoscersi vicendevolmente fuori dalle pastoie della quotidianità e per “continuare” a vivere dando un senso diverso alla propria esistenza.
Concludo, infine, con un libro di Maylis de Kerangal pubblicato solo di recente in Italia ma comparso in Francia dieci anni fa: Corniche Kennedy (2018, Feltrinelli). I personaggi che vi si fronteggiano ripropongono il tema dello scontro generazionale: da una parte bande di ragazzi che sfidano quotidianamente la morte tuffandosi dagli scogli irti, pericolosi, altissimi della Corniche Kennedy, lungo il litorale di Marsiglia; dall’altra i tutori dell’ordine che quei salti devono impedire. Con uno stile teso e vertiginoso – che mozza il fiato ad ogni tuffo e, al contempo, ne fa sentire la forza sconsideratamente vitale – l’autrice torna a proporre, come in Riparare i viventi (2015, Feltrinelli) una sorta di corsa contro il tempo e contro l’autodistruzione.
Luisa Mirone
Quest’estate, mi accosto con emozione a un intellettuale limpido e sofferto, a Vasilij Grossman e al suo Vita e destino (1980). Questo romanzo immenso, al quale unanimemente si riconosce il respiro tolstojano della narrazione corale, è attraversato da una sensibilità straordinaria del tempo e degli eventi; e non solo di quel tempo e di quegli eventi che lo generarono e che vi sono raccontati con lucidità disarmante da una pluralità di punti d’osservazione (l’invasione nazista e la controffensiva sovietica tra il 1942 e il 1943, con il triste e orrendo corollario di lager, pogrom, miserie), ma di un tempo doppio: «spazio trasparente in cui gli uomini nascono, si muovono e scompaiono senza lasciare traccia», tuttavia «il tempo confluisce nell’uomo e nel suo regno, vi si annida, e poi passa, si dilegua, ma l’uomo e il regno restano…». In questa doppiezza, c’è tragedia e romanzo, c’è romanzo e poesia, perdizione e salvezza; c’è ogni movenza della vita e del destino degli esseri umani.
Un anno raccontato in oltre 700 pagine, a fronte delle pochissime (appena più di cinquanta) che fanno Un anno di scuola (1929) di Giani Stuparich: un anno (l’ultimo del Liceo) carico di presagi per la Storia (è il 1909-1910) nel racconto teso, senza pause, di un piccolo coro di giovani voci maschili, cui si aggiunge, come un detonatore, l’unica ragazza della classe, volitiva e originale, decisa ad essere «semplicemente un compagno», eppure costretta più o meno consapevolmente proprio dai compagni «a restar donna perché vi facessi del male». Il tempo e l’anno di Grossman, e i territori della sua storia, e il coro dei suoi personaggi – tutti molteplici, dilatati, perenni; perché «ciò che è vivo, non ha copie» – da leggersi insieme al tempo, all’anno di Stuparich, e alla sua Trieste e al suo coro esiguo di studenti, meteore velocissime e per questo metafore di un dolore forse meno totale, ma ugualmente lancinante e antico. Storie corali, comunque; di un coro ancora possibile, di cui sento un bisogno struggente, oggi, qui, in quest’epoca di solitudine e folla.
Esco dalla lettura invernale dei romanzi “individualisti” di Elisabeth Strout, dov’è l’occhio attento e disincantato della protagonista – si chiami Olive Kitteridge, si chiami Lucy Barton – a ricostruire relazioni e ambienti, a preparare i giudizi. L’ho ascoltata lo scorso giugno al Tabobuk, la Strout – affabile senza molte concessioni; promuoveva il suo ultimo romanzo (Tutto è possibile, 2017). Ma, dopo il canto del coro di Grossman e Stuparich, tornerei ad Amy e Isabelle (2015) e a Mi chiamo Lucy Barton (2016), alla genesi non dell’ultimo romanzo della scrittrice, ma di tutte le nostre storie: quella del rapporto straordinario e complesso con la madre. Strout ne fa una disamina chirurgica: dallo scatenamento del conflitto (Isabelle è madre ancora giovane di Amy, un’adolescente timida eppure sua potenziale rivale per desiderio di vita e d’amore), sino alla resa dei conti fra madre e figlia, entrambe adulte, entrambe madri, entrambe mogli, entrambe malate, nel racconto solo apparentemente controllato di Lucy Barton.
Katia Trombetta
Routine, ritmi perentori, quotidianità. Quotidiane distorsioni, fake news, realtà indecifrabili. Fatti o virtualità? Parole scandalose fatte senso comune. Sempre più concrete distopie ostacolano i tuoi tentativi di comprendere e di interpretare il tuo tempo, anche te stesso, te stessa, ma più ti sforzi più ti sembra di sprecare solo energia. Se ti senti come un criceto che gira a vuoto nella gabbia di un’interpretazione che non ti offre vie d’uscita, allora intanto puoi cominciare a fermarti tu, a sospendere la tua personalissima ermeneutica. Stattene in silenzio sotto l’ombrellone e non opporre resistenza al tuo stare. Adesso che è estate e che hai più tempo non cercare di capire, di attribuire significati. Se hai bisogno di significato non è cercando ragionamenti da contrapporre alla nuova barbarie italica che lo troverai. Roma brucia nella sua decadenza, agosto è vicino e l’arderà di squallore. È così in molti altri posti, o forse è anche peggio. Che fare? Nel silenzio della resa inizia a pensare che c’è qualcosa che hai dimenticato: spazi, storie, sensazioni, amore. Non solo tu, in tanti abbiamo dimenticato, e i più forse non sapranno mai di non avere memoria. Non sei solo. C’è qualche libro, ce ne sono tanti, per iniziare di nuovo a riscoprire ciò che abbiamo perduto. Il mondo a piedi, elogio della marcia (2013) di David Le Breton, è un invito a compiere quello che oggi è diventato a tutti gli effetti un atto rivoluzionario, in un certo senso perfino politico. Il libro parte dalla constatazione di quanto questo gesto così esclusivamente umano sia stato espunto dalla società, con conseguenze gravi sulla nostra stessa capacità di comprendere la realtà, nella misura in cui risulta limitata la possibilità di farne esperienza. La sezione più corposa è dedicata al piacere del camminare, in tutte le sue declinazioni e implicazioni, in particolare agli aspetti concreti, alle difficoltà fisiche e ai cambiamenti sia nella percezione sia nella formulazione stessa dei pensieri, al modo in cui lo spazio e il tempo si ridefiniscono nella loro essenzialità, portando in superficie ciò che altrimenti non si vedrebbe. L’autore offre anche un piccolo repertorio di alcune delle prime esplorazioni estreme compiute dall’uomo e poi si sofferma sui cammini nelle città, concludendo con una sezione dedicata ai pellegrinaggi e agli itinerari spirituali. Al termine della lettura forse avrai voglia di farti un po’ viandante anche tu. Ti sentirai resistente, in qualche modo rivoluzionario, e così potrai fare qualcosa di più ardito che leggere un libro. Potrai leggere perfino delle poesie. Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore e di terra (2017) di Franco Arminio è una raccolta che condivide con il cammino il recupero di qualcosa che è andato perduto o che rischia di esserlo per sempre, un recupero che si realizza anche in questo caso attraverso la fisicità dell’esperienza. La raccolta è divisa in quattro sezioni: l’entroterra degli occhi; brevità dell’amore; poeta con famiglia; poesia al tempo della rete. Nella prima sezione ti troverai di fronte il paesaggio di quella che Arminio definisce l’«Italia interna». L’entroterra è al tempo stesso luogo da osservare e punto di osservazione, l’occhio si sofferma su ciò che è stato dimenticato, su un pezzo d’Italia che la modernità ha cancellato dalla coscienza. Eppure non si tratta di un ritorno all’antico, l’antico com’era non c’è più. Si tratta semmai di andare verso il futuro, iniziando dalla constatazione di ciò che ci è stato sottratto. L’intento, quindi, non è né elegiaco né celebrativo, ma scopertamente politico, attraverso la fisicità di versi semplici, chiari, inequivocabili, che invitano a mettere al centro della nostra esperienza sensi più acuti, una percezione che ci disseppellisca. Questa carnale consistenza caratterizza anche la sezione dedicata all’amore, dove l’altro è luogo fisico da esplorare e origine della propria riscoperta. A fare da contrappunto, anche nella sezione dedicata alla famiglia, una sorta di pacata, ironica ossessione per la morte, anche se la morte nelle poesie di Arminio ha sempre più o meno a che fare con i morti che sono stati vivi e così finisce per essere molto più vita che morte. L’ultima sezione è metapoetica: Arminio riflette sul ruolo della poesia oggi e su quelle che chiama le «nuove percezioni dell’umano». Che cosa può ancora fare la poesia oggi, se non stimolare con amore queste percezioni?
«Dare amore per me significa dare nuove visioni di noi stessi e degli altri. Darle non per cantarcela tra noi, ma per puntare a uno sfondamento, per sfondare la creazione e vedere cosa c’è dietro questa parata che chiamiamo vita».
Emanuele Zinato
Ci sono romanzi capaci di indurre nel lettore una specie particolare di tentazione, che avvertiamo oggi più preziosa perché sempre più messa al bando: quella di assumere i panni dell’altro. Prendiamo a esempio La vita davanti a sé (1975) di Romain Gary, Vergogna (1999) di J.M. Coetzee, Il responsabile delle risorse umane (2005) di Abraham Yehoshua. Per ciascuno di questi tre testi suggerirei di accettare integralmente la sfida e il rischio che la lettura comporta, non cercando certezze né consolazioni ma identificandosi viceversa con uno dei personaggi. Nel primo è Momò, un ragazzetto arabo a parlare in prima persona e a chiederci di assumere i suoi occhi e i suoi pensieri: vive all’ultimo piano di un condominio della banlieue di Belleville, accudito da Madame Rosa, una vecchia ebrea che a pagamento ospita i figli delle prostitute, il suo amico è Madame Lola, un travestito ex campione di boxe del Senegal, e le sue libere associazioni sul senso della vita sono stranianti, del tutto creaturali e niente affatto lacrimevoli. Nel secondo romanzo si assume l’interiorità problematica del capo del personale di un’azienda alimentare di Gerusalemme che s’innamora di Julia, una dipendente, migrante ucraina, solo dopo che questa perde la vita in un attentato kamikaze. Innamorato di un’ombra, il dirigente deve di intraprendere il lungo viaggio per portarne il corpo fino alla sua patria lontana: lo sfondo planetario è quello del mondo globalizzato, del lavoro precario, dell’insicurezza terroristica, eppure, non si tratta affatto di una cronaca romanzata di fatti d’attualità perché questi ultimi sono collocati in una vertiginosa dimensione epico-allegorica e antropologica (la sepoltura, l’eros e la morte). Identificarsi con il protagonista di Vergogna, David Lurie, professore universitario bianco che lavora a Città del Capo, è ancora più problematico sul piano dell’esperienza. David, come ci segnala il titolo originario Disgrace, è figura di disonore, di indecenza. Ma è anche un personaggio che si misura con la realtà dei conflitti e che muta nel corso della vicenda. All’inizio del romanzo è un cliente di una prostituta nera e seduce una studentessa perdendo il posto di lavoro. E soprattutto, all’inizio della vicenda, prima del trasferimento nella sperduta fattoria sudafricana dove lavora la figlia, è impermeabile al mondo. Verso la fine, viceversa, dopo aver patito la sconfitta e la violenza, avverte le diverse alterità irriducibili che ha davanti e dentro di sé: quella dei neri, quella della figlia, quella animale.
{module Articoli correlati}
Articoli correlati
No related posts.
-
L’interpretazione e noi
-
 Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga
Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -
 Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?
Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -
 Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda
Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -
 Nuovi doveri per il mondo in trasformazione
Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -
-
La scrittura e noi
-
 Frugare nelle tasche
Frugare nelle tasche -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta
Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -
 Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci
Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -
 Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi
Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -
-
La scuola e noi
-
 Il mito in classe
Il mito in classe -
 L’intelligenza artificiale è politica
L’intelligenza artificiale è politica -
 Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca
Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -
 “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale
“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -
-
Il presente e noi
-
 Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo
Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivo -
 L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files
L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -
 Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO
Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -
 “Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità
“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -
Commenti recenti
- massimo ferrari su Franco Battiato. Un lungo viaggio, breve e divisivoOttima recensione, sintetica com’è giusto che sia, ma preceduta da un lavoro di analisi che…
- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…
- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.
- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…
- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…
Colophon
Direttore
Romano Luperini
Redazione
Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato
Caporedattore
Roberto Contu
Editore
G.B. Palumbo Editore


Lascia un commento